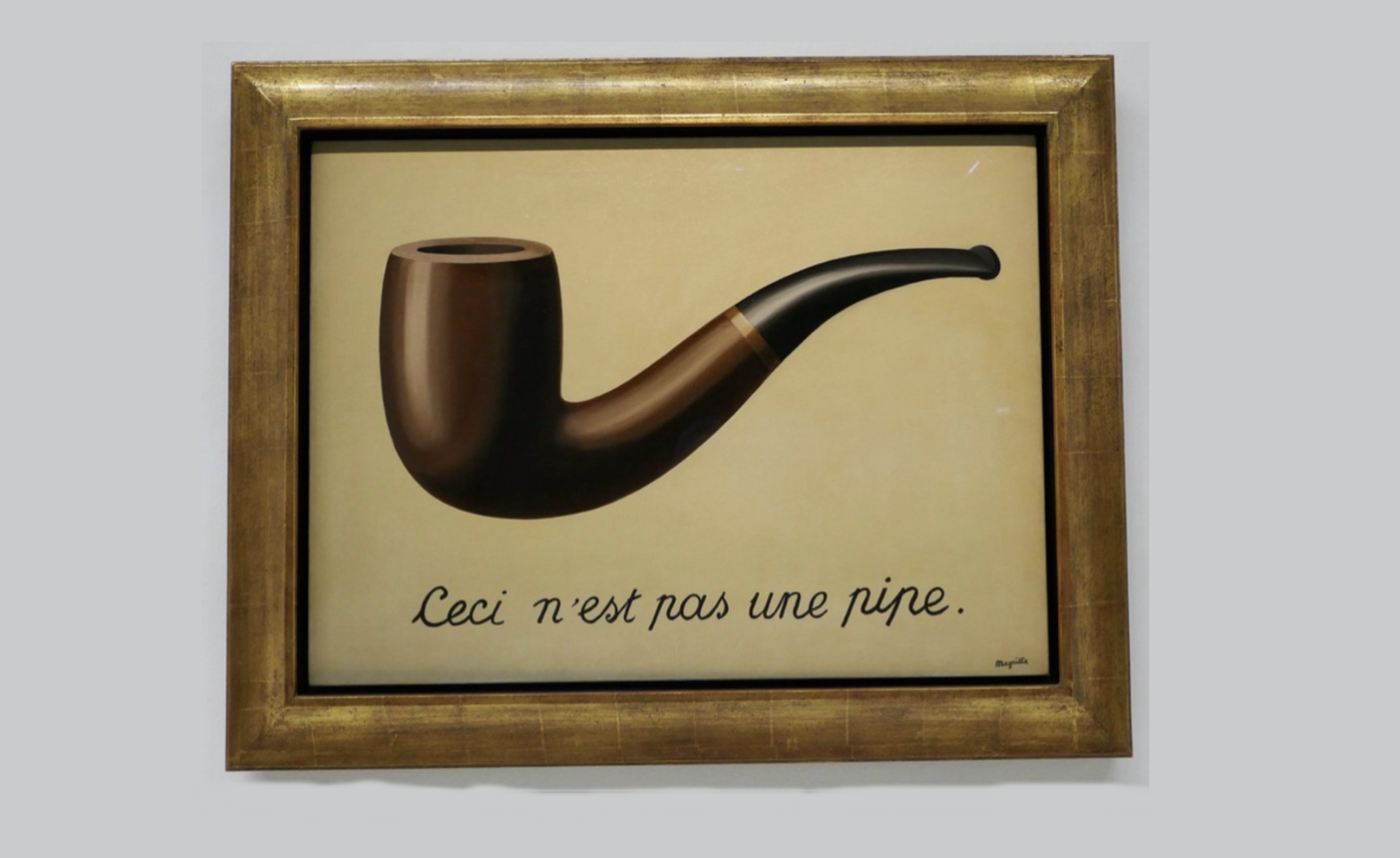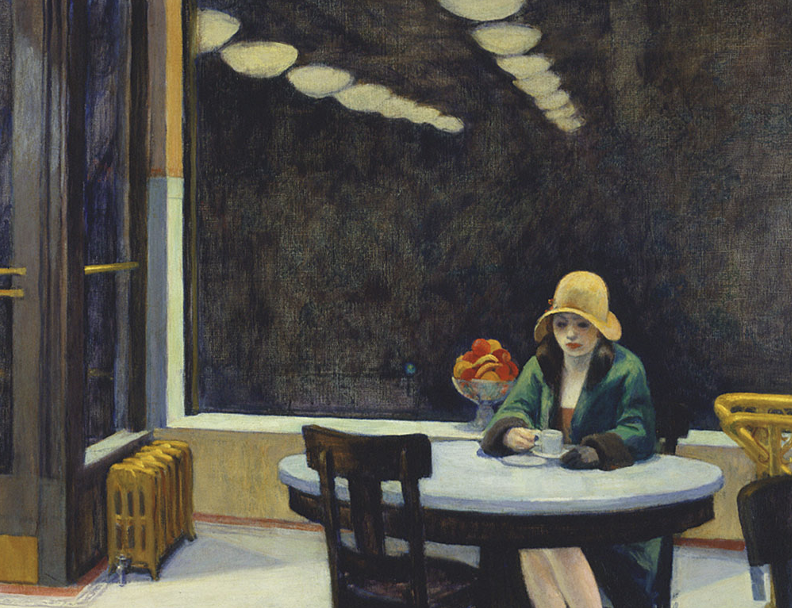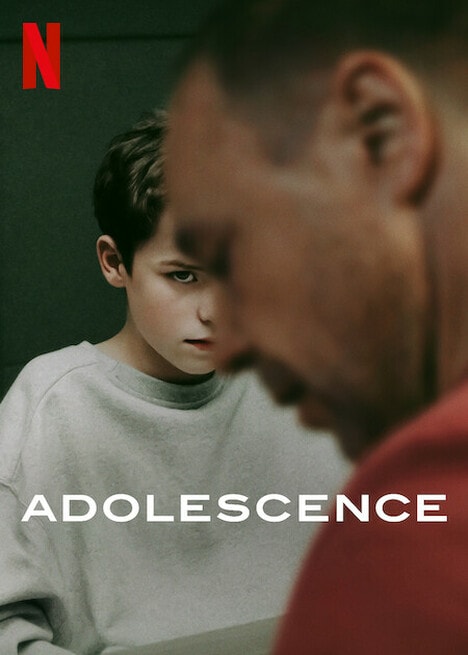Parole chiave: adolescenza, omicidio, valutazione peritale
Ugo Sabatello[1]
Con Franco Martelli e Francesca Molina mi sono trovato a lavorare su una complessa CTU civile internazionale relativa a un bambino e ho potuto apprezzare la profondità clinica e la correttezza deontologica della loro prassi. Non sono molti i Consulenti (area civile) e i Periti (area penale) che abbiano esperienza effettiva con i bambini e gli adolescenti per cui, quando ho saputo che, assieme alla dott.ssa Ceruti, hanno svolto una perizia su un caso di cronaca particolarmente efferato e enigmatico, ho chiesto al Collegio peritale se fosse disposto a rispondere ad alcune domande scritte, non tanto o non solo sul caso in particolare, ma su temi relativi alle perizie in campo minorile, area di studio poco frequentata ma che presenta una urgenza e una necessità ineludibile.
Abbiamo proposto ai Colleghi una serie di domande relative a diversi temi. Troverete in neretto le domande e in tondo le loro risposte. La biblio alla fine dell’intervista è quella segnalata da me e dalla collega Gigliotti come base per le domande.
Ringrazio, quindi, i Colleghi[2] che hanno accettato di condividere con Spiweb le loro riflessioni.
I Colleghi del Collegio così definiscono il fatto:
“G. ha ucciso la sua famiglia (padre, madre e il fratello minore) con molte coltellate poco prima di compiere 18 anni. Era il gioiello di famiglia perché premuroso, rispettoso e tranquillo. Era stimato a scuola perché ritenuto un ragazzo modello, esempio per i compagni. Frequentava amici, ma fantasticava una vita solitaria e senza legami affettivi in cui cercare la strada di un mondo nuovo per sè.
Metodologia adottata
1. Secondo Kernberg, l’integrazione di test psicodiagnostici e colloqui clinici permette di cogliere con maggiore precisione la complessità della personalità (Kernberg, 1984). Quali strumenti psicodiagnostici avete selezionato nella Vostra valutazione peritale e perché li avete ritenuti specificamente adatti al caso di R. C.?
2. Chabert (2008) ha evidenziato il valore delle tecniche proiettive per esplorare i vissuti profondi, spesso inconsci, del soggetto. Avete utilizzato tecniche proiettive nel Vostro lavoro peritale? Se sì, con quale obiettivo specifico e quali risultati hanno prodotto nel caso di R?
L’utilizzo di specifici test psicodiagnostici consente di approfondire i risultati dei colloqui clinici che, in ogni caso, restano il principale punto di repere della valutazione e, conseguentemente, della diagnosi.
Si tratta, effettivamente, di una integrazione che consente di cogliere aspetti che possono sfuggire al colloquio clinico ma dirimenti per la comprensione del dinamismo intrapsichico.
Nel caso analizzato sono stati utilizzati i seguenti test: Rorschach R-PAS; MMPI-A; C.W.S. Crisi Wartegg System; Blacky Pictures; GSS 1 Gisli H. Gudjonsson.
Il Rorschach con la metodologia R-Pas, che è oggi la più accreditata, e il questionario MMPI A sono i test più utilizzati e consentono di ottenere un profilo di personalità che integra aspetti cognitivi e componenti proiettive. La forma R-Pas permette anche una valutazione statistica rapportata al campione di riferimento e, per questa ragione, consente di collocare il paziente all’interno di un range socialmente significativo.
Alla fotografia di personalità ottenuta con il Rorschach R-PAS si è affiancata l’interpretazione dinamica del Wartegg, attraverso gli stimoli evocativi, per intravedere l’eco dell’arcaica formazione dei tratti personologici. Ciò è parso necessario per esaminare la componente alessitimica ben chiara nei colloqui clinici.
La compressione emotiva, controllata difensivamente dalla razionalità, si allenta alla richiesta creativa insita nel test Wartegg che, nel caso R.C., al primo riquadro, dà testimonianza delle ferite dell’Io e, nei riquadri 6 e 8, del tentativo di riparazione.
Pur non essendo test utilizzato in ambito penale, si è aggiunto il Blacky Pictures proprio per la sua potenza proiettiva arcaica che consente di apprezzare il modello di attaccamento e i passaggi di separazione/individuazione del paziente.
Quest’ultimo è stato il test più attivante per R. C. tanto da elicitare una breccia nella corazza alessitimica, breccia atta ad intravedere l’enorme sofferenza legata ad un deficit identitario particolarmente grave.
L’utilizzo di tutti i test proiettivi ha valore non solo diagnostico ma anche prognostico poiché, in questo caso, indirizza il futuro lavoro analitico alla componente controtransferale che, unica, potrebbe consentire a R. C. di esperimentare un nuovo processo empatico e quindi un attaccamento acquisito.
La risonanza controtransferale durante l’esecuzione dei test citati è stata intensa e, con ogni probabilità, ha elicitato dinamismi psichici biunivoci.
La scelta del GSS 1 è dovuta a richiesta specifica insita nel Quesito peritale e riferita alla suggestionabilità di R.C.
Si è attenzionato anche il momento della somministrazione testale, posto tra i primi colloqui e l’ultimo incontro clinico, in cui si è cercato di utilizzare i risultati ottenuti in visione prospettica.
3. Steiner (1993) evidenzia che le difese psicologiche degli adolescenti sono spesso meno consolidate e più flessibili rispetto agli adulti. Ha notato questo elemento nella perizia di R.C. e in che modo ciò ha influenzato il ragionamento diagnostico da lei seguito?
La principale difesa di R.C. è la razionalizzazione, quale sistema organizzato per opporsi all’emotivo.
È la razionalizzazione, agita attraverso simboli quali l’AI e gli studi di genetica, a rappresentare il punto di passaggio, quasi una “dogana” ove la tassa è la perdita di parti del Sé, tra elementi nevrotici della personalità che tentano di padroneggiare il reale ed elementi di fantasia, dinamicamente attratti dallo psicoticismo, che tentano di riparare l’Io ferito di R.C.
Le fantasie diventano rilevanti quando la realtà è vissuta come troppo pericolosa o ci si sente troppo impotenti, per cui rifugiarsi in un mondo di fantasia aumenta il senso di sicurezza. Tale rifugio, come sostenuto da Steiner, è un luogo di sospensione che procura sollievo da angoscia e dolore. La sua funzione è sostanzialmente difendersi dalla depressione incipiente.
C’è in R.C. una continua oscillazione tra introiezione e proiezione, tanto che l’identificazione proiettiva, sua ulteriore e più arcaica difesa, si fa flessibile in una coesistenza di parti in evoluzione psicotica, le fantasie originarie, e non psicotiche che hanno obiettivi in antagonismo.
Bion, in Differenziazione fra le personalità psicotiche e non psicotiche (1967), dichiara: la personalità non psicotica aveva a che fare con un problema nevrotico, cioè un problema centrato sulla risoluzione di un conflitto tra le idee e le emozioni che avevano avuto origine nell’azione dell’Io. Ma la personalità psicotica aveva a che fare con il problema di riparare l’Io.
La coesistenza di queste componenti e, soprattutto, il loro fluire nella relazione ha reso via via più chiara la condizione clinica di R.C.
È l’oscillazione a rendere le difese meno rigide, aprendo varchi al lavoro analitico. In R.C. le fantasie non hanno ancora granitica struttura psicotica, sono lasse, dinamiche e permettono ingresso/uscita dal “rifugio della mente”. La parti del Sé scisse e proiettate si muovono quale angoscia libera nella dinamica relazionale e hanno necessità di essere contenute.
I vissuti controtransferali e una approfondita analisi testale, hanno consentito una riflessione su due concetti fondanti la comprensione della vita psichica nel periodo neonatale: l’autismo normale (Mahler) e il narcisismo primario (Freud), ovvero quell’amore di sé, costituito da un totale coinvolgimento in se stesso, che nel neonato precede necessariamente la capacità di amare gli altri.
Le narrazioni sull’infanzia di R.C. hanno portato alla convinzione che sia esistito un difetto strutturale nel rispecchiamento diadico e quindi nella costruzione stessa del narcisismo primario e dell’intero apparato difensivo.
Freud considerava l’amore di sé come evolutivamente primario rispetto alla capacità relazionale (amore anaclitico) e sede dei primitivi sentimenti di “bontà”. Immaginava che perdurasse sotto forma di “Io ideale” e nel narcisismo dell’amore genitoriale, che rende il figlio speciale e unico, tanto da sostenere che l’amore parentale, così commovente e in fondo così infantile, non è altro che il narcisismo dei genitori tornato a nuova vita (Freud 1914)
Se le risorse controtransferali dell’analista riusciranno nella cura del narcisismo primario ferito e a contenere i frammenti di angoscia proiettata, questi diverranno tollerabili e, a seguire, bonificabili in un rinnovato rispecchiamento.
Aspetti controtransferali
4. Secondo Heimann (1950), il controtransfert non è più da considerarsi solo un ostacolo, ma una risorsa nella relazione clinica. In ambito peritale, dove è richiesta una postura più neutrale, come avete gestito la tensione tra il coinvolgimento emotivo e l’esigenza di oggettività?
5. Come afferma Ferro (1999), la mente dell’analista può diventare ‘campo di rappresentazione’ dei contenuti non mentalizzati del paziente. Quali immagini, sogni o fantasie si sono attivati in Voi? Quali ritenete che possano aver avuto valore nella comprensione profonda del mondo interno di R.?
6. Ogden (1994) parla di “campo analitico intersoggettivo” come spazio condiviso tra paziente e analista. Anche in un contesto peritale, avete avuto la sensazione che si stesse costruendo un campo emotivo condiviso con Riccardo? Se sì, come si è lavorato su ciò che questo campo vi restituiva?
Durante il percorso di osservazione clinico-diagnostica condotta su R, è emersa una significativa difficoltà nell’accesso diretto ai contenuti affettivi, sia sul piano verbale che comportamentale per la presenza di una corazza alessitimica che impediva la connessione con il suo mondo interno. L’assetto psicologico di Riccardo ha reso complesso l’utilizzo delle tradizionali tecniche di valutazione, sia a livello anamnestico che testistico. In particolare i protocolli proiettivi hanno evidenziato una notevole difesa nei confronti della simbolizzazione affettiva e una generale difficoltà nel produrre una narrazione emotivamente colorita, ad eccezione del Blachy, che ha generato una falla in uno scudo protettivo così ben strutturato. Anche il colloquio clinico, pur condotto in un setting analitico non giudicante, ha rilevato la presenza di un’organizzazione difensiva orientata alla gestione cognitiva dell’esperienza, senza accesso a una dimensione affettiva autentica. Il tono appiattito, la mimica scarna e la tendenza alla razionalizzazione osservati in Riccardo stridevano però con l’intensa sollecitazione controtransferale percepita all’unisono, seppur con differente declinazione, da tutto il collegio peritale. Questa profonda attivazione emotiva si è tradotta in una sottile forma di angoscia legata al senso di vuoto avvertito nel setting. Analizzando le risonanze generate dal campo transferale è stato così possibile sintonizzarsi emotivamente con gli affetti scissi di Riccardo. Le emozioni, i pensieri, le fantasie dei periti hanno assunto la forma di indicatori delle dinamiche proiettive e delle identificazioni inconsce che R. ha mobilitato all’interno della relazione transferale. Le reazioni controtransferali sono state costantemente condivise e analizzate in numerosi momenti di confronto che hanno consentito di bonificare il campo analitico da possibili contaminazioni soggettive in favore di una visione globale univoca che ha reso pensabile o perlomeno percepibile ciò che fino a quel momento appariva inaccessibile e confuso. Questa operazione ha consentito di dare una forma agli affetti dissociati di R., attraverso l’accoglienza empatica e il contenimento delle pulsioni che governavano il suo mondo interno. E’ stato proprio nel corpo e nella psiche dei periti che tali affetti hanno trovato una prima possibilità di rappresentazione, offrendo a R. l’esperienza di essere pensato. Così come la madre accoglie, elabora e restituisce in forma accessibile gli stati emotivi grezzi del suo bambino, nel setting peritale si è ricreata un’analoga esperienza di “reverie” che ha permesso ai consulenti, divenuti specchio emotivo del periziando, di tenere dentro di sé le angosce proiettate da R., metabolizzarle e renderle così più pensabili e comprensibili. In questo processo, l’identificazione proiettiva originariamente agita si è trasformata in uno scambio relazionale significativo, capace di dare senso e significato a emozioni nebulose e inaccessibili.
R. ha manifestato sin dalle fasi iniziali della valutazione una marcata difficoltà nell’accesso e nella modulazione degli stati affettivi. Le emozioni, non espresse verbalmente né rappresentate sul piano riflessivo, sono apparse come segnali corporei disorganizzati, agiti relazionali ambigui e posture comunicative difensive. Tali elementi sono stati letti come espressione di un funzionamento psichico segnato da scissioni interne, in cui emozioni intollerabili sono state espulse dalla coscienza e mantenute in una condizione di dissociazione affettiva. E’ stato grazie alla funzione trasformativa della reverie che i periti hanno potuto accogliere tali proiezioni, avvertite inizialmente sottoforma di stati controtransferali non elaborati, ansia diffusa, confusione mentale e successivamente sottoposti a un processo di pensiero e simbolizzazione. Questo processo non ha avuto luogo su un piano esclusivamente cognitivo ma ha coinvolto l’intera disponibilità recettiva dell’apparato psichico dei periti, che si sono offerti come contenitori di affetti grezzi trasformandoli in contenuti psichici. La reverie ha dunque reso possibile il passaggio da un’esperienza emotiva caotica e frammentata a una narrazione interna coerente, attraverso un rispecchiamento empatico che ha generato un primo ancoraggio simbolico permettendo la reintegrazione, nella mente del perito, degli stati affettivi scissi del periziando. Tale dinamica evidenzia come, anche in un contesto valutativo e non terapeutico, la qualità della relazione e la capacità del perito di svolgere una funzione riflessiva e contenitiva possano incidere significativamente sulla possibilità di accesso a contenuti psichici profondi e clinicamente rilevanti.
Nel percorso valutativo, è emersa in maniera evidente la carenza di un’esperienza precoce di contenimento e rispecchiamento emotivo, riconducibile a un attaccamento primario non sufficientemente sicuro.
Grazie alla formazione clinico-dinamica dei membri del collegio è stato possibile riconoscere, utilizzare ed integrare i contenuti controtransferali come indicatore diagnostico.
E’ stata proprio l’analisi del controtransfert a facilitare l’avanzamento della formulazione diagnostica consentendo di ipotizzare la presenza in Riccardo di contenuti emotivi profondamente dissociati ma comunque attivi a livello relazionale. Se ci fossimo basati su una valutazione psichiatrica sterile e pragmatica, considerando solo ciò che era visibile, avremmo colluso con le difese di Riccardo stigmatizzando il suo comportamento come costrutto antisociale, perdendo il focus etiopatogenetico in favore di una rigida e categoriale classificazione nosografica. L’utilizzo consapevole e metodologicamente controllato di questi dati controtransferali ha rappresentato una via d’accesso alternativa, ma clinicamente fondata, alla dimensione affettiva del periziando consentendoci di formulare l’ipotesi di un funzionamento alessitimico che, diversamente, avremmo potuto confondere come la cinica e spregiudicata indifferenza del narcisista maligno. E’ importante sottolineare come tale approccio non rappresenti una scorciatoia interpretativa ma un’applicazione rigorosa dei modelli relazionali della prospettiva psicodiagnostica moderna in cui il controtransfert è concepito come una componente intersoggettiva del campo terapeutico e valutativo, espressione della co-costruzione dell’incontro clinico tra soggetto esaminato e perito/terapeuta.
Tipo di ragionamento effettuato per giungere alle conclusioni
7. Secondo quanto afferma Hinshelwood (2014), ogni valutazione clinica presenta momenti chiave che orientano significativamente le conclusioni del professionista. Potreste indicarci uno o due momenti particolarmente rilevanti che hanno rappresentato per voi una svolta nel ragionamento peritale sul caso C?
I ‘momenti’ speciali della perizia.
Nell’intervista peritale può essere difficile sottrarsi alla vis investigandi.
Questo atteggiamento dispone ad un esercizio attivo che è orientato ad esplorare un terreno, a sollevare zolle e a guardare dentro: verbi convessi che intendono afferrare una concavità.
Così si ritagliano i tasselli che il faro peritale illumina e che dispone nel mosaico del ragionamento.
Il ‘momento’ speciale arriva, invece, quando l’’occhio peritale’ arretra e si lascia colpire dalla concavità dell’altro.
Può essere una concavità che sgorga luce, o una concavità opaca, o una concavità muta.
Nel caso di R. il ‘momento’ è arrivato, quando, nella ‘distrazione’ cercata dell’orecchio peritale, egli ha consegnato inconsapevolmente se stesso, il bambino umiliato che è stato, collocando quel bambino sulla superficie atona della sua opaca levigatezza emotiva: esperienze di afasica umiliazione che rendono afasica la mente.
Il riflesso di quella opacità ha illuminato le radici psichiche di R.
Lì si è trovata una chiave che ha aperto più di una porta.
La porta, anzitutto, che ha dato accesso alla diagnosi primaria – sul versante psichiatrico e sul versante psicodianamico – di ‘alessitimia’. Ha dato ragione al costrutto diagnostico psichiatrico che era chiamato ad una definizione dalla irrilevanza emotiva delle esternazioni razionalizzanti di R.
Ha dato accesso alle trame, sconosciute a R., della sua interiorità, mancante dell’esperienza fondativa della risonanza emotiva che attiva la relazione con l’altro e l’esperienza di sé.
Ha dato accesso alle radici di più di una fantasia di R.
Quella della vita immateriale, privata della materia delle emozioni affettive e raggiunta in una solitudine governata dai robot, e quella della eliminazione fisica degli autori, i genitori, di emozioni primarie non decodificate.
Il corpo di R. ha illuminato la scena peritale con la sua opaca immobilità.
E’ stato, anch’esso, il ‘momento’ speciale che si è lasciato prendere senza cercarlo.
E’ stato il ‘visibile’, quasi toccabile riflesso dell’opacità delle sue emozioni di bambino umiliato.
Qui corpo e psiche si sono congiunti.
Questa congiunzione semiologica ha dato spazio alla parola peritale della ‘dissociazione’ e della ‘schizoidia’.
‘L’Io diviso’, Laing: “L’individuo ‘normale’ entra in una condizione schizoide nel tentativo di sfuggire, se non fisicamente, almeno mentalmente ad una situazione il cui carattere di pericolosità per il suo essere non offre nessuna via di uscita reale: egli diventa allora una specie di osservatore, distaccato e impassibile, a ciò che il suo corpo sta facendo o che ad esso viene fatto”.
Alla parola ‘corpo’ si potrebbe assegnare, nel caso di R., il valore sintomatico di corpo dissociato e di corpo che uccide.
L’ultima porta dà accesso alla possibile terapia attraverso la mobilizzazione controllata e controtransferale delle emozioni, vivissimamente sollevate nei periti, del terapeuta.
Ha costituito un esercizio mentale di tutto rilievo proteggere la sintonia clinica con i ‘momenti’ speciali di R. dalle variazioni comunicative e relazionali del ‘setting’ peritale per sua condizione multivocale. La diversità dei registri comunicativi, emergente dalla diversa direzionalità delle parti processuali e dalla difformità delle risonanze controtransferali, ha evidenziato la scomposizione, financo la ‘scompostezza’, dell’atto peritale che, in radice, riceve, invece, un mandato clinico privilegiato.
E’ emerso nei periti il pensiero che il ‘corpo’ del perito, contenente lo svolgersi della relazione controtransferale con il ‘corpo’ del periziando, abbia a poter ‘agire’ nella continuità dell’interazione clinica, venendo metodologicamente posposte, nel tempo peritale, le ‘battute’ delle ‘parti’ in gioco.
Francesca Molina Raffaella Ceruti Franco Martelli
23.6.2025
Affido ai Colleghi che leggeranno eventuali commenti. Il Collegio peritale ha dato una sua propria lettura di un atto omicida apparentemente senza senso e senza concrete finalità, sollevando complessi problemi di metodologia, valutazione peritale, assetto interno di chi si presta alla attività forense.
La Corte giudicante ha poi svolto il suo compito da un punto di vista molto diverso da quello dei periti. Con i Periti condividiamo la posizione propria della psicoanalisi riassunta nelle parole di Stanley Ruszczynski:
“ Forse il valore fondamentale dell’approccio psicoanalitico è che si tiene ancorato all’ide che l’atto violento ha un significato che potrebbe non essere mai conosciuto appieno, e allo stesso tempo riconosce il valore che la curiosità e l’interesse per quel possibile significato potrebbero avere nel dare inizio a un cambiamento nella relazione tra l’autore e le sue azioni”.
Dopo la definizione di questa intervista vengo a sapere dai giornali che il ragazzo è stato condannato al massimo della pena, 20 anni di detenzione e che la Corte lo ha ritenuto pertanto imputabile.
Nel pieno rispetto per le valutazioni della Magistratura, resto comunque sorpreso e mi chiedo quale sia il senso di una simile condanna per un ragazzo chiaramente patologico, cosa significhino 20 anni di carcere, che assistenza potrà mai avere all’interno, sia pure, di un IPM (Istituto Penale Minorile)e, infine, come questo possa coincidere con il mandato e le finalità del Codice Penale Minorile.
Dovremo attendere le motivazioni per avere una qualche risposta.
Ugo Sabatello
Bibliografia
Chabert, C. (2008). Il Rorschach in clinica adulta. Interpretazione psicoanalitica. Milano: Raffaello Cortina Editore.
Ferro, A. (1999). La tecnica nella psicoanalisi. Tra apprendere dall’esperienza e costruzione del campo analitico. Torino: Bollati Boringhieri.
Heimann, P. (1950). “On counter-transference”. The International Journal of Psychoanalysis, 31, 81–84.
Hinshelwood, R.D. (2014). Ricerca sul processo psicoanalitico: Teoria e metodo clinico. Milano: FrancoAngeli.
Kernberg, O.F. (1984). Disturbi gravi della personalità. Torino: Boringhieri.
Ogden, T.H. (1994). Soggetto dell’inconscio, soggetto dell’esperienza. Torino: Bollati Boringhieri.
Steiner, J. (1993). I rifugi della mente. Torino: Bollati Boringhieri.
[1] Intervista elaborata assieme alla dott.ssa Federica Gigliotti (NPI- Psicoterapeuta)
[2] Raffaella Ceruti laurea in medicina e chirurgia. Specializzazione in neuropsichiatria infantile. Psicoterapeuta ad indirizzo psicodinamico. CTU, CTP.
Francesca Molina
laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Psicologia Medica; Neuropsichiatra Infantile; Psicoterapeuta e Analista della Società Italiana di Psicologia Individuale. Docente della Scuola di Psicoterapia Adleriana del CRIFU di Milano e Delegato della Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia. CTU e Perito.
Franco Martelli
Medico chirurgo, specialista in Psichiatria e in Criminologia clinica, Psicoterapeuta.