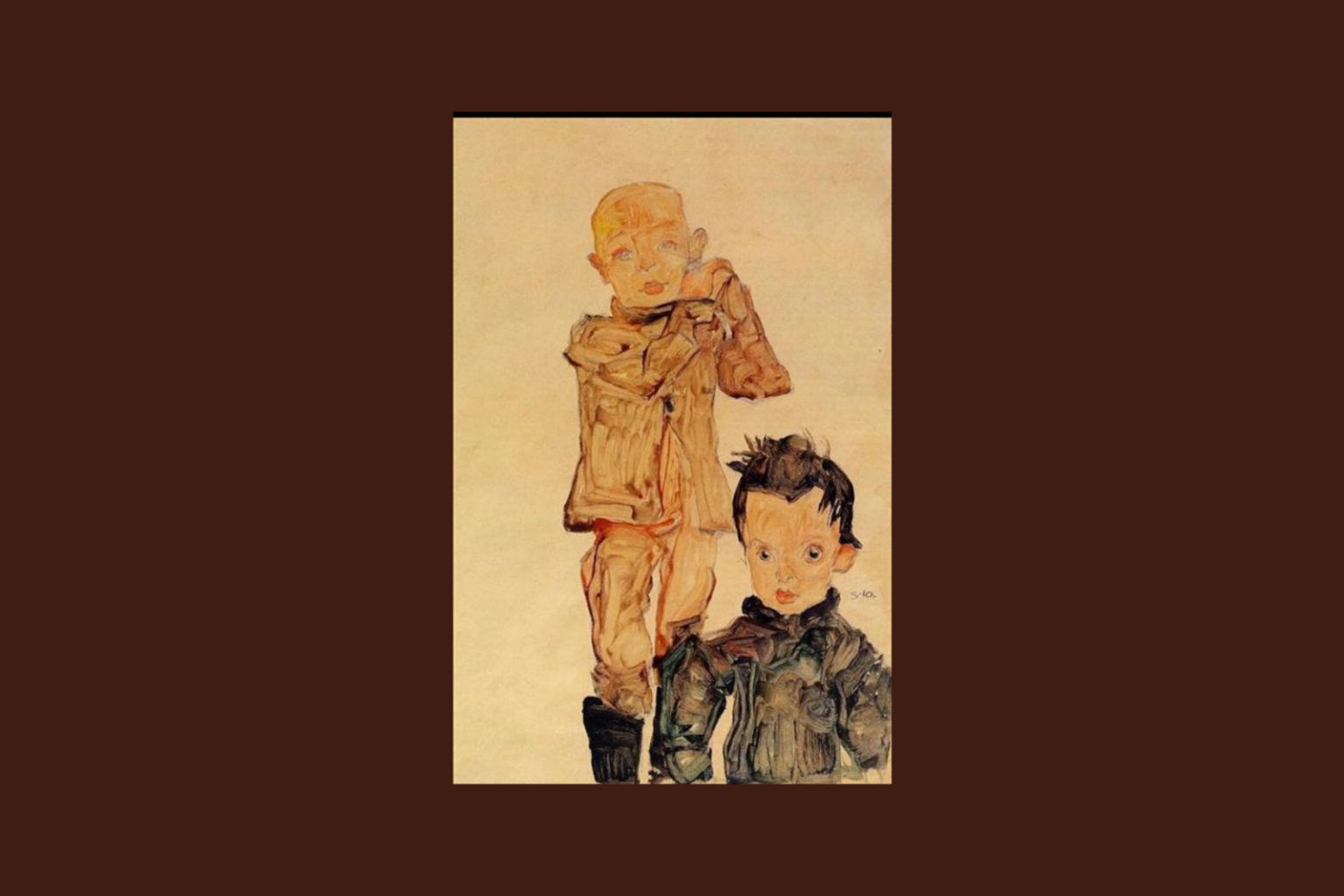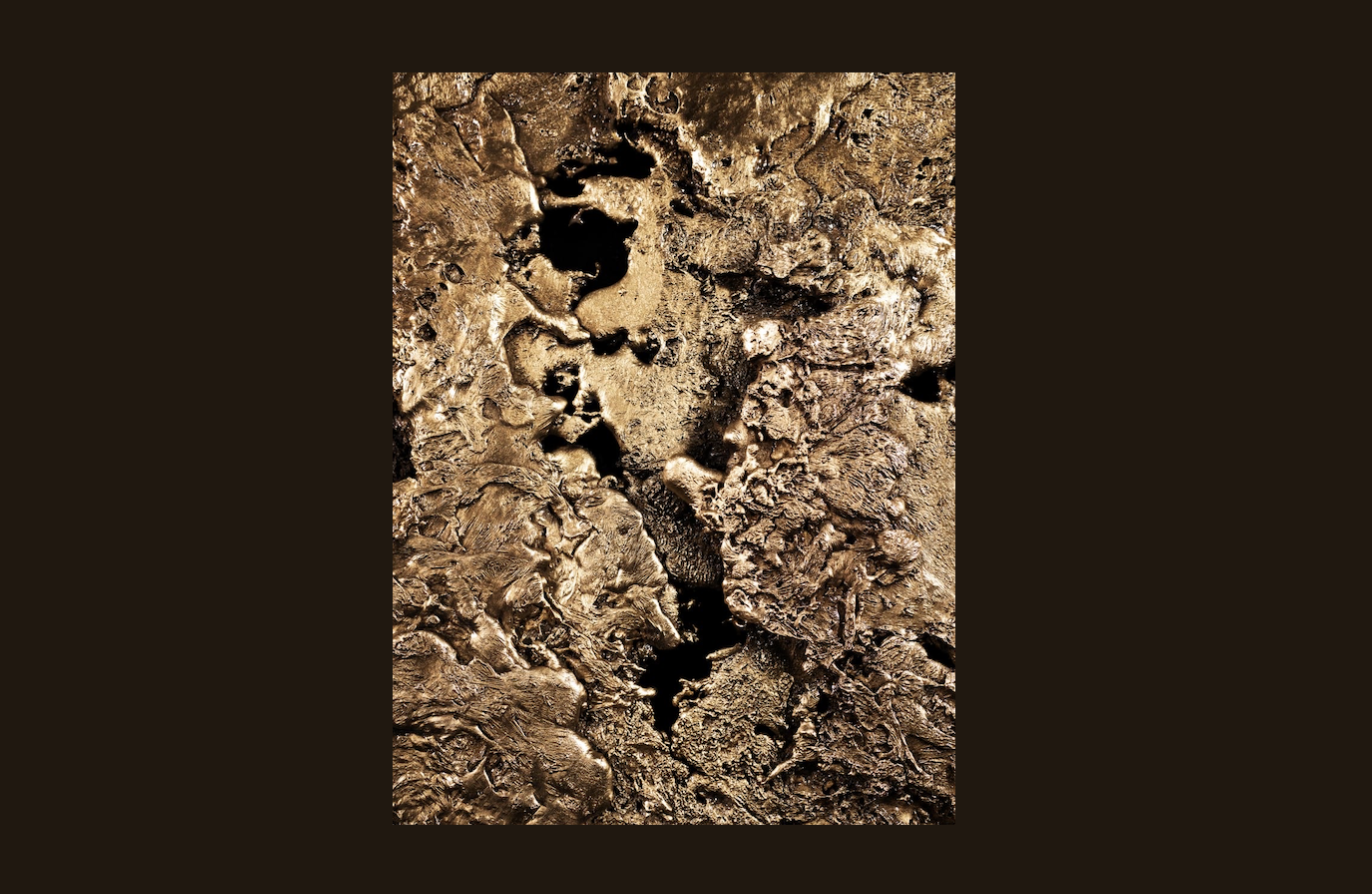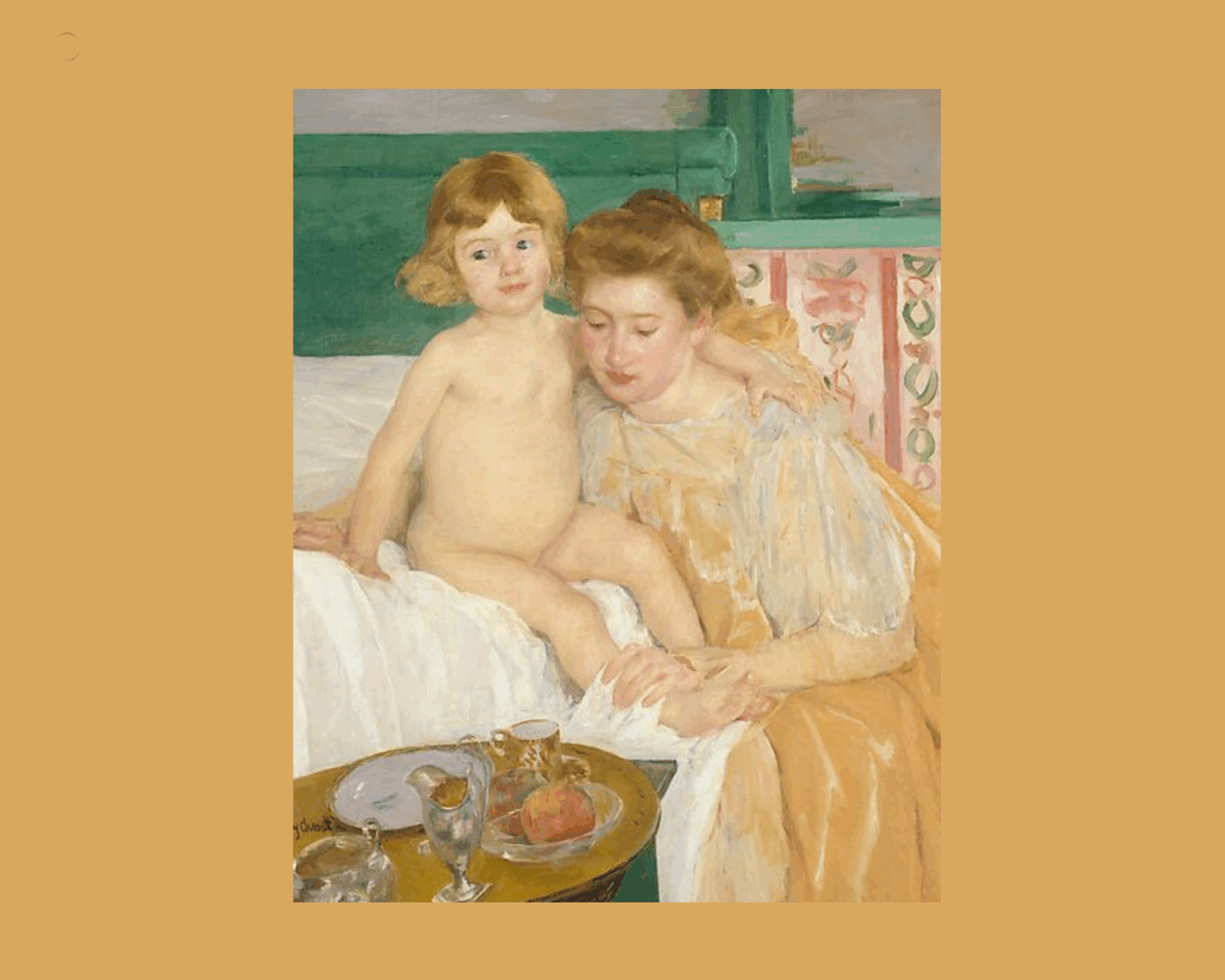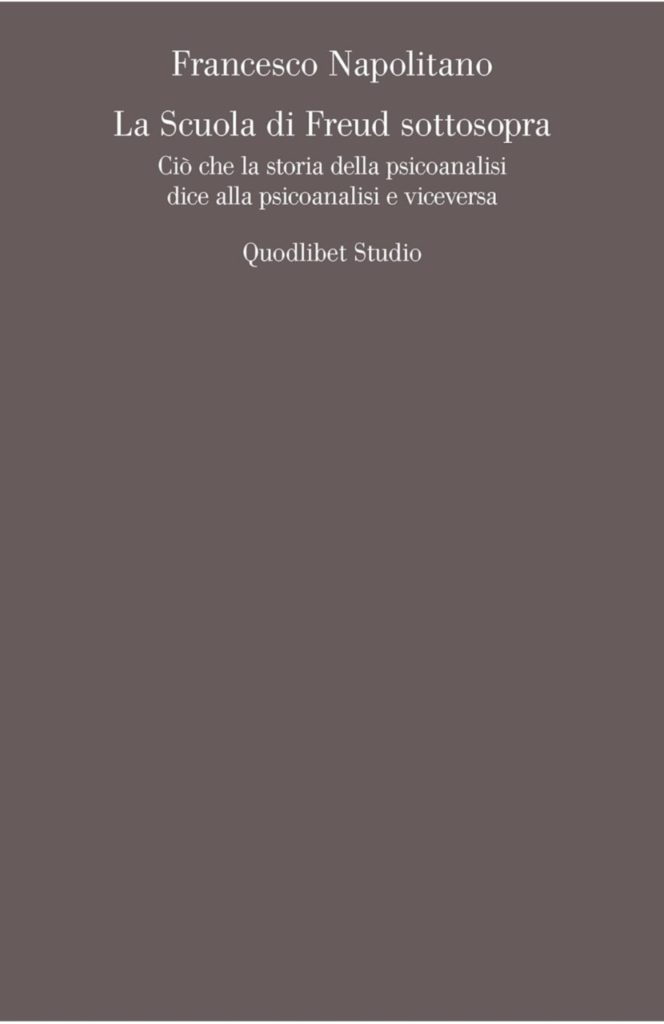Parole chiave: fantasma di castrazione, Joyce Mcdougall, psicosomatica, comportamenti compulsivi, lavoro psichico
Gli argomenti trattati da Roberto Musella in questo lavoro ci conducono, oltre che nel terreno classicamente Freudiano, anche verso pensieri sviluppati nel tempo inerenti quel che si può dire l’embodiment, cioè un modo diverso e profondo di intendere la “psicosomatica”. L’embodiment della fenomenologia e filosofia (Merleau-Ponty) e delle attuali neuroscienze (Gallese), dove la constanzialità di corpo e psiche è proposta come produttrice delle azioni senso-motorie in un’unione di stampo post-cartesiano. In questo quadro propone l’uso del corpo con le cicatrici in lui inscritte, per allontanarsi, anzi evitare il lavoro psichico intollerabile.
Buona lettura.
Fausta Cuneo
Roberto Musella
“L’iscrizione somatica del fantasma”
Nel 2002, Joyce McDougall tenne a Napoli una conferenza dal titolo “L’economia psichica della dipendenza: una soluzione psicosomatica”. In quel contributo, pubblicato nel volume “Stati caotici della mente” a cura di L. Rinaldi (2003), McDougall proponeva una lettura delle dipendenze – da sostanze o da agiti compulsivi – come soluzioni corporee ad un sovraccarico affettivo.
Secondo la McDougall, l’uso di sostanze, così come comportamenti patologici e compulsivi come la bulimia, l’anoressia, l’autolesionismo, ecc… hanno una funzione specifica: tenere lontano l’affetto quando questo entra in conflitto con il resto della personalità (in particolare sentimenti perturbanti come l’odio, la rabbia, la solitudine, l’abbandono, ma anche gli aspetti più problematici del desiderio sessuale) e, aggiungerei io, quando la sua forza soverchia la capacità dell’Io di contenerlo e simbolizzarlo.
L’elemento centrale, e innovativo, della riflessione di J. McDougall è che questi agiti rappresentano per l’autrice un cortocircuito psicosomatico. McDougall racconta di se stessa che, dopo essersi riproposta di smettere di fumare, si accorgeva che accendeva una sigaretta ogni volta che era sopraffatta da affetti ingestibili. Il gesto fisico – l’inalazione del fumo – aveva la funzione di lenire la tensione psichica, bypassando il lavoro mentale e affidandosi al corpo come valvola di sfogo, affermando quindi che (ibid., 137) “Uno degli scopi del comportamento dipendente è quello di sbarazzarsi dei propri sentimenti”.
Quando, anni fa, le chiesi perché parlasse proprio di “soluzione psicosomatica” per i comportamenti dipendenti, mi rispose che è proprio la necessità di usare compulsivamente il corpo al posto della psiche che definisce il comportamento del dipendente: “psicosomatico”.
Con il tempo, ho compreso che l’evitamento del lavoro psichico può prendere forme diverse, spesso accomunate da un coinvolgimento diretto o indiretto del corpo. Il corpo può essere infatti il bersaglio di sintomi positivi – psicosomatici, nel senso allargato della Mc Dougall, appunto – e contemporaneamente oggetto di un rifiuto o di un diniego, in un processo di scissione tra psiche e soma.
Già a partire dal Progetto per una psicologia (1895, 217) si va affermando in Freud un modello economico dello psichismo che prevede che l’apparato psichico risponde alla coppia eccitamento/scarica attraverso uno schema elementare tendendo, a fronte di uno stimolo, a scaricare automaticamente ogni eccitamento attraverso un cortocircuito che replica il cosiddetto arco riflesso.
Molti anni dopo per Freud (1920), l’annullamento radicale del lavoro psichico si compie al di là del principio di piacere, lì dove il piacere masochistico coincide con l’ideale ritorno ad una sostanza inanimata, priva di stimoli perturbanti.
A partire da quanto detto, potrei dire che la dipendenza, come la soluzione psicosomatica in generale, non è solo una fuga dall’affetto, ma una fuga dal lavoro psichico che quell’affetto impone alla mente, in quanto legato al corpo.
Se, rifacendoci al modello freudiano, riteniamo che la pulsione abbia un doppio versante – affettivo, radicato nel corpo, e rappresentazionale, che spinge in direzione della psiche – potremmo affermare che nella soluzione psicosomatica assistiamo al fallimento della coppia affetto-rappresentazione con relativo radicamento somatico di affetti non rappresentati. Aggiungerei, quindi, alla intuizione di McDougall, non solo l’evitamento dell’affetto spiacevole ma l’evitamento del lavoro psichico che l’affetto impone alla psiche in virtù del suo legame con il corpo.
Fatta questa premessa, il passaggio teorico-clinico successivo che voglio compiere è legato più specificamente al difetto del funzionamento combinato affetto-rappresentazione in relazione al fantasma di castrazione.
Per sviluppare questo punto, vorrei partire dalla seguente affermazione: la cifra dell’umano sta nella sua imperfezione e il fantasma di castrazione rappresenta – simbolicamente (e potrei aggiungere ‘universalmente’) – il segno (la cicatrice psichica) della perdita della perfezione ‘ideale’. Il concetto di cicatrice psichica potrebbe essere ulteriormente sviluppato ma per ora mi limiterei ad affermare che la presenza della cicatrice psichica, in questo caso l’iscrizione del fantasma nello psichismo, previene la ricaduta sintomatica e nello specifico quella somatica.
Il passaggio mi sembra importante perché sposta il campo di osservazione dal corpo alla psiche. È nella psiche, e non nel corpo che abita la cicatrice, nel caso in questione il fantasma di castrazione. Tanto più si palesa la rappresentazione del fantasma, tanto meno sarà necessaria la sua iscrizione somatica.
La castrazione, iscritta nella psiche, entra in una catena simbolica di cui fanno parte la separazione, la perdita, la malattia, la morte. L’angoscia, affetto che accompagna il fantasma di castrazione, sta proprio nella realizzazione psichica della finitezza umana.
Seguendo l’ultimo Freud (1925, 1938), la difesa che si contrappone alla realizzazione intrapsichica della castrazione, con la conseguente angoscia, è Il diniego che, producendo una scissione dell’Io, ammette su un piano e rinnega sull’altro l’evidenza della differenza tra i sessi e il senso che ne accompagna la percezione. Freud ci avverte che non si tratta di cancellare, scotomizzare la traccia percettiva dell’evidenza della differenza tra i sessi ma che piuttosto, con il diniego, non si accetta ciò che i sensi attestano, la minaccia della castrazione, il suo significato e l’angoscia conseguente. La scissione produce l’effetto di ammettere su un piano (quello cognitivo) e rinnegare sull’altro (quello affettivo) la castrazione. La scissione ideo-affettiva che si produce (che potremmo anche definire psico-somatica) è figlia del rinnegamento della castrazione, ‘questa cosa’ (l’evidenza della differenza sessuale) ‘esite ma non significa niente’ (non si iscrive nella psiche e non assume valenza simbolica). Il feticcio viene investito quale baluardo a difesa del rinnegamento del significato e, in una prospettiva evolutiva, può diventare il prototipo di variazioni progressivamente più simboliche e meno concrete. Questa mia considerazione si discosta da Freud, per il quale la creazione del feticcio determina una scissione dell’Io che non potrà che approfondirsi sempre più.
La cicatrice-castrazione quando ammessa dalla psiche, segna il limite all’onnipotenza, mettendo ordine nel registro simbolico. È il limite che spezza l’onnipotenza infantile e introduce il soggetto all’ordine dell’umano.
Inevitabilmente, quote di onnipotenza si oppongono con forza, radicalmente, a questa perdita, dando vita a diversi esiti patologici. Qui vorrei proporne tre, anzi quattro, forme emblematiche, lasciando volutamente insaturo il campo clinico, attraverso le vignette che seguono e che intendono segnalare l’iscrizione somatica del fantasma rinnegato:
- La Perversione
Si pensi al feticismo, alla pedofilia o ad alcune forme di transessualismo, intese in chiave difensiva, come strategie per evitare l’angoscia legata alle differenze e in particolare alle differenze sessuali che l’angoscia di castrazione evoca.
Un paziente, ad esempio, provava dichiaratamente disgusto per il genitale femminile e raccontava di perdere l’erezione di fronte a donne completamente nude (non così quando restavano semivestite e dalle quali si sentiva piuttosto attratto). Fantasticava rapporti con ragazze adolescenti e aveva rapporti omosessuali a carattere passivo estremamente promiscui in locali notturni. In altri momenti, lo stesso paziente, descriveva la chiara sensazione somatica di avere “un buco al posto del pene”.
L’angoscia era totalmente assente e del tutto rinnegata quando provavo a restituirgli il senso delle associazioni relative alla castrazione.
“Ho sognato di avere il mio scroto in mano, la cosa non mi meravigliava né mi preoccupava”.
Oppure: “ho sognato che mi trovavo in camera con un amico. Qualcuno trasportava il suo pene su un vassoio mentre eiaculava. Guardando il pene evirato, gli chiedevo se riuscisse a percepirne l’eiaculazione. Alla sua risposta negativa pensai che bisognasse chiamare un chirurgo per fargli riattaccare il pene”.
Eventuali interpretazioni, anche molto prudenti, relative all’angoscia di castrazione che accompagnavano i contenuti che mi portava erano rinnegate come incomprensibili (ad esempio quando mi raccontava di aver assistito al rito di circoncisione di un cuginetto e associava alla fantasia di scivolare con le natiche su una lunga lama di rasoio posta sul corrimano di un’ampia scala di un palazzo nobiliare)
“chissà che la circoncisione del cuginetto associata a questa fantasia di scivolare con le natiche sulla lama di un rasoio non le abbiano fatto pensare alla paura di perdere il pene?”
“ma assolutamente no, la circoncisione non c’entra niente con la perdita del pene”.
Mi poteva lontanamente parlare della sua angoscia solo attraverso la ricaduta sintomatica nel reale somatico: la dispercezione di non avere il pene e di avere un buco al suo posto che, come lui stesso affermava, potrebbe avvicinarci a riflettere su una soluzione psicosomatica ancora più radicale. Il paziente diceva che pensava fosse così che si dovessero sentire i transessuali che richiedevano di essere operati.
- L’allucinazione
Per quanto apparentemente l’allucinazione ricadrebbe fuori dal dominio del corpo vorrei provare a descrivere, attraverso una vignetta clinica, come vi ricade in quanto effetto del rigetto.
Parto dal celebre caso dell’uomo dei lupi per passare ad un mio caso recente.
Freud (1914) racconta di un’allucinazione in cui il giovane paziente credeva di essersi tagliato un dito, mentre giocava ad intagliare un albero di noci. Questo avveniva il giorno dopo aver udito una storia relativa ad una bambina nata con un dito in soprannumero che le venne reciso con un colpo d’ascia.
Il paziente di Freud, l’uomo dei lupi, aveva rigettato (verwift- qui potremmo soffermarci sulla differenza tra Verwerfung e Verleugnug – rigetto e diniego ma non è questa – per il momento- la sede), sul piano del pensiero, l’ipotesi della castrazione, come se non esistesse, l’aveva esclusa, per vedersela poi ripiombare sotto forma di allucinazioni: il sangue che sgorga dall’albero di noci, il proprio dito tagliato e, probabilmente, il cosiddetto sogno dei lupi (che somiglia più ad un’allucinazione che ad un sogno). Al sogno dei lupi sono collegate tutta una serie di associazioni che evocano la castrazione: ricordiamo, in ordine sparso, la storia del lupo che si spezza la coda pescando (Freud, 1914, 503), la storia del sarto che strappa la coda al lupo (ibid.,509) e la curiosa questione del lupo in meno sull’albero (5 lupi anziché sei o sette come da associazioni alla favola del lupo e dei sette capretti – vedi Musella, 2007).
Il caso: una paziente, in un episodio simile a quello freudiano, vide sul volto di una sconosciuta passeggera con cui viaggiava in treno una profonda cicatrice, che si rivelò poi, con sua enorme sorpresa inesistente. Così come l’uomo dei lupi una volta seduto trova il coraggio di riguardare il suo dito per accorgersi che è ancora perfettamente al suo posto, la donna in questione riguarda la donna di fronte a lei per accorgersi che non ha alcun taglio sul viso. La stessa paziente aveva affrontato numerosi interventi di chirurgia estetica, apparentemente senza angosciarsene affatto, cercando di eliminare in questo modo ogni segno del tempo che passa con relativa perdita dell’ideale integrità somatica che accompagna il processo di invecchiamento. Le operazioni chirurgiche si susseguivano senza limite (2-3-10-20-50…), come se si potesse intervenire all’infinito sul proprio corpo infliggendogli ogni sorta di martirio e, apparentemente, senza alcuna sofferenza e senza chiedersi degli effetti delle evidenti cicatrici che lasciavano il loro segno.
Il diniego del limite psichico (la realizzazione della finitezza umana e del decadimento del corpo) e l’incapacità di accedere al lutto, aveva prodotto la ricerca compulsiva della soluzione chirurgica e i segni (i tagli inflitti sul corpo) a loro volta rinnegati dalla psiche (proprio per l’impossibilità ad accedere alla cicatrice psichica di cui parlavo) ricadevano ora sull’esperienza allucinatoria, la signora con il volto tagliato.
- L’acting psicosomatico
Un altro paziente, caso limite, che viveva in uno stato di apatia permanente e di incapacità a considerare la sua vita un fallimento, era soggetto a ripetuti incidenti che gli provocavano tagli, fratture, ferite. Solo dopo un lungo lavoro analitico e l’ennesimo episodio, questa volta culminato in un incidente gravissimo per il quale rischiò l’amputazione di una gamba – riuscì ad avvicinarsi e ad iniziare a sognare qualcosa che lontanamente conduceva al senso del limite e alla castrazione come suo rappresentante originario.
- La clinica del corpo
Entriamo, infine, in quel vasto territorio che Assoun chiama clinica del corpo. Qui troviamo diverse ‘soluzioni’ che vanno dall’ipocondria, alla psicosomatosi, alla fissazione psicosomatica, al corpo che incorpora il fantasma. Corpo che si fa cripta, deposito dove si annida la psiche non elaborata, corpo che reclama la sua libbra di carne sollevando l’angoscia connessa alla castrazione.
Una paziente viveva il suo diabete non come malattia con le sue temibili complicazioni, non come lutto da elaborare, ma come marchio della castrazione: temeva amputazioni, cecità, decadimenti fisici che rimandavano tutti a un’affettività intollerabile, impossibile da simbolizzare. Nel suo caso, l’angoscia non era per la malattia, per altro ampiamente sotto controllo, ma per l’amputazione: per la perdita di un corpo onnipotente, idealizzato, rifiutante ogni imperfezione (che, come dicevo prima, avrebbe nel fantasma di castrazione la sua naturale rappresentazione psichica).
Il corpo, invece, diventa teatro dell’angoscia, e il sintomo, la malattia, assumono significato simbolico. Anche un precedente vissuto ipocondriaco, della stessa paziente, di avere un fantomatico cancro al seno non era connesso tanto alla temibile, fantasticata, neoplasia quanto alla presunta amputazione che avrebbe dovuto subire.
Infine, un altro paziente si tagliuzzava gli arti per imprimere sul corpo il limite (la castrazione-cicatrice) che non riusciva a realizzare psichicamente.
In conclusione, ciò che questi casi condividono è l’evitamento del lavoro psichico. Il corpo – ora ferito, ora rinnegato, ora agito, ora allucinato – prende il posto della psiche.
Una quota di narcisismo onnipotente irrisolto (ma quando si può dire completamente risolto?) cerca proprio questo: cortocircuitare il fantasma di castrazione eleggendo il fallo idealizzato, allucinato, incorporato in una cripta psicosomatica a rappresentare l’integrità narcisistica onnipotente immutata.
Per concludere: la soluzione psicosomatica (nel senso allargato e condiviso da molti autori, tra cui i citati McDougall e Assoun) è una scorciatoia al lavoro psichico ma, ovviamente, è una trappola e può tristemente risolversi nell’essere una tomba (di queste cose si può, infatti, purtroppo, morire). È il modo in cui il corpo si fa portavoce di un dolore non pensato, di un affetto non rappresentato, un modo per preservare la scissione rispetto alla possibilità di accedere alla rappresentazione e al lutto.
È nostro arduo compito, come analisti, quello di aiutare quel corpo a ritrovare il cammino verso la rappresentazione.
Bibliografia
Assoun P.L. (1997) La clinica del corpo. FrancoAngeli. Milano, 2004
Freud S. (1895) Progetto di una psicologia. O.S.F., 2.
Freud S. (1914). Dalla storia di una nevrosi infantile (Caso clinico dell’uomo dei lupi). O.S.F., 7.
Freud (1920) Al di là del principio di piacere. O.S.F., 9.
Freud (1927) Feticismo. O.S.F., 10.
Freud (1938) La scissione dell’Io nel processo di difesa. O.S.F., 11.
Mc Dougall J. (2002) L’economia psichica della dipendenza: una soluzione psicosomatica al dolore psichico In Stati caotici della mente (L. Rinaldi, a cura di). Raffaello Cortina. Milano, 2003
Musella R. (2007). Sogno, Transfert, Allucinazione. Riv. Psicoanal., 53, 941-958.