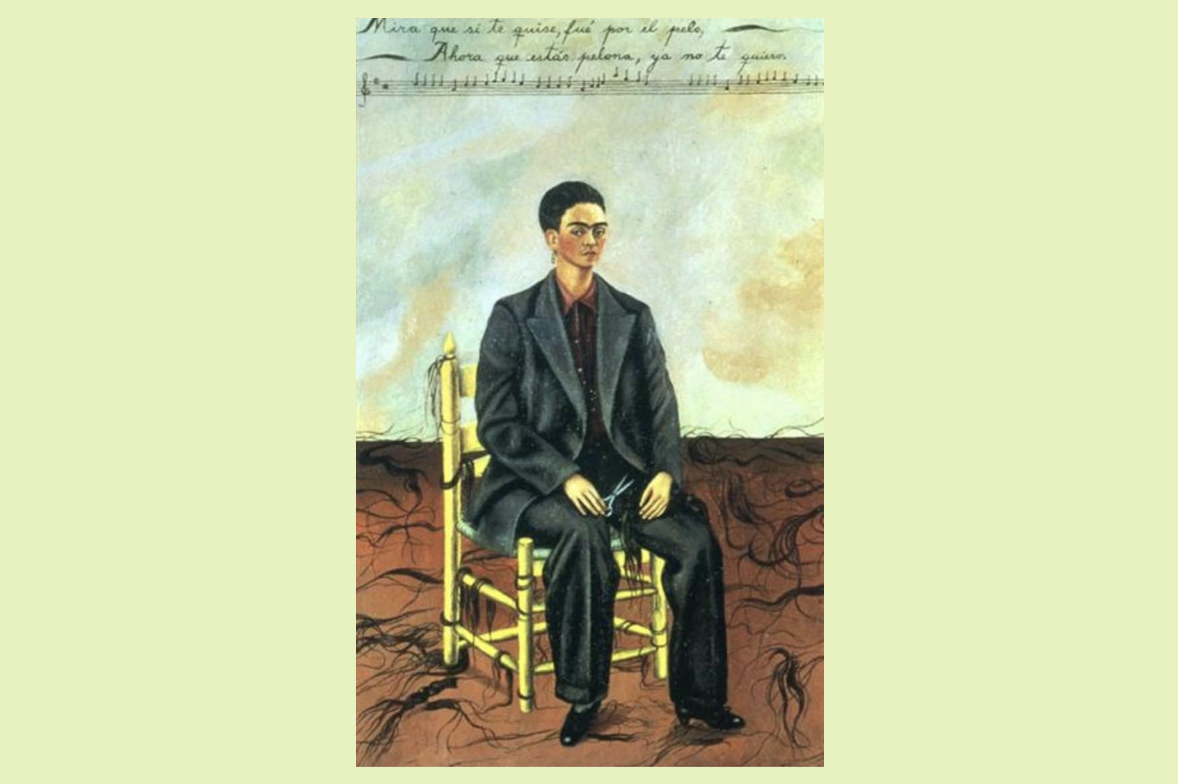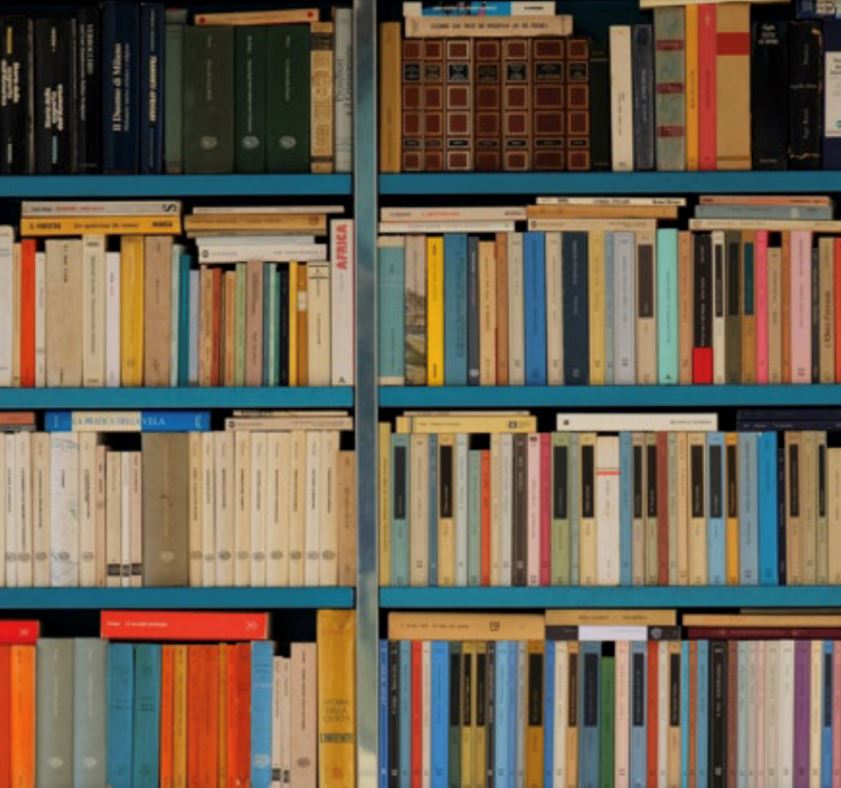Parole chiave: cura psicoanalitica, campo analitico, relazione analista-analizzando, intersoggettività.
Marina e il suo immenso dolore che trova un argine nel campo analitico
Come se il mare separandosi
svelasse un altro mare,
questo un altro, e i tre
solo il presagio fossero
d’un infinito di mari
non visitati da riva-
il mare stesso al mare fosse riva-
questo è l’eternità
(Emily Dickinson, 1955)
Madre e bambino sono immersi nello stesso mare. E nello stesso sogno.
Sin dalla vita intrauterina, il cordone ombelicale collega il feto alla placenta. La placenta è un organo di mezzo, appartiene sia alla madre che al feto. È un organo co-creato. Rappresenta il regno di mezzo che, in qualche modo, avvolge psichicamente, anche dopo la nascita, madre e bambino in un unico abbraccio. Come ci fa notare Civitarese (2023), sin dalla nascita esiste “un che di comune” che riunisce e al contempo separa: come il fiume che crea le sponde del letto in cui scorre. Soggettività e intersoggettività coesistono, sin dall’inizio, in una danza tra identità e alterità. Il rapporto tra le due facce è dialettico, l’una non può esistere senza l’altra. (Civitarese, 2023, 2025). C’è una madre e c’è un bambino, così come nel campo analitico c’è un analista e c’è un analizzando.
Madre e bambino s’incontrano nel rispecchiamento e nel riconoscimento reciproco.
Si ritrovano all’unisono nello stesso sguardo e nello stesso abbraccio. Come sappiamo, infatti, non possiamo parlare di madre senza bambino e viceversa non possiamo parlare di bambino senza madre (Winnicott, 1965).
In greco, esiste il verbo duale che sta ad indicare due persone che sono accoppiate tra di loro e che diventano un tutt’uno.
Le cose contemporaneamente sono unite e separate, sono nostre e non sono nostre. C’è sempre qualcosa a metà.
Come il canale del Bosforo che divide e unisce tra loro la città asiatica (orientale) dalla città europea (occidentale) di Istanbul; o come il canale dello stretto di Messina (U Strittu) che divide la Sicilia dall’Italia e collega i due mari Tirreno e Ionio, le cui acque per un gioco di correnti reciproche si mescolano tra di loro.
Il soggetto non può esistere senza l’oggetto.
Esistere deriva dal latino ex sistere ovvero avere l’essere da un altro, ricevere la possibilità d’essere da qualcuno di esterno al Sè. Si può esistere solamente se si sta in relazione con qualcun altro.
Nella relazione tra madre e bambino si crea una danza ritmica tra presenza e assenza, avvicinamento e allontanamento, soggettività e intersoggettività. Si crea una pulsazione vitale, un continuo movimento, come le onde del mare.
“Ciò che prima si dilatava, ora si contrae. Ciò che prima sembrava implodere, ora potrebbe esplodere. Lo spazio-tempo si muove come un’onda sinuosa ed è continuamente mutevole” (Genovesi, 2024, 24).
Come il movimento che caratterizza il processo evolutivo nel campo analitico che è co-creato da analista e analizzando.
Siracusano nota che “lo spazio analitico può essere limitato e illimitato, a una o più dimensioni, si può espandere e contrarre […] è irrazionale, amatematico e ageometrico” (Siracusano, 1981, 87).
Ogni cosa è continuamente suscettibile di cambiamento. Ci s’incontra e ci s’incastra reciprocamente.
“Come sappiamo, la metafora del campo è presa a prestito dalla teoria del campo elettromagnetico o gravitazionale. Le proprietà essenziali che essa veicola sono di rappresentare una totalità dinamica, di essere inclusiva, invisibile (ma deducibile dagli effetti che esercita sui suoi elementi costitutivi), delimitata (anche se continuamente in contrazione o in espansione) […] È un contenitore (una delle radici etimologiche del termine “campo” proviene dal latino capere ossia “contenere”). Naturalmente ciò non vuol dire che sia un sistema chiuso, bensì facendosi contenuto esso stesso si relaziona dialetticamente con ciò che gli è esterno, cioè con gli altri contenitori più ampi” (Ferro e Civitarese, 2015, 20-21).
Si genera una relazione complessa tra sistemi diversi. Come un regno comune di interconnessione reciproca. Ognuno di noi, infatti, vive essenzialmente nell’esperienza della relazione con l’altro (Merleau-Ponty, 2002).
Esperire proviene dal latino experiri e dal greco empeirào, ossia sperimentare, mettere alla prova; nella versione che proviene dal greco empeiro significa anche attraversare, passare attraverso, muoversi e transitare da un luogo all’altro. Quindi, sembra attenere a uno sperimentare contemporaneamente sia nel mondo interno che nel mondo esterno, transitando continuamente tra ciò che osserviamo fuori e ciò che intuiamo dentro. Nella dialettica, reciproca e reversibile, tra la radice etimologica latina ex ovvero fuori e la radice etimologica greca en ovvero dentro.
Si crea un canale di collegamento tra il mondo interno e il mondo esterno. Si genera un collegamento tra noi e gli altri che ci fa incontrare in un campo comune che è nostro (Civitarese, 2023, 2025).
Si co-genera una danza in cui ci passiamo vicendevolmente le nostre sensazioni e le nostre emozioni e impastiamo insieme i nostri affetti e i nostri pensieri.
Nel campo analitico, c’è un flusso continuo che potenzialmente cambia a seconda da quale prospettiva lo osserviamo.
Lo Verso, citando Morin, si collega all’epistemologia della complessità, mettendo in evidenza che l’insieme di un sistema è diverso dalla somma delle parti e inoltre che in un campo di osservazione è necessario includere la soggettività dell’osservatore (Lo Verso, 1994).
Anche Bion in Trasformazioni nota che “Secondo Heisenberg, nella fisica atomica, si è verificata una situazione in cui lo scienziato non può fare affidamento sulla visione, comunemente accettata, in base alla quale il ricercatore ha accesso ai fatti, poiché i fatti che devono essere osservati sono distorti dall’atto stesso dell’osservazione” (Bion, 1965, 72).
L’osservatore, quindi, entra a far parte del campo osservato. Se cambia prospettiva l’osservatore, cambia anche il fenomeno osservato.
Come ci fa notare Civitarese (2023), da un punto di vista clinico, potremmo pensare al campo analitico costituito dai movimenti della coppia madre-bambino, così come della coppia analista-analizzando, in quanto un processo che se c’è un buon incontro favorisce la crescita di entrambi, mentre se non c’è un buon incontro la ostacola; ovvero, qualcosa che può funzionare sia in senso progressivo che regressivo.
Per questo diventa fondamentale che nel campo analitico, l’analista si assuma la responsabilità di creare un clima favorevole all’incontro reciproco a livello profondo, di sensazioni, di emozioni, di affetti e di pensieri.
Marina ha 16 anni. Da qualche mese è in analisi, in quanto un paio di anni fa ha perso il padre per un malore improvviso. Non riesce a parlare del padre perché il dolore è troppo forte e non arginabile. Dice che da sola non ce la fa. Lamenta violente e improvvise crisi d’ansia con fame d’aria e scariche diarroiche. Penso a una necessità urgente di evacuare emozioni intollerabili, in maniera impellente. Anch’io, talvolta, vengo colto da improvvisi crampi addominali e sensazioni di sbandamento. Credo che queste mie sensazioni somatiche mi consentano di sintonizzarmi con lei, in maniera tale da incontrarci in un unisono emotivo. Ci sono sensazioni che vengono pensate insieme, in maniera implicita, in un vissuto comune. Così diventa possibile generare una danza analitica con un ritmo armonico che ci consente di crescere e di creare un contenitore nei confronti di contenuti intollerabili. La funzione alfa del campo analitico così può trasformare gli elementi beta in elementi alfa. Da qui nasce la possibilità di co-creare un sogno congiunto, una funzione onirica che crei un principio di pensiero e metabolizzazione mentale. Solo così diventa possibile che Marina cominci a parlare del padre, di come ha ricevuto la notizia inattesa e di come il dolore sia atroce per lei. Mentre ne parla, piange a dirotto e mi chiede dei fazzoletti di carta per asciugare le lacrime che copiosamente scendono dai suoi occhi e le bagnano, illuminandolo, il viso. Qualcosa che asciughi la sua angoscia dilagante e allagante. Qualcosa che avvii una funzione pensante. Così sembra che gradualmente il dolore, nel campo analitico, possa trovare un argine che è la possibilità di cominciare ad elaborare il lutto e tornare alla vita.
Bibliografia
Bion W.R. (1965). Trasformazioni. Roma. Astrolabio. 2024.
Civitarese G. (2023). Introduzione alla teoria del campo analitico. Milano. Raffaello Cortina.
Civitarese G. (2025). I limiti dell’interpretazione. Milano. Franco Angeli.
Dickinson E. (1955). Tutte le poesie. Milano. Mondadori. 1997.
Ferro A., Civitarese G. (2015). Il campo analitico e le sue trasformazioni. Milano. Raffaello Cortina.
Genovesi B. (2024). La cura psicoanalitica. In un intreccio interdisciplinare tra fisica quantistica, filosofia e neuroscienze. Milano. Franco Angeli.
Lo Verso G. (1994). Le relazioni soggettuali. Torino. Bollati Boringhieri.
Merleau-Ponty M. (2002). Conversazioni. Milano. SE. 2025.
Siracusano F. (1981). Lo spazio nella relazione analitica. Rivista di Psicoanalisi. 1: 83-95.
Winnicott D.W. (1965). Sviluppo affettivo e ambiente. Roma. Armando. 1970.