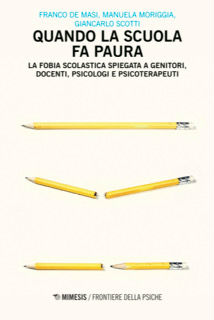Parole chiave: Pedagogia, Scuola, Soggettivazione, Ascolto, Consultazione psicoanalitica.
Angelo Antonio Moroni
Psicoanalisi e Scuola: un dialogo necessario alla luce delle nuove soggettività emergenti in età evolutiva.
“Betty ha talento, sa ballare
Con l’amore e la violenza
Vive bene, vive male
Non esiste differenza
Tra la morte di una rosa
E l’adolescenza”
Baustelle, “Betty”, da “L’Amore e la Violenza” (2017)
Uno sguardo d’insieme
L’interrogarsi delle discipline psicologiche in generale, e della psicoanalisi in particolare, sulle metodologie di intervento extra-cliniche in età evolutiva, non è un fatto recente. Questo interrogarsi ha sempre implicato una riflessione sulla possibilità di estendere e rendere malleabili le metodologie di ricerca, prevenzione e presa in carico. La scuola è senza dubbio un palcoscenico extra-clinico nel quale possiamo assistere alla nascita psicologica di un bambino, di un preadolescente e di un adolescente, momento che presuppone fenomeni emotivi molto potenti, quali:
- il processo di separazione-individuazione dai legami familiari infantili;
- il perturbante e conflittuale confronto generazionale tra genitori e figli;
- la trasformazione della dipendenza dagli adulti significativi;
- la creazione di un nuovo contenitore sociale costituito dal “gruppo dei pari”;
- l’avvento, spesso traumatico della sessualità in adolescenza.
Questo tipo di fenomeni, che hanno tutti una radice sia individuale che psicosociale, rivestono certamente un ruolo centrale nel determinare il contenuto delle dinamiche inconsce che attraversano l’istituzione scolastica.
Come scrive Biondo (2022) nel recente ricco testo psicoanalitico “Psicoanalisi a scuola”, a proposito di un possibile contributo della psicoanalisi nel contesto scolastico:
“riteniamo che non sia sufficiente lavorare solo sul metodo, per quanto sia importante, occorre lavorare con i docenti, sulla relazione dei docenti con i loro allievi, e con le famiglie e sulle modificazioni generazionali che hanno stravolto il contesto culturale e relazionale all’interno del quale si muove l’azione educativa dell’istituzione scolastica. In questo campo la psicoanalisi può dare un significativo contributo grazie alle sue riflessioni sulla relazione di transfert-controtransfert che si svolge tra docenti e allievi, grazie alle sue riflessioni teorico-cliniche sulle origini della capacità di pensare e sullo sviluppo del pensiero, sullo sviluppo della capacità di apprendere e sul blocco evolutivo che proprio tale capacità inibisce” (Biondo, 2022, p. 11).
E’ proprio dall’intreccio tra i vari fili che costituiscono il tessuto umano con cui è fatta l’”agenda inconscia” (Perini, 2007) dell’istituzione scolastica intesa come gruppo, che possono sorgere le potenzialità inaspettate per un intervento psicologico psicoanaliticamente orientato in questo ambito.
Dal punto di vista biologico e neuroscientifico si parla peraltro, in particolare della preadolescenza e dell’adolescenza, come di un “sensitive period” o di una “sensitive window” (Laube, van den Boos, Fandakova, 2020) nell’elicitazione di fattori di rischio in relazione, per esempio, alla scoperta della sessualità (Victor, Hariri, 2017); ma ad essa si guarda anche come nuovo fenomeno favorente grandi opportunità di carattere cognitivo, esperienziale, affettivo e sociale, cioè di apprendimento in senso ampio (Suleiman, Galvan, Paige Harden, Dahl, 2017). La letteratura è unanime nel sottolineare che lo sviluppo puberale è soggettivo, singolare, instabile e dipendente da molti fattori, tra cui, soprattutto, quello relativo alla presenza e al ruolo dei caregivers e dell’ambiente-gruppo che circonda l’adolescente, in particolare il gruppo dei pari (Sisk, Gee. 2021). Tali interazioni trovano un loro contenitore d’elezione nella scuola.
In psicoanalisi il “modello monopersonale” dello sviluppo psichico in età evolutiva è stato a lungo, anche dopo Freud, paradigma dominante (vedi anche Blos, 1971, 1967; Erikson, 1968; Laufer & Laufer, 1984). Tale paradigma ha mantenuto un’impostazione metapsicologica classica, pur declinata secondo architetture teoriche differenti.
Studi più recenti (vedi Leuzinger-Bohleber et al., 2022, Arnett, 2006; Riva Crugnola, 2024), vedono invece lo sviluppo evolutivo in modo sempre più discontinuo e campo-dipendente. L’attuale ricerca nell’ambito della “Field Theory” post-bioniana amplia ancora di più il concetto di “campo” ad un intersoggettivo allargato che co-determina le vicissitudini dell’individuo. Questi ultimi vertici teorici attingono cioè a uno sfondo filosofico non tanto vicino a quello di Martin Buber, cioè al “principio dialogico” tra sé e altro (Buber, 1997), ma piuttosto a quello della fenomenologia intersoggettiva. Stiamo parlando in particolare del pensiero di Corrao (1998), di Ferro (1992, 2013, 2017) e di Civitarese (2011, 2017), Manica, 2025) che si rifanno alla fenomenologia husserliana, a Merlau-Ponty (1945), ma anche ad Heidegger (Heidegger, 1927; Moroni, 2023). Per non parlare della messa in discussione del concetto di “fase di latenza”, ritenuto da molti analisti ormai obsoleto, anche considerato che la pubertà oggi si manifesta già intorno agli 8 anni (Rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Buzzi, Cavalli, De Lillo, 2024). Come osserva ad esempio Florence Guignard (2010), la pulsionalità infantile, iperstimolata dai nuovi strumenti tecnologici messi fin da subito a disposizione dei bambini, e dal gruppo dei pari – particolarmente quello scolastico – sembra andare incontro sempre più a fenomeni di “disimpasto pulsionale”.
Agli aspetti summenzionati dobbiamo aggiungere: le attuali trasformazioni della famiglia e delle sue geometrie relazionali; la digitalizzazione e informatizzazione dei rapporti sociali cui i soggetti in età evolutiva sono esposti fin da piccoli (per una disamina più completa degli studi sulle “identità digitali” in adolescenza, vedi in particolare Marchiori & Moroni, 2024); le tematiche relative alle varianze di genere; la crescente sintomatologia legata all’agito e alla violenza auto ed etero-diretta. Tali trasformazioni attualmente in atto sono spie di una mutazione antropologica radicale, sia individuale che gruppale, che estrinseca i propri modi di manifestazione all’interno del contenitore sociale scolastico, a volte in modo anche deflagrante. La serie TV inglese “Adolescence” (2025) mette assai bene in evidenza, in modo suggestivo e potente, proprio questi elementi.
La consultazione psicoanalitica in ambito pedagogico: evoluzione storica di un rapporto complesso.
Nonostante Freud avesse sempre considerato le Scienze Umane, la Pedagogia e in particolare la Filosofia, come modalità intellettualistiche e distanzianti di conoscenza del mondo da parte della psiche dell’individuo, i continuatori del suo pensiero, particolarmente Anna Freud e Melanie Klein, hanno certamente apportato enormi contributi sia teorici che clinici alla pedagogia. La psicoanalisi infantile ha inoltre generato un paradigma innovativo in quest’area di ricerca. Tale paradigma possiamo definirlo con Pellizzari (2003), linguistico-relazionale, dove il termine “linguistico” rimanda alla promozione dei processi di simbolizzazione e di reverie a partire dagli elementi somatici grezzi con cui per lo più si esprimono i bambini e gli adolescenti. “Relazionale” è un aggettivo che invece pone l’accento sull’importanza della relazione con il caregiver/adulto significativo nel creare uno spazio psichico e intersoggettivo che favorisca la crescita. La figura dell’insegnante, a partire dalla filosofia idealistica ottocentesca, è sempre stata intesa tuttavia, quantomeno in Italia, come espressione massima dello Spirito, soprattutto se guardiamo al pensiero di Hegel (Hegel, 1807). Tale prospettiva ha prodotto una concezione dell’insegnamento centrata su un assetto completamente asimmetrico tra insegnante e discente. La filosofia di Gentile – che in Italia ha improntato negli anni ’20 la nota riforma complessiva della scuola pubblica – è infatti ispirata dal pensiero hegeliano. Per Gentile “Non s’insegna ad insegnare”: questo è uno dei punti cruciali della pedagogia gentiliana. Sono solo la ricchezza spirituale del maestro, dote innata, ciò che rende il maestro maestro e la scuola scuola. Non esiste un metodo: il metodo è il maestro. Hegelianamente, dunque, per Gentile ciò che fonda la relazione maestro-allievo è una dialettica spirituale, non certo una relazione come la intende la psicoanalisi. L’insegnante è tensione verso l’Assoluto dell’autocoscienza dello Spirito: educare significa indicare questo assoluto all’allievo come fine della sua soggettivazione. Questo tipo di filosofia pedagogica ha permeato l’istituzione scolastica fino ai giorni nostri, delegittimando di fatto qualsiasi tipo di intervento psicologico e/o psicoanalitico in questo ambito. Bisogna infatti arrivare al 1990, cioè al D.P.R. 9/10/90 n°39, perché nelle scuole secondarie, si istituiscano i C.I.C (Centri Informazione Consulenza). Come scrive Bozzola (2022) descrivendo il ruolo dei C.I.C.: “Si tratta di uno spazio di accoglienza che ha l’obiettivo di favorire il benessere di bambini e ragazzi e di prevenire situazioni di disagio e comportamenti a rischio, prima che interferiscano con i normali processi di crescita bio-psico-sociale” (Bozzola, 2022, p. 59). A partire da questi primi Centri sperimentali di ascolto, lo Sportello di Ascolto Psicologico Scolastico, diventa via via uno degli interventi elettivi della più vasta grande branca della psicologia chiamata “psicologia scolastica”, ma solo a partire dal decennio 1990-2000 (Cornoldi & Molinari, 2019; Francescato, Tomai & Ghirelli, 2011). In Italia Matteo Lancini, è uno dei primi a promuoverne lo sviluppo e a scriverne in modo sistematico (Lancini, 2003, 2021). Da segnalare in tale area anche la ricerca, per quanto riguarda il Nord Italia di Marchiori e Moroni (2022) e, per quanto attiene al Centro-Sud, gli studi di Biondo (2020, 2022). Lo psicologo clinico è la figura professionale che opera in questo contesto, ma l’obiettivo del suo lavoro, come da mandato della scuola, “non è quello di iniziare un percorso psicoterapeutico ma di accogliere il disagio per sostenere i ragazzi e gli insegnanti con suggerimenti e proposte attualizzabili nel loro contesto” (Di Rienzo & Bianchi di Castelbianco 2020, p. 15).
Al di là del contesto italiano, sul piano internazionale le intersezioni tra psicoanalisi, pedagogia e clinica dell’età evolutiva, sono state invece molto vive fin dalle origini della psicoanalisi stessa. Basti pensare alla figura di Susan Isaacs, allieva di Melanie Klein, che dal 1924 al 1927 ha diretto la Malting House School in Inghilterra, applicando la metodologia psicoanalitica nella prassi pedagogica. Questa studiosa, ha avuto modo di raccogliere una considerevole quantità di dati osservativi relativi al gioco infantile, alle sue relazioni con lo sviluppo sociale del bambino e del preadolescente, e alle funzione dell’adulto come educatore all’interno della relazione insegnante-allievo. L’elemento innovativo del suo pensiero consiste nell’aver enucleato alcune essenziali distinzioni tra adulto-educatore, cioè promotore del benessere psico-socio-affettivo del bambino, e psicoterapeuta. Ha posto quindi le basi di una più moderna visione pedagogica, nella quale la funzione dell’osservazione e dell’ascolto psicologico sono centrali tanto quanto quella educativo-curricolare.
Sempre in Gran Bretagna, occorre ricordare il servizio di consultazione del Tavistock Institute (Young People Counselling Service) che da anni ha assunto la funzione di “radar sociale” e di monitoraggio di un disagio adolescenziale che da fisiologico potrebbe avere – o non avere- la possibilità di cronicizzarsi in blocchi evolutivi patologici.
Un’altra esperienza sempre di area anglosassone, di interscambio proficuo tra psicoanalisi e scuola è il modello di consultazione psicologica elaborato da Moses ed Egle Laufer a metà degli anni ‘80, decisamente più clinico-terapeutico e di impronta freudiana, che rappresenta da molto tempo un servizio innovativo come estensione del metodo psicoanalitico in campo sociale. Nella struttura da loro diretta, il “Brent Consultation Service”, Finanziato dal Dipartimento dell’Educazione di Londra, si occupano da anni di giovani con problematiche essenzialmente patologiche, ai quali viene fornita una consultazione di tipo diagnostico mirata all’invio ad una psicoterapia.
Dell’area francese, è da ricordare il Centro di Psicoanalisi e Psicoterapia fondato a Parigi da Evelyne e Jean Kestemberg sempre negli anni ‘80, che ha a lungo lavorato sul tema della consultazione clinica. Secondo questi autori il momento della consultazione assume di per sé un significato importante per il paziente, al di là del fatto che poi il soggetto intraprenda o meno un trattamento terapeutico. La consultazione in quanto tale, e al di là dei contesti psicosociali in cui è effettuata, determina l’attivazione precoce di fenomeni di transfert e fornisce al paziente un fondamentale aiuto per comprendere meglio la sua vita interiore.
La scuola come “garante metapsichico” e le nuove soggettività emergenti in età evolutiva: una sfida per la psicoanalisi.
Non abbiamo qui lo spazio per approfondire il pensiero dei molti psicoanalisti italiani che a partire dagli anni ’50 si sono occupati dell’estensione del metodo psicoanalitico in ambito sociale, extra-clinico e in particolare scolastico. Ci basterà quindi ricordare i contributi fondamentali di: Tommaso Senise (1990); Giovanna Giaconia (1989, 2005); Giuseppe Pellizzari (2003, 2021); Ruggiero (2006); Roberto Goisis (2014); Arnaldo Novelletto (1986, 2009); Gustavo Pietropolli Charmet (2000). Ciò che accomuna il lungo percorso di elaborazione teorica e di prassi della consultazione in contesti istituzionali, ci sembra in ogni caso il considerare fruttuoso e percorribile l’intervento di consultazione psicoanalitica a scuola. Riprendendo il pensiero di Kaes (2009) è infatti sempre più chiaro che in molte situazioni sociali particolarmente deprivate, la scuola rappresenti uno dei pochi se non l’unico “garante metapsichico”, cioè l’unico contenitore affettivo e relazionale per molti giovani. La scuola, intesa come dimensione gruppale generatrice di potenzialità socializzanti, appare sempre più come una delle occasioni di scambio emotivo significativo per i ragazzi di oggi. Le nuove soggettività emergenti, i nuovi modi in cui si estrinseca l’identità nascente di preadolescenti e adolescenti, sono infatti, oggi più che mai soggetti ad una vera e propria ibridazione con il digitale e il virtuale. Anche il “gruppo dei pari” sembra essersi trasferito sui Social, depauperando gravemente le occasioni di scambio e di conoscenza reciproca in contesti naturali come appunto le aule scolastiche. Ci troviamo cioè sempre più di fronte a identità digitali (Marchiori & Moroni, 2024) che generano rappresentazioni di Sé per lo più attraverso il registro dell’immagine, e non tanto mediante il linguaggio simbolico verbale o scritto. Il cosiddetto virtuale è ormai difficilmente differenziabile dal reale, tanto che molti autori parlano di vita onlife. Se, ad esempio Bollas sottolinea che la “cultura dell’immagine” portata avanti dagli attuali social network utilizzati per la maggiore dagli adolescenti, (Instagram, Tik Tok, etc.) è descrivibile come “l’insieme dei fenomeni che utilizzano la vista per evitare l’insight” (Bollas, 2018), altri autori contemporanei, come Boursier (2022), o Vlachopoulou e Houssier (2022) ne individuano invece possibili potenzialità transizionali oltre che i possibili rischi di un loro abuso anche sul versante dell’addiction.
In un contesto di trasformazioni antropologiche di questa portata, la scuola non può naturalmente rifugiarsi all’interno di una ideale astoricità di tipo gentiliano/hegeliano, ma al contrario deve assumersi la responsabilità e la consapevolezza di essere un importante “garante metasociale” per la psiche in formazione degli studenti; allo stesso modo la psicoanalisi deve considerare come nuova sfida da affrontare, quella di estendere il suo metodo in contesti sociali come la scuola stessa, che sono rimasti tra i pochi in cui poter “raggiungere” (Joseph, 1985) i bambini, i preadolescenti e gli adolescenti, per poterli aiutare e per prevenirne il disagio psichico. Abbiamo visto, emblematicamente, come la pandemia da Covid-19 abbia generato e aumentato la sofferenza mentale degli adolescenti, e accentuato la casistica da ritiro sociale (hikikomori). Scrive in modo emblematico Marchiori (2022): “I dati del rapporto UNICEF pubblicato nell’ottobre 2021 ‘La condizione dell’infanzia nel mondo. Nella mia mente: promuovere, tutelare e sostenere la salute mentale dei bambini e dei giovani’, sono allarmanti e sottolineano che l’impatto della pandemia sulla salute mentale è solo “la punta dell’iceberg”. Già prima di questo evento troppi bambini soffrivano di problemi non affrontati di salute mentale, che interferiscono con la loro capacita di sviluppare appieno il proprio potenziale di realizzazione nella vita (…) La pandemia ha evidenziato in modo eclatante come la salute mentale sia basata su una rete estremamente delicata, soprattutto per i bambini e gli adolescenti, il cui equilibrio psicologico dipende molto da quello dei genitori e di chi, a vario titolo, si prende cura di loro. Inoltre, tale equilibrio è interconnesso all’ambiente esterno, alle risorse economiche e culturali, alla salute fisica, alle relazioni con i pari, alle opportunità che loro si offrono” (Marchiori, 2022, pp. 139-140).
Le “opportunità che loro si offrono” sono in realtà sempre più scarse, e la presenza di Sportelli di Ascolto Psicologico Scolastico, a partire dalle prime esperienze degli anni ’90 coi C.I.C., pur essendosi estesa, non sembra ancora sufficiente. La Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, non ancora pienamente attuata a livello territoriale, è stata in Italia recentemente emanata con l’obiettivo di promuovere e integrare interventi sociali, assistenziali e socio-sanitari a favore di persone e famiglie in difficoltà, riconoscendo il diritto a servizi di qualità e incentivando l’autonomia e la solidarietà. La legge individua ruoli e competenze di Regioni e Comuni, stabilisce strumenti di programmazione come il Piano di Zona. In tale contesto il ruolo dello Psicologo di Base e di quello Scolastico, pare vengono finalmente visti come figure centrali per la realizzazione di progetti di ascolto del disagio giovanile, integrandola nelle équipe territoriali.
L’ambiente scolastico è tuttavia ancora percepito dagli studenti come scarsamente recettivo del profondo bisogno di ascolto delle nuove generazioni. Basti pensare a una recentissima ricerca dell’Università Guglielmo Marconi, interna al più ampio progetto “Cosa farò da grande”. Lo studio ha coinvolto 150 studenti del terzo e quarto anno di un Liceo Classico, di uno Scientifico, un Artistico, un Linguistico e un Istituto Tecnico, collocati in aree differenti – sia ricche che povere – della città metropolitana di Roma. I risultati sono pubblicati su Scuola Democratica a firma della sociologa Rita Fornari, con il titolo “Dare voce agli studenti: metafore sull’esperienza scolastica”. Le metafore utilizzate dai ragazzi per descrivere la loro percezione dell’ambiente scolastico “rimandano al malessere e a una condizione opprimente: la scuola è gabbia, manicomio, purgatorio, inferno. Richiamano regole, vincoli, barriere. Un posto buio, Matrix. Un ragazzo tira fuori L’Urlo di Munch. Qualcuna evoca le montagne russe” (Arletti, Venerdì di Repubblica, 5 settembre 2025, n° 1955, p.20).
Note conclusive
Le nuove forme di soggettivazione identitaria emergenti in età evolutiva rappresentano una nuova sfida per la psicoanalisi, così come per l’Istituzione scolastica e per le altre istituzioni socio-sanitarie deputate alla prevenzione e alla cura di un disagio giovanile sempre più variegato e complesso. La psicoanalisi si trova dunque, oggi più che mai, a ripensare il concetto di consultazione, e a rivedere i propri paradigmi e i propri metodi a riguardo. Cospicuo è peraltro il patrimonio di conoscenze in tale settore di intervento che la psicoanalisi ha accumulato, a partire dalle prime riflessioni di Freud circa “La psicologia del ginnasiale” (Freud, 1914). Per altri versi non possiamo dimenticarci che da decenni psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti si trovano a intervenire in contesti anche molto lontani dal loro consueto setting di lavoro clinico. Basti pensare agli ospedali, alle comunità terapeutiche psichiatriche, alle molte e diversificate strutture dei servizi territoriali. Le esperienze fatte in questi contesti si appoggiano agli studi che lo psicoanalista inglese Bion ha elaborato attraverso una complessa metodologia applicativa della psicoanalisi a gruppi di pazienti psicotici ospedalizzati. A partire da ciò, si è sviluppata la cosiddetta “Psicoanalisi delle organizzazioni”, che prevede la presenza di psicoanalisti all’interno di strutture sanitarie o aziendali in senso lato, con la funzione di supervisore delle dinamiche emotive che i gruppi sviluppano al loro interno, facendoli spesso anche “ammalare” (Bion,1958; De Polo, 2016; Foresti, 2020; Perini, 2007). Tale lunga esperienza teorico-clinica sembra in ogni caso convergere sull’importanza del tema dell’ascolto dei bisogni cangianti delle nuove generazioni. Un ascolto che non può essere distratto, e che soprattutto va calato nei “contesti di vita” in cui bambini, preadolescenti e adolescenti sono più presenti e in relazione tra loro. E’ in atto infatti uno scollamento tra generazioni, la connessione tra genitori e figli è spesso intermittente, ma lo è anche tra alunni ed insegnanti ed educatori. L’incapacità di ascoltare si riscontra anche tra gli adulti stessi, in particolare tra ricercatori, clinici e politici. Risulta sempre più chiaro che la vera sfida sia utilizzare l’ascolto per connettersi, entrare in relazione, interagire, in primis riconoscendo dignità di reale interlocutore allo “studente”, accogliendo il suo punto di vista, immedesimandosi, accettando anche la sua eventuale volontà di non comunicare. Per raggiungere questo obiettivo occorre creare spazi per quello che ha da dire, o per il suo essere difensivamente mutacico. E’ fondamentale tentare sempre di raggiungerlo là dove si trova, tenendo conto di quelli che sono i suoi linguaggi, non solo verbali, ma anche artistici, musicali, creativi, “alternativi”, veicolati molto spesso dal corpo prima ancora che dalla parola.
Riferimenti bibliografici
Aliprandi, T Senise T., Pelanda, E., Psicoterapia breve d’individuazione, Feltrinelli, Milano 1990.
Arletti, C. (2025), Come descrivereste la vostra scuola con una metafora?. In Il Venerdì di Repubblica, 5 settembre 2025, n° 1955, pp. 18-22.
Arnett, J. J. (2006). Emerging Adulthood: Understanding the New Way of Coming of Age. In J. J. Arnett & J. L. Tanner (Eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century (pp. 3–19). American Psychological Association.
Suleiman,B. A., Galvaàn, A., Paige Harden, K., Dahl, R.E. (2017), Becoming a sexual being: The ‘elephant in the room’ of adolescent brain development. In Developmental Cognitive Neuroscience 25 (2017) 209–220
Bollas, C. (2018). L’età dello smarrimento. Milano, Raffaello Cortina.
Bion, W.R. (1958). Esperienze nei gruppi. Roma, Armando, 1971.
Biondo, D. (2020), Gruppo evolutivo e branco. Strumenti e tecniche per la prevenzione e la cura dei nuovi disagi degli adolescenti, Milano, Franco Angeli.
Biondo D. (2022). Introduzione. In D. Biondo, R. Patalano & C. Rotondo (Eds.). Psicoanalisi a scuola (9-12). Roma: Vecchiarelli, data ultima consultazione 25 febbraio 2022: https://
www.psicoanalisiesociale.it/psicoanalisi-a-scuola-a-cura-di-daniele- biondo-roberta-patalano-concetta-rotondo/ Biondo, D. (2017). Mondo digitale e dolore evolutivo. Rivista di Psicoanalisi, 63, 235-252.
Blos P. (1971), L’adolescenza: una interpretazione psicoanalitica, Franco Angeli, Milano 1977.
Boursier, V. (2022). Centralità del corpo e delle relazioni nelle pratiche web-mediate in adolescenza. Riflessioni nell’intersezione tra clinica e ricerca. Psiche, 2, 461-474.
Bozzola, I. (2022), Lo sportello d’ascolto psicologico: esperienze sul campo per definirne confini e possibilità, in Marchiori, E., Moroni, A.A. (Eds.), Ascolto Educativo. Interazioni tra psicoanalisi, pedagogia e clinica dell’età evolutiva, Padova, Linea Edizioni.
Buber, M. (1997). Il principio dialogico e altri saggi. A cura di A. Poma. Roma, Edizioni San Paolo, 2011.
Buzzi, C., Cavalli, A., De Lillo, A. (a cura di) (2022), Quinto Rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, Bologna, Il Mulino
Civitarese, G. (2011). L’inconscio come una funzione psicoanalitica della personalità. Rivista di psicoanalisi, 57, 401-405.
Civitarese, G. (2017). Trasposizioni. Glossarietto di Psicoanalisi. Milano: Mimesis.
Cornoldi, C. & Molinari, L. (Eds.) (2019). Lo psicologo scolastico. Competenze e aree di intervento. Bologna: Il Mulino.
Corrao, F. (1998), Orme. Vol. I. Contributi alla psicoanalisi, Milano, Raffaello Cortina.
De Polo, R. (2016), La bussola psicoanalitica tra individuo, gruppo e società, Milano, Franco Angeli.
D.P.R. 9/10/90 n°39 – Istituzione dei C.I.C. (Centri Informazione Consulenza)
Di Renzo, M. & Bianchi di Castelbianco, F. (2020). Introduzione. Verso nuove frontiere. In F. Bianchi di Castelbianco, M. Di Renzo & A. Memmoli, A. (Eds.) L’ascolto a scuola. Una lettura psicodinamica della generazione 2.0 (pp. 11-15). Roma: Magi.
Erikson, E. (1968). Gioventù e crisi d’identità. Roma, Armando, 1995.
Ferro, A. (1992). La tecnica nella psicoanalisi infantile: Il bambino e l’analista, dalla relazione al campo emotivo. Milano: Raffaello Cortina.
Ferro, A. (2017). Pensieri di uno psicoanalista irriverente. Guida per analista e pazienti curiosi. Milano: Raffaello Cortina.
Ferro, A. (Ed.) (2013). Psicoanalisi oggi. Teoria e tecnica. Carocci: Roma.
Foresti, G. (2020). Disperazione identitaria. Crisi della globalizzazione e confini noi/io/altri. Psiche, 2, 447- 468
Francescato, D. Tomai, D.M. & Ghirelli G., (2011). Fondamenti di psicologia di comunità. Principi, strumenti, ambiti di applicazione. Roma: Carocci.
Freud, S. (1914). Psicologia del ginnasiale. O.S.F. 7.
Giaconia G. (1989), Problemi di tecnica nel trattamento degli adolescenti. In Semi, A.A. (Eds.), Trattato di Psicoanalisi, Vol. 1, Milano, Raffaello Cortina.
Giaconia G. (2005), Criminalità e adolescenza, in G. Giaconia (a cura di), Adolescenza ed etica. Scritti di F. Codignola, F. Ferraro, A. Galli, P. GammaroMoroni, G. Giaconia, S. Lambertucci Mann-G. Pellizzari, Borla, Roma.
Goisis, P.R. (2014), Costruire l’adolescenza. Milano, Mimesis Edizioni.
Guignard, F. (2010), Lo psicoanalista e il bambino nella società occidentale di oggi. Rivista di Psicoanalisi 56:901-920.
Joseph B. (1985), Il transfert: la situazione totale, in Joseph B., Equilibrio e cambiamento psichico, Raffaello Cortina, Milano 1991.
Heidegger, M. (1927), Essere e Tempo, Milano, Longanesi, 2005
KaËs, R. (2009). Le alleanze inconsce. Roma, Borla, 2010.
Lancini, M. (2003). Ascolto a scuola. La consultazione con l’adolescente. Milano: Franco Angeli.
Lancini, M. (2021). L’età tradita. Milano: Cortina Raffaello.
Laube, C., Van den Bos, W., Fandakova, Y. (2020) The relationship between pubertal hormones and brain plasticity:Implications for cognitive training in adolescence. In Developmental Cognitive Neuroscience, 2020-42, 1-14.
Laufer M., Laufer M.E. (1984), Adolescenza e breakdown evolutivo, Bollati Boringhieri, Torino, 1986.
Legge 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Leuzinger-Bohleber. M., Kaufhold, J., Kallenbach, L., Negele, A., Ernst, M., Keller, W., Fiedler, G., Hautzinger, M., Bahrke, U., Beutel, M. & Tavernese, F. (2022), Come misurare le trasformazioni psichiche durature nei trattamenti a lungo termine di pazienti cronicamente depressi. Lo Studio LAC: cambiamenti sintomatici e strutturali negli esiti dei trattamenti cognitivo-comportamentali e psicoanalitici a lungo termine., in L’Annata Psicoanaltica Internazionale 12:70-110
Manica, M. (2025), Da una psicoanalisi attiva a una psicoanalisi contemplativa. Teoria e clinica., Torino, CELID.
Marchiori, E., Moroni, A.A. (Eds.) (2022), Ascolto Educativo. Interazioni tra psicoanalisi, pedagogia e clinica dell’età evolutiva, Padova, Linea Edizioni.
Marchiori, E., Moroni, A.A. (2024), Adolescenza e identità digitali: una sfida per la psicoanalisi. Rivista di Psicoanalisi, 2024/3, pp. 859-878.
Merleau-Ponty, M (1945), Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano, 2003
Moroni, A. A. (2023). Adolescence as a phenomenon of the field and affection as a vector of at-one-ment in the analytic relationship. International Forum of Psychoanalysis, 1–15. https://doi.org/10.1080/0803706X.2023.2237710
Novelletto A., Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza, Borla, Roma 1986.
Novelletto A., L’adolescente. Una prospettiva psicoanalitica, Astrolabio, Roma 2009.
Pellizzari, G. (2003), La psicoanalisi degli adolescenti ha cambiato la tecnica psicoanalitica? Relazione al 5° Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza “L’adolescente tra contesti naturali e contesti terapeutici” 18 e 19 ottobre 2002-Firenze
Pellizzari, G. & Moroni, A.A. (Eds.) (2021). Una stanza tutta per me. Manuale di psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente. Milano, Mimesis.
Perini, M. (2007), L’organizzazione nascosta. Dinamiche inconsce e zone d’ombra nelle moderne organizzazioni. Milano, Franco Angeli.
Pietropolli Charmet, G. (2000). I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte a una sfida. Milano: Raffaello Cortina.
Riva Crugnola, E. (Eds.) (2024), Diventare giovani adulti. L’approccio psicodinamico a livello evolutivo e clinico, Milano, Raffaello Cortina.
Ruggiero, I. (2006). Consultation in Adolescence: Hurried, Terminable, Interminable. International Journal of Psychoanalysis, 87, 537-554.
Sisk, L., Gee, D.G. (2021), Stress and adolescence: Vulnerability and opportunity during a sensitive window of development. In Current Opinion in Psychology, Volume 44, April 2022, Pages 286-292
United Nations Children’s Fund. The State of the World’s Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children’s mental health, UNICEF, New York, October 2021.
Victor, E.C, Hariri, A.R. (2016), A neuroscience perspective on sexual risk behavior in adolescence and emerging adulthood. In Dev Psychopathol. 2016 May ; 28(2): 471–487.
Vlachopoulu, X., Houssier, F. (2022). Il processo adolescenziale nell’era del digitale. Psiche, 2, 447-460.
Riferimenti filmografici
Adolescence (UK,2025). Mini-serie TV: 4 episodi.Creatori: Stephen Graham, Jack Thorne. Produzione: It’s All Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment.
Riferimenti discografici
Betty. In L’amore e la violenza – Vol I (2017). Artista: Baustelle. Produzione artistica: Francesco Bianconi. Mixaggio: Pino Pischetola. Casa Discografica: Warner Music
Settembre 2025