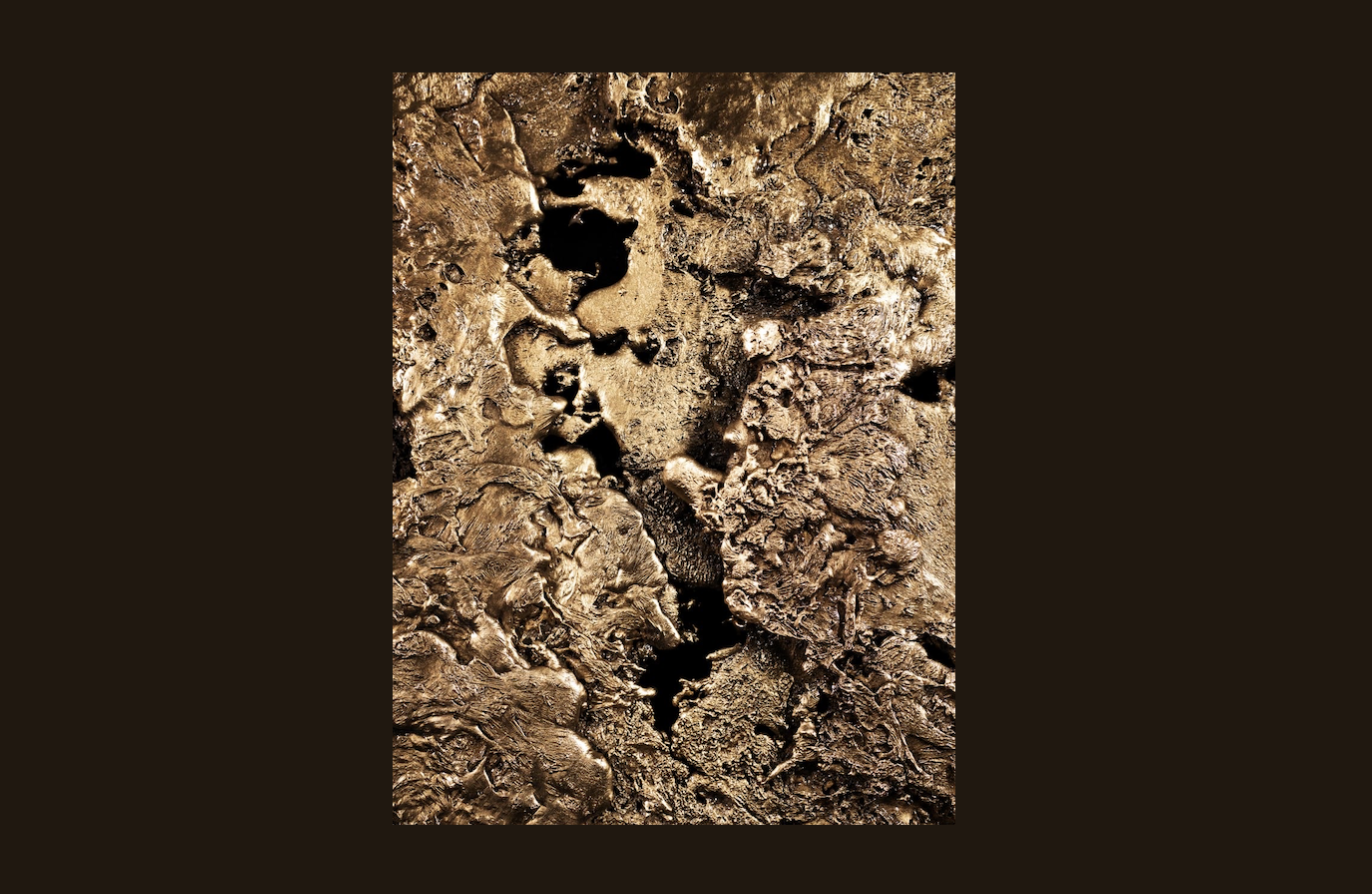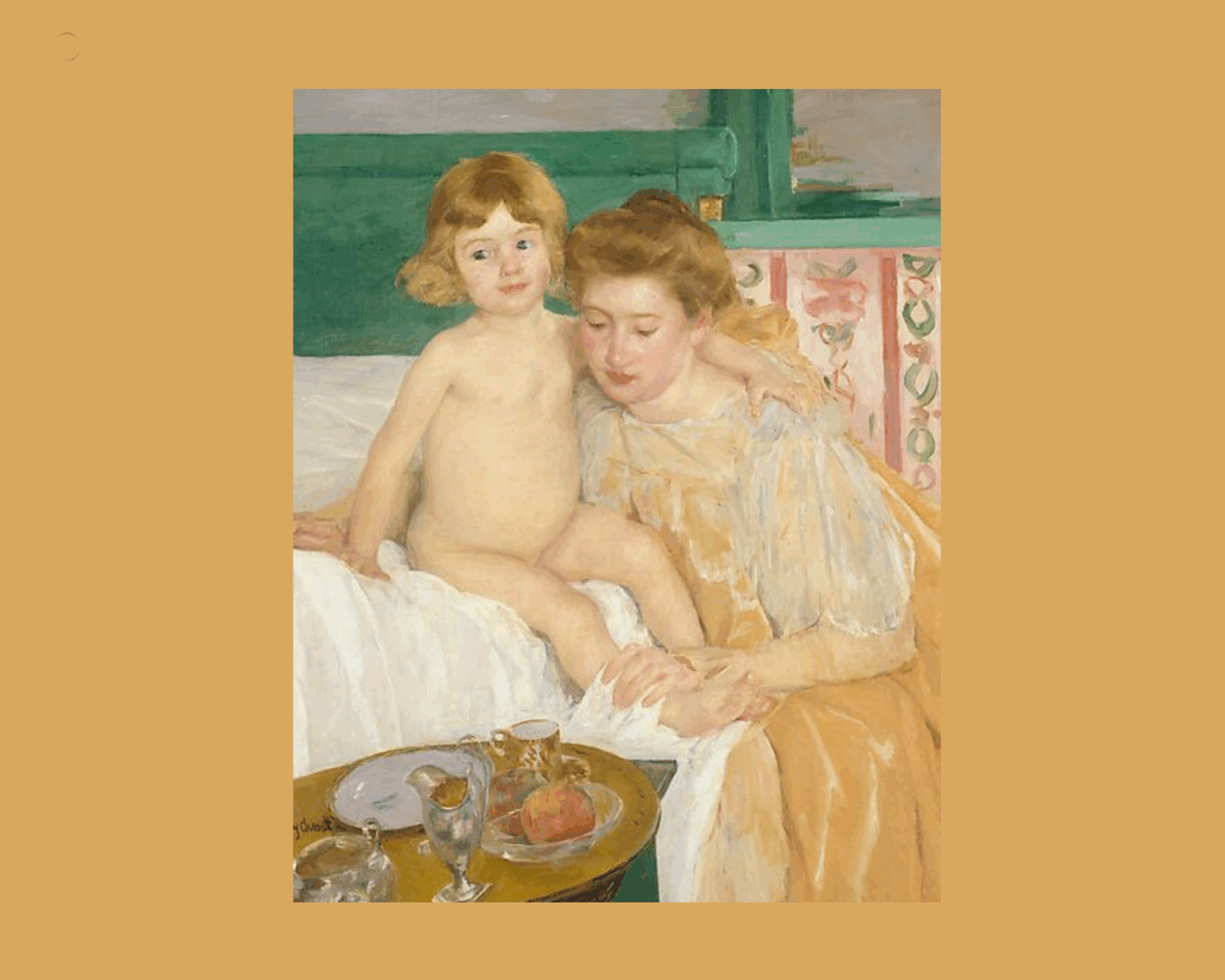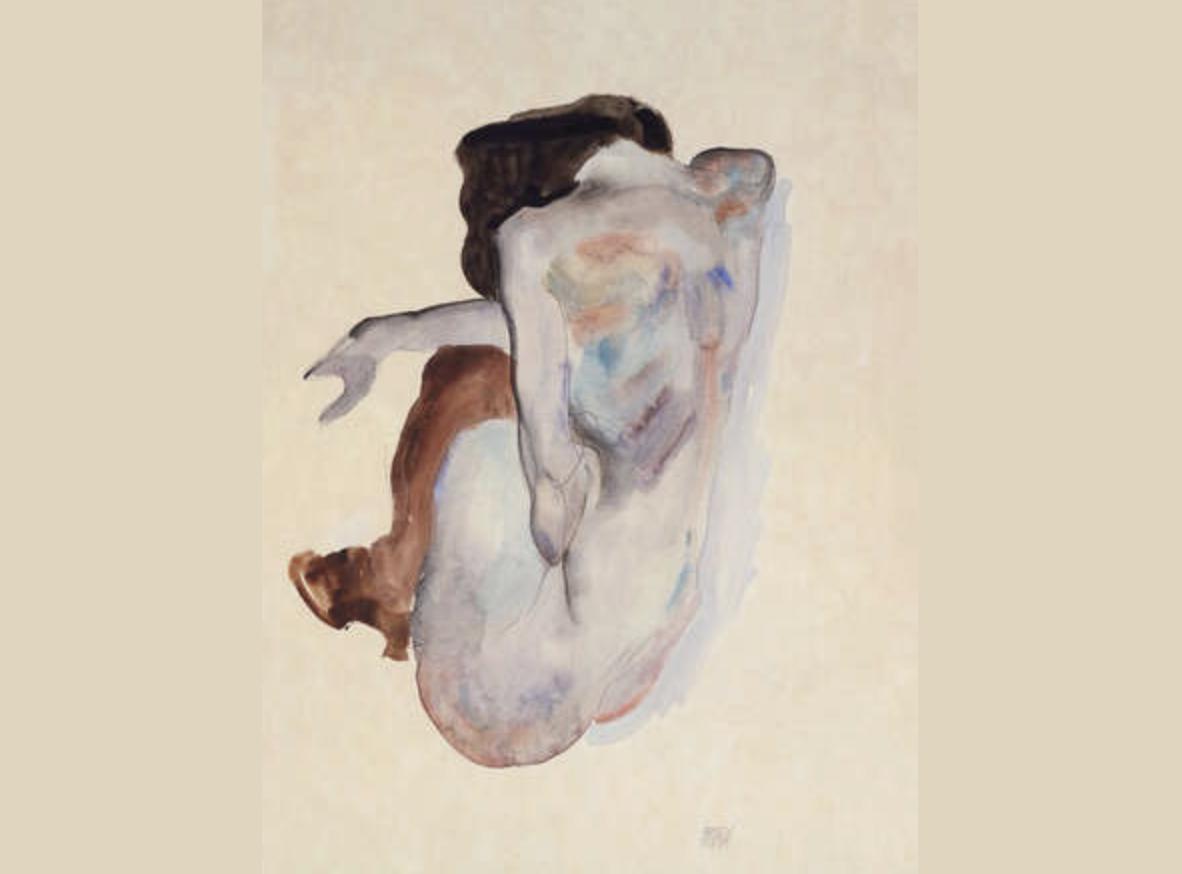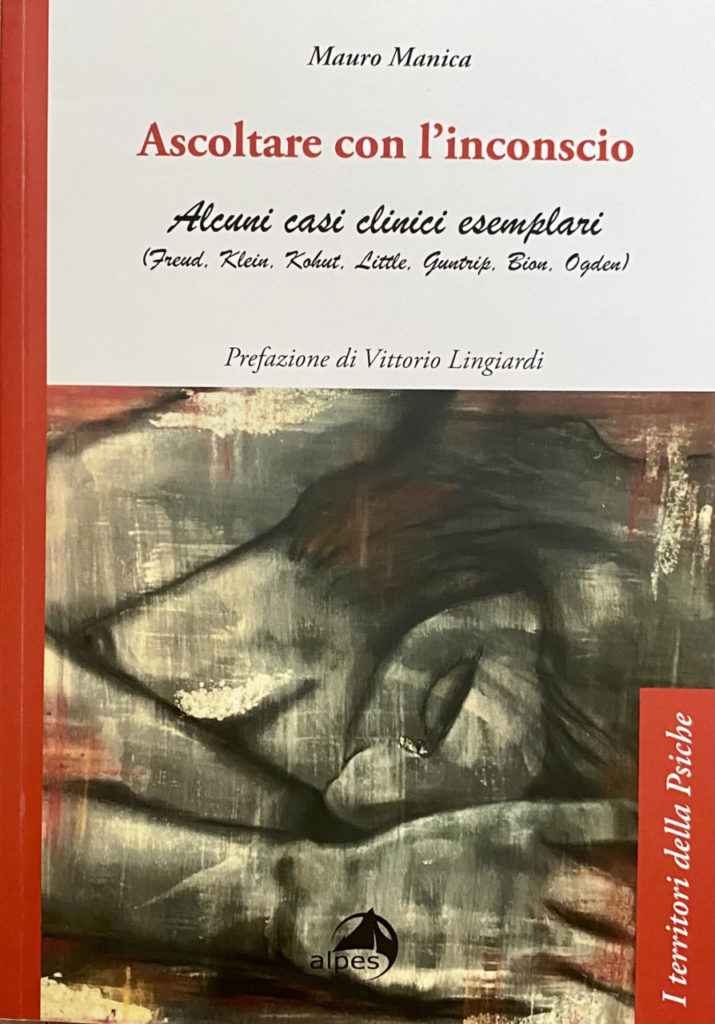Parole chiave: smartphone, ritiro psichico, social network, internet, giovani, realtà virtuale, relazioni, disagio
E’ diventato chiaro che l’uso eccessivo dei mezzi informatici può influenzare negativamente la vita in generale e, in particolare, quella relazionale e produrre cambiamenti nelle abitudini delle persone e sulle loro funzioni cognitive e affettive.
I genitori di oggi devono confrontarsi con continui dilemmi e con una logorante negoziazione con i figli sull’uso dei dispositivi elettronici. Questa forma di conoscenza diffusa e pratica rappresenta anche una delega allo strumento che cancella la necessaria riflessione personale.
Ma i media sono i mezzi moderni alla portata di tutti per chi vuole strutturare un ritiro psichico in cui rifugiarsi. In altre parole, l’abuso del mezzo informatico spesso è preceduto da difficoltà del ragazzo, che ricorre allo smartphone come una difesa dal disagio.
Riflessioni analitiche sulla dipendenza dalla rete informatica
FRANCO DE MASI
franco.demasi01@gmail.com
Lavorando come psicoanalisti si osserva con frequenza crescente che alcuni pazienti, soprattutto quelli giovani, intelligenti e sensibili oltre che sofferenti, trascorrono un periodo più o meno lungo della giornata collegati al cellulare o al computer e ritirati in una realtà alternativa e virtuale. Quando questo ritiro occupa gran parte della giornata possiamo parlare di una forma di dipendenza vera e propria.
Questo fenomeno si è accentuato durante la pandemia di Covid-19, in cui alcuni adolescenti si sono immersi nel mondo virtuale dello smartphone e hanno perso progressivamente il contatto con i coetanei. Nel corso dell’epidemia i ragazzi si sono iperconnessi per cancellare l’angoscia, ma l’isolamento e la mancanza della scuola, che è il luogo in cui gli adolescenti imparano a vivere le proprie emozioni, hanno provocato un aumento dell’ansia con un conseguente circolo vizioso tra questa e l’iper-connessione alla rete. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare eccessivi disturbi d’ansia, sono stati quelli più strutturati, che hanno mantenuto il rapporto coi coetanei.
La pandemia, che ha imposto un necessario isolamento sociale, ha così aggravato il ritiro di alcuni fra loro.
Nel campo sociale, politico e di igiene mentale si discute molto di questo problema, che riguarda soprattutto le fasce di popolazione più giovani.
E’ diventato chiaro che l’uso eccessivo dei mezzi informatici può influenzare negativamente la vita in generale e, in particolare, quella relazionale e produrre cambiamenti nelle abitudini delle persone e sulle loro funzioni cognitive e affettive.
Il compito della psicoanalisi sarebbe di descrivere il carattere specifico di questa nuova realtà, il suo potere sulla psiche e le ragioni per cui la mente è così facilmente seducibile. In altre parole, sarebbe opportuno indagare la qualità del piacere che cattura la mente e che rischia di interferire con lo sviluppo psichico ed emotivo dei giovani in particolare.
Nelle sedute siamo spesso molto preoccupati e impotenti di fronte a questi giovani isolati e senza una sofferenza apparente. Ne esistono alcuni alcuni, che finiscono per trascurare non solo le relazioni necessarie alla vita ma anche l’idea del loro futuro, condannati come sono a un’esistenza fatta di istanti che si succedono, priva di prospettive e di scopi.
Le nostre preoccupazioni si incontrano con le esperienze di alcune madri che seguono i loro figli con molta attenzione e che possiedono conoscenze specifiche sui media.
Queste madri devono affrontare un compito problematico, concedere lo smartphone al figlio per evitarne l’esclusione dal gruppo dei compagni, e al contempo limitarne l’uso solo per le necessità scolastiche o anche per quelle utili di svago o di socialità. In molti casi sono gravate dalla fatica di governare un processo che a volte rischia di esporre anche loro all’isolamento in confronto ad altre madri meno rigorose.
I genitori di oggi devono confrontarsi con continui dilemmi e con una logorante negoziazione con i figli sull’uso dei dispositivi elettronici.
L’introduzione dei media nella vita sociale, relazionale e intellettuale ha prodotto una rivoluzione silenziosa nel nostro modo di essere al mondo. Una trasformazione mai avvenuta nel campo della comunicazione e delle conoscenze tra gli esseri umani.
Ma questa forma di conoscenza è a doppio taglio. Da una parte è possibile ottenerla quasi automaticamente premendo un pulsante, ma dall’altra rappresenta una delega allo strumento che cancella la necessaria riflessione personale nella comprensione della realtà. Il rischio che ci minaccia, e questo vale specialmente per gli adolescenti, è quello di diventare degli automi sapienti dipendenti dal mezzo. Per questo motivo la mente dei giovani rischia di essere depositata nello smartphone.
Nello spazio di internet, infatti, non esistono confini: chi naviga si trova fuori da uno spazio determinato, in un ambiente potenzialmente infinito. Questa dimensione di un luogo virtualmente presente e senza confini fa dell’isolamento una peculiarità necessaria. Si può comunicare con tutti e con nessuno in particolare.
Purtroppo il pericolo maggiore riguarda gli adolescenti, la cui psiche è in continua formazione e indirizzata verso la maturità adulta, che corrisponde all’assunzione delle responsabilità e alla capacità di prendersi cura dei propri simili.
Nella nostra pratica clinica troviamo alcuni casi di sofferenza estrema, sono giovani che si sono letteralmente ritirati nello schermo e si sono immersi in una realtà dissociata dalla vita vera e dalle relazioni con i compagni o con la famiglia.
Un caso preoccupante è quello dei bambini che abbandonano la classe per il manifestarsi della fobia scolastica e rimangono a casa, rifugiandosi nel mondo virtuale alternativo, senza provare dispiacere per la solitudine in cui vivono. Il mondo virtuale assicura loro un piacere continuo e la mancanza di sofferenza per la perdita dei compagni e della scuola.
Naturalmente i casi che vediamo in terapia sono una minoranza ma sappiamo che negli ultimi anni ne affrontiamo sempre di più nei nostri studi.
Per arrivare a questi casi estremi occorre che molti fattori agiscano in concomitanza tra loro. Per prima cosa la tendenza del giovane sin dall’infanzia a una vita ritirata, quindi la mancanza di vicinanza psicologica da parte dei genitori, che sembrano non avvertire il rischio che sta correndo il figlio, e da ultimo il potere del mezzo informatico che crea dipendenza attraverso la stimolazione sensoriale.
Vediamo ora alcune delle trasformazioni nella comunicazione e nella vita di relazione avvenuta ad opera dei media informatici.
I cosiddetti social media hanno rinunciato alla loro iniziale funzione comunicativa e si sono orientati di più a radunare nelle loro piattaforme persone che necessitano di conferme e approvazione. Possiamo dire che si è passati dalla comunicazione all’esibizione. Da qui il fenomeno degli influencer che possono diventare tali in virtù del numero di like che ricevono.
In realtà comunicare per ottenere l’approvazione, come avviene per il numero di like che si ricevono, significa voler vivere nella mente degli altri, del maggior numero possibile di altri. Si è protesi nello spazio degli altri e si rinuncia al proprio sé individuale che è l’unico a sostenere la persona nelle inevitabili crisi della vita.
L’uso precoce dei social network da parte dei minori può influire negativamente sul loro rendimento scolastico.
I dati recentemente raccolti da un progetto ideato dal dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano lo confermano. Dallo studio emerge che l’uso dei media riduce l’impegno scolastico, come dimostrato dal risultato più modesto dei ragazzi che usano già lo smartphone. La ricerca ha messo in luce anche un dato interessante che riguarda le diseguaglianze fra le famiglie sulla consapevolezza dei rischi derivanti dal numero di ore in cui i bambini vengono lasciati con uno smartphone. Madri e padri con un titolo di studi più modesto non solo fanno trascorrere in media più tempo davanti al cellulare ai propri bambini, ma concedono lo smartphone prima.
L’invasione dei videogiochi è stata molto veloce. Non contrastati inizialmente dai genitori, perlomeno da quelli spaventati dall’idea che i figli potessero incontrare pericoli fuori casa, i videogiochi adesso sono ora messi in discussione per i pericoli evidenti che comportano.
Tra tutti gli strumenti informatici i videogiochi sono, infatti, i più idonei a indurre dipendenza da Internet. Ormai sono molto diffusi e molto vari, in modo da poter interessare più persone possibili.
Le interazioni sociali che gli adolescenti sperimentano con i compagni di videogiochi sono , inoltre, temporanee e superficiali. Con i cosiddetti “amici” con cui si gioca non si sviluppano relazioni intime e durature ma solo rapporti funzionali alla continuazione del gioco.
E’ possibile chiedersi perché i videogiochi siano così interessanti, visto che non si vincono soldi come nel gioco d’azzardo. Una risposta possibile sarebbe semplice: i videogiochi sono programmati per creare dipendenza. A differenza di chi guarda la televisione, l’utente non è passivo, ma interviene attivamente accettando sfide, superando ostacoli e portando a termine prove di abilità.
Il fatto di vincere, di ottenere un risultato, induce una gratificazione cui non si può rinunciare e che spinge a continuare. Il software registra i miglioramenti del giocatore e alza progressivamente il livello di difficoltà, così il gioco diventa sempre più stimolante e induce uno stato di euforia. Alcuni studi dimostrano che in questa situazione si spengono le aree del cervello responsabili della riflessione, mentre si attivano quelle della percezione sensoriale e dell’azione.
Quali sono i giovani più a rischio? Cosa gli succede? Cosa li rende diversi dagli altri? La loro dipendenza dallo smartphone è casuale o esiste in loro qualche predisposizione che la precede?
Per dare una spiegazione a questo fenomeno devo far riferimento al concetto psicoanalitico di ritiro psichico, che consiste in un distacco dalla realtà e nella creazione di un mondo, alternativo e segreto, che è appunto il ritiro.
Il mondo virtuale favorisce la vita nel ritiro perché la realtà sensoriale di Internet entra, si radica e prolifica nella mente dei bambini e degli adolescenti allontanandoli dalla realtà delle relazioni. Catturati dagli avvenimenti virtuali essi non sentono la mancanza degli amici reali, perdono il contatto con il mondo dele relazioni mentre sviluppano quelle virtuali.
Le esperienze affettivo-emotive, infatti, nascono e si sviluppano nel mondo tridimensionale, e non in quello bidimensionale del web, non sono per questo rappresentabili né possono essere vissute pienamente nella rete. Salvo in alcuni casi e per certi temi nella rete c’è scarso spazio per la condivisione dei sentimenti. E’ un mondo in movimento che, però, è scarsamente affettivo. La rete non è programmata per far sviluppare i bisogni emotivi e formativi, non è strutturata con questi obiettivi, ma, grazie a una sottile opera di manipolazione, si mostra come una stimolante arena della vita.
Non bisogna dimenticare anche l’invadenza della pornografia nella mente dei giovani. Lo smartphone oggi, con il profluvio dei video pornografici, ha anticipato il momento dell’ingresso del giovane nella sessualità con il rischio di fissarla a una modalità autoerotica.
Certamente la conoscenza della sessualità nell’adolescente ha sempre avuto un carattere non relazionale, era creata nell’immaginario, condiviso tra coetanei e mediata da racconti o dalle confabulazioni, ricavata da immagini di stampa o da cassette video.
Questo tipo di esperienza poteva essere una strada inevitabile per la conoscenza della sessualità e un’anticipazione per lo sviluppo di una sessualità relazionale. Oggigiorno l’esperienza della video pornografia, diversa dalla ricerca di nudità degli adolescenti del passato, rischia di essere per alcuni giovani un punto di arrivo, l’unica attrattiva possibile, con il pericolo di diventare una dipendenza drogata dal sesso.
Lo smartphone è uno strumento che permette una rapida realizzazione dell’aspettativa: un tocco su un tasto garantisce un concreto appagamento.
L’utente del web si trova, senza saperlo, nelle stesse condizioni di Ulisse, che corre il rischio di soccombere a Circe, la maga capace di sedurre gli uomini preparando farmaci che annullano la volontà e la consapevolezza. L’astuto Ulisse si protegge con una bevanda e, così facendo, non si trasforma in un maiale. Tutti noi corriamo questo stesso pericolo ma, purtroppo, non possediamo ancora l’antidoto.
Nel settembre 2024 decine di intellettuali italiani e personalità del mondo della pedagogia, della psicologia e del cinema hanno chiesto al nostro governo di vietare ai minori di 14 anni di avere uno smartphone e proibire agli under 16 di aprire un profilo sui social media. I danni per i bambini e le bambine, secondo i firmatari, dipendono in particolare dal fatto che l’interazione continua con gli schermi, oltre a produrre un deficit nell’apprendimento e nelle prestazioni scolastiche, impedisce ai bambini e agli adolescenti di vivere la vita reale e le esperienze che strutturano la mente.
Alla fine di novembre del 2024, dopo mesi di intenso dibattito, l’Australia ha approvato una legge per vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni. È diventata così il primo Paese al mondo a imporre un bando del genere ai più giovani. Altri Paesi, dalla Francia, agli Stati Uniti, dalla Norvegia alla Gran Bretagna, seguono con attenzione questa decisione che potrebbe essere il primo passo verso una consapevolezza globale sui danni causati dai social media agli adolescenti.
Non è facile stabilire regole di salvaguardia per la salute psichica delle persone che entrano in rete. Non mi riferisco ai traumi veri e propri, ma alle sottili penetrazioni, alle piccole suggestioni che modificano la psiche di vari individui. Sono modifiche lente e insidiose dipendenti dall’età e dal tempo trascorso nei media.
Più si è giovani e più tempo si trascorre su internet, più alti sono i rischi come l’insonnia, il deficit di attenzione, la ridotta comprensione della lettura, la sessualizzazione della mente, il cyberbullismo, e, il più grave, l’isolamento, ossia il ritiro psichico nel mondo virtuale.
Il problema non è salvare i bambini dagli effetti nocivi degli smartphone, quanto piuttosto comprendere che questi media hanno conquistato per anni la mente di noi adulti senza che avanzassimo qualche dubbio o qualche contrarietà.
Si tratta, dunque, di una presa di coscienza collettiva e intergenerazionale di grande dimensione, necessaria per salvare una scoperta sensazionale dal pericolo che venga usata in modo improprio a causa del narcisismo, dell’ esibizionismo, dell’avidità di potere e della vanità che caratterizza noi umani.
Bibilografia
De Masi, F.; Moriggia, M.; Scotti, G. (20209 Quando la scuola fa paura. Mimesis Edizioni.
De Masi, F. (2023) Il ritiro psichico: conseguenze nel bambino e nell’adulto. Rivista di Psicoanalisi, 2023, LXIX, 11.
Haidt, J. (2024) Una generazione ansiosa. Rizzoli 2024.
Lembke, A. (2021) L’era della dopamina. ROI Edizioni.
Spitzer, M. (2016) Solitudine digitale. Corbaccio 2016.