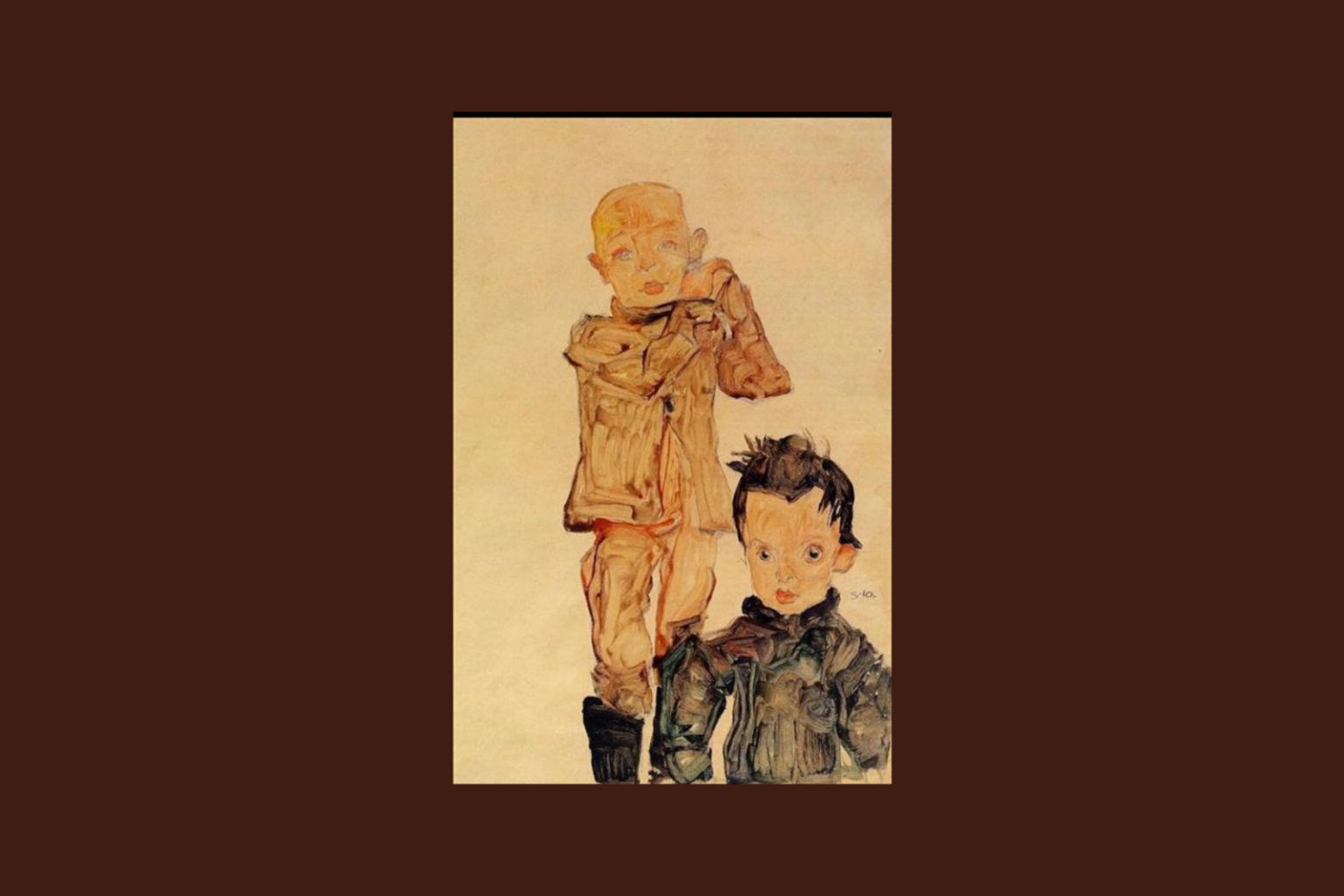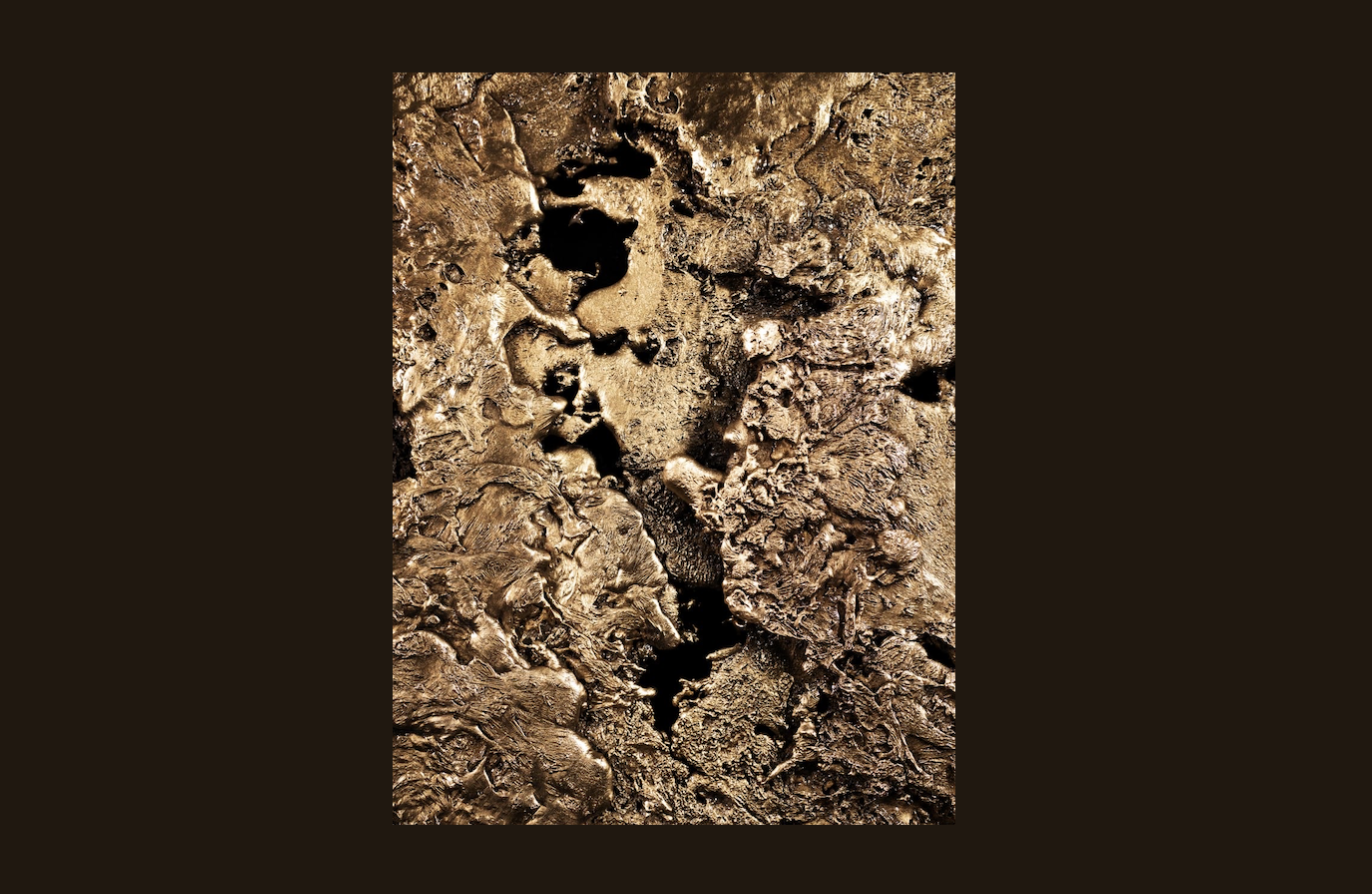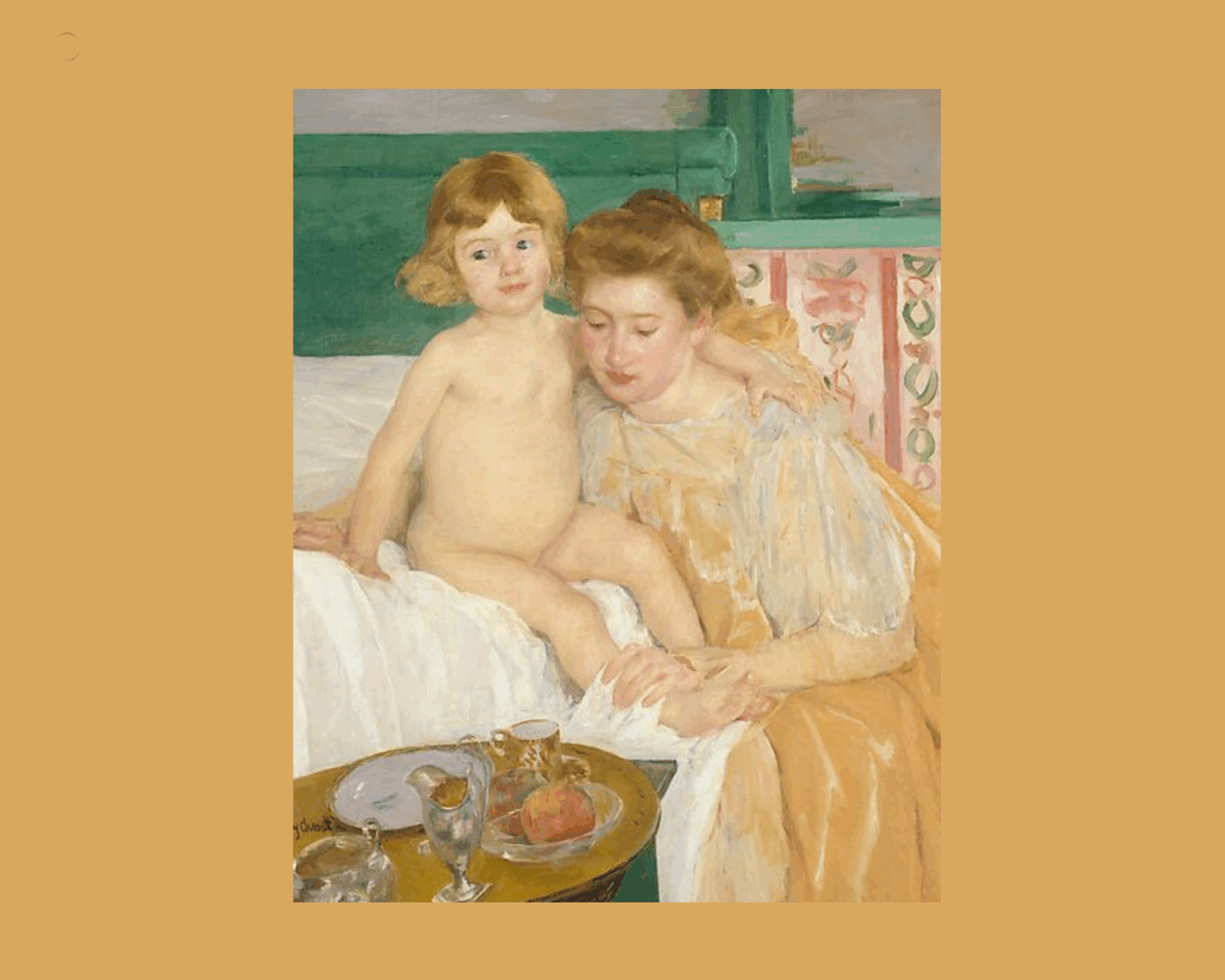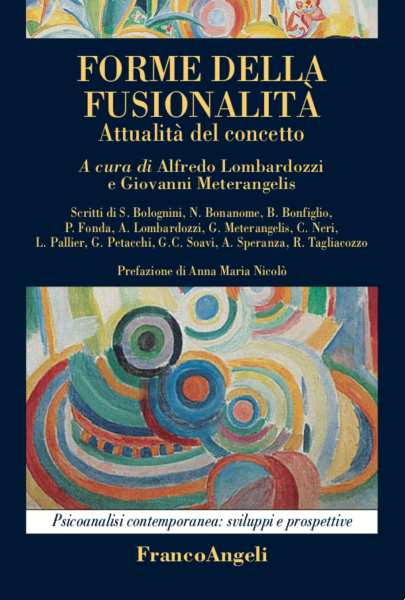L’angelo della vita. Segantini – 1894
Parole chiave: emergenza e creazione di oggetti, gradi di fusionalità, simbiosi, Bleger
Tra simbiosi e fusionalità
(note dal seminario di Bologna del 24 maggio 2025)
Questo seminario ha avuto soprattutto due progetti. Il primo è stato quello di tentare una definizione dinamica di due concetti che molto spesso nel lessico anche psicoanalitico sono usati come sinonimi. Il secondo, più complesso, sarebbe quello di indagarne possibili nessi e magari continuità. Proviamo a suggerire che entrambe le dimensioni riguardino il processo di emergenza e creazione di oggetti che si presentano nel campo analitico come dimensioni discrete che si pongono fra (legano?) analista e paziente a sostegno del procedere del processo analitico. La sospensione di una delle due dimensioni è uno degli elementi che comporta l’impasse del processo analitico.
Pertanto abbiamo colto l’opportunità di questo seminario per ampliare la riflessione attraverso lo scambio con altri colleghi interessati allo sviluppo di questo tema. In questa nota non è stato possibile riportare le proposte cliniche su cui, peraltro, si è molto articolata la discussione all’interno del Seminario di Bologna. Ce ne dispiace soprattutto perché la nostra proposta guarda soprattutto alle potenzialità cliniche dell’uso di questi concetti.
Il concetto di Fusionalità.
Il concetto di Fusionalità cosi come è stato teorizzato dai colleghi del Centro di Psicoanalisi Romano (Neri, Petacchi, Pallyer, Soavi, Tagliacozzo) nei loro lavori della fine degli anni 80, affrontava in una ottica sia teorica che clinica una sorta di “paradossalità”. Esiste ci dicono un comune denominatore, che può essere riconosciuto in una pressante richiesta, da parte del soggetto, di autonomia e contenimento: ” esiste un senso di attrazione nell’acquistare autonomia così è presente il sempre vivo desiderio della ritrovata fusionalità essere tutt’uno con la madre. Stato questo capace di elargire esperienze di estremo benessere e senso di realizzazione”, Questa concezione non era molto dissimile da quella verificata sperimentalmente da L. Sander (1980) (cit. da Bordi 1997) nel suo studio di “monitoraggio continuo della culla” nel quale venivano registrate le attività del neonato sia quando è unito alla madre, sia quelle di quando è separato da lei, con la sottolineatura dei momenti di dualità e quelli di singolarità. Durante questa fase il bambino è in contatto sia con il fuori che con il dentro di sé. Osservazione fatta anche da Emde (1990, citato da Bonfiglio) che , a proposito dell’osservazione della coppia madre-bambino, concorda sul fatto che “transitorie identificazioni che possono presentarsi in momenti di empatia richiedono un temporaneo senso di unità con l’altro, seguito da un senso di separatezza per poter risultare utili”. La Fusionalità non è mai stata considerata, nonostante il senso di attrazione verso l’altro, unicamente come una assenza di differenziazione, ma piuttosto come una condizione di: “ tranquillità, assenza di persecuzione, assenza di manipolazione, gioia, eventualmente stasi, assenza di falsificazione” (Pallier, 1990, 93) percezioni che rimangono nella memoria sensoriale come “tracce, mappe abitudini apprendimenti ben radicati che costituiscono un sistema inconscio del Sé” (Ginot, 2017) testimoni di un sufficiente accudimento nel quale le gratificazioni e le frustrazioni si alternano armoniosamente. Tracce che vanno a formare le prime basi di una costruzione rappresentazionale del sé in relazione all’altro. Ma veniva anche riconosciuto che “ il bisogno di fusione era anche ritenuto in rapporto dialettico con il desiderio, altrettanto vitale, di evolvere lungo il percorso di separazione-individuazione” (Moccia , Meterangelis 2011, 188), e come dice Soavi: “Esiste un’opposizione e una complementarietà tra le fantasie fusionali e i processi di individuazione…. La complementarietà va cercata nel fatto che la capacità di vivere fiduciosamente il momento di abbandono “a occhi chiusi” precede e rende possibili i processi attorno ai quali si organizzerà l’identità “ (1990, 97-98).
Questa idea richiama l’idea di Kohut che i bisogni di oggetto-sé permangono per tutta la vita. Questo punto di vista ha delle implicazioni nel trattamento analitico e cioè che la fusione e la differenziazione non sono in conflitto fra di loro, ma lavorano in una sinergia. L’autonomia dall’oggetto così come l’individuazione di sé stessi non si sviluppano attraverso la separazione dall’accudente nei primi anni di vita, ma avviene attraverso la conservazione di gradi di fusionalità. Uno dei ricercatori infantili più influenzato dalla psicoanalisi Lou Sander (2007) ha definito questa dialettica fusioneindividuazione con il concetto di “stato”, paragonando il bambino , l’accudente e l’ambiente nel quale vivono, ad un sistema vivente, non dissimile da tutti gli altri sistemi viventi. Un contesto nel quale è presente una adeguata organizzazione, che produce nel neonato una capacità di autoregolazione. Nel contesto si confrontano specificità alla ricerca di ciò che Sander chiama “corrispondenza di specificità”, ovverosia ricerca di risonanze di natura non solo affettiva ma anche di natura percettivo sensoriale. La “ corrispondenza di specificità” di Sander ci rende edotti del fatto che poiché le esperienze di parziale fusione e di differenziazione sono sempre presenti dall’inizio della vita, è possibile immaginare i confini del sé non come costruiti in maniera strutturale e lineare, ma come tendenti a presentarsi in uno stato di continuo cambiamento, in conseguenza del passaggio di stimoli dall’interno all’esterno dei propri confini, e , viceversa. Pertanto i confini possono presentarsi in condizioni di minore o maggiore porosità e fluidità. La rigidità dei confini, come la si ritrova nella simbiosi, è il risultato di non adeguati scambi fra il sé e l’altro. Sono, quindi, l’ adeguata alternanza fra uno stato fusionale ed un senso di separatezza le condizioni necessarie per un armonico sviluppo evolutivo.
Fusionalità nella relazione analitica
Loewald mette in evidenza l’esistenza di una relazione fra lo sviluppo infantile con la teoria della clinica psicoanalitica, ed individua i modi di entrare in relazione del bambino con chi se ne prende cura, e che persistono per tutto il corso della vita. Lo scopo dell’evoluzione così come quello della terapia analitica è quello di integrare senza confonderli questi due aspetti, “giocando” fra la spinta verso l’autonomia e la separazione e l’attrazione verso l’unità fusionale. Con il passare degli anni diversi Autori hanno riconosciuto questi punti di vista concependo lo sviluppo della struttura psichica attraverso modi di relazionalità, per cui l’individualità nasce in un contesto nel quale il bambino è impegnato attivamente nel suo ambiente di accudimento: “Il bambino influenza quell’ambiente tanto quanto ne è plasmato , per creare qualcosa di unicamente umano e simultaneamente specifico” (Seligman, 2018). Il bambino mostra una innata capacità di agire per influenzare l’ambiente di accudimento al fine di sperimentare piacere, e questa abilità appare essere una delle capacità di base nei bambini (Thelen 2005). Bolognini ha riconosciuto modi della mente di entrare in relazione con un’altra mente nel corso dell’intera esistenza: l’interpsichico, cioè l’assenza di confini fra i sé in relazione, assenza che permette, quindi, il passaggio dall’uno all’altro “in modo digeribile, ricevibile, metabolizzabile…… di alcuni elementi interni dell’altro che ci vengono trasmessi, o viceversa” (2021), condizione, questa, che, a nostro parere, caratterizza la fusionalità. P. Fonda (2019) ci rappresenta modelli di relazione fra il sé e l’oggetto, visti dal versante dello stato dei confini del sé, come “modalità di funzionamento interagenti fra di loro”. Il livello fusionale dove non ci sono confini fra i Sé e una moltitudine di elementi sensoriali, fluttua e si diffonde liberamente nello spazio comune. Un secondo livello di frammentarietà e separatezza dove i confini del sé passano da frammenti scollegati di separatezza, ad aree di confine ancora a maglie larghe, sino a confini abbastanza delineati, ma non da consentire il funzionamento di un vero spazio potenziale. Sino ad un terzo livello dove i confini del sé sono sufficientemente stabili dove si costituisce uno spazio potenziale che rende possibile la costituzione di un pensiero simbolico di cui è possibile, nello scambio, riconoscere l’appartenenza al soggetto o all’oggetto. Questa comunicazione che è in primo piano è possibile solo se sullo sfondo sono presenti le altre due forme di comunicazione.
Anche nella letteratura psicoanalitica internazionale è possibile rintracciare posizioni simili. Ogden (1989) ritiene che la mente è organizzata in modalità simultanee di relazione da quello contiguo-autistico a quello schizo-paranoideo, a quello depressivo. Mitchell (2000), seppure con un linguaggio diverso, ritiene che la mente organizza le nostre esperienze secondo schemi organizzativi e ne individua quattro. Modi che si sviluppano progressivamente passando da meno sofisticati e meno organizzati a livelli di maggiore organizzazione. Benjamin (2019) parlando di intersoggettività postula che il riconoscimento reciproco e la condivisione inizino nelle primissime interazioni preverbali, in cui le intenzioni si allineano o i sentimenti risuonano anche tra partner impari. Riconoscimento e condivisione vanno a formare il terzo che si presenta nel corso della vita sotto altre modalità di relazione, dal terzo ritmico a quello differenziante sino al simbolico.
La fusione creando la condivisione di spazi comuni e di apertura di confini fra i due sé, permetterebbe una comunicazione fra inconsci bypassando la coscienza. Molti, se non tutti, di questi contenuti finiscono in un inconscio non rimosso in attesa di rappresentabilità. Questo suggerisce che la fusione di per sé non è terapeutica, ma bisogna permettere alle precoci strutture relazionali, di acquisire un ruolo motivazionale, per trovare nelle prime relazioni di accudimento il contesto in cui svilupparsi e permanere attive nel corso dell’intera esistenza, e come tali essere mobilizzate nell’intervento analitico attraverso l’azione di fattori affettivi e attraverso l’interpretazione.
Quello che ci sembra utile sottolineare è che tutti gli Autori citati condividono la presenza dialettica di queste modalità affettive in ogni esperienza umana, modalità che mutano simultaneamente nel corso di tutta la vita, tutte considerate legittime, salutari e prevedibili..
Della Simbiosi verso la Fusionalità
Il concetto di Simbiosi ha assunto una caratteristica precisa nel funzionamento del processo analitico soprattutto a seguito delle posizioni di Josè Bleger, noto esponente del gruppo di kleiniani argentini facente capo soprattutto a Enrique Pichon-Riviere, impegnati nelle vicende sociali molto drammatiche di quel periodo della storia argentina. Comunque, c’è da considerare come il concetto di simbiosi non sia nuovo nella teorizzazione soprattutto delle fasi iniziali dello sviluppo e ricorra in alcuni autori precedenti – sempre soprattutto della linea kleiniana – che vedono la simbiosi come fase regredita di indifferenziazione dell’oggetto
La linea argentina, soprattutto con Bleger e poi i Baranger, risulta abbastanza nuova e specifica soprattutto introducendo da un lato il riferimento sociale e dall’altro la relazione bipersonale. In entrambi i casi la nozione di fondo è rappresentata dal concetto di “depositario”. E’ Enrique Pichon-Riviere che teorizza il concetto di “depositario” ovvero l’esistenza di una dimensione psichica, realizzata attraverso la dimensione “sociale” (la madre, l’istituzione, il corpo…) capace di accogliere le parti psicotiche della personalità altrimenti incontenibili. Il concetto di “depositario” è importante nella linea che cerchiamo di proporre perché si confronta e differenzia dinamicamente, a nostro parere, con lo stato di Fusionalità. Il depositario è il luogo della Simbiosi: accoglie le parti psicotiche della personalità indifferenziate prima che possa attivarsi la soluzione Schizoparanoide. A differenza del depositario che contiene la simbiosi, la fusionalità è uno stato dinamico in cui la difesa che si organizza attraverso la regressione simbiotica può evolvere nella esperienza di un O-Se che introduce ad una dimensione creativa. Nela simbiosi, invece, “l’elaborazione dell’oggetto agglutinato può essere fatta soltanto per ‘frammenti’, in una lenta discriminazione” (ibid., 119). Una prima differenza che possiamo cogliere fra modalità di funzionamento simbiotico e fusionale è quella che Bolognini (2021, 107) vede fra le mucose e la pelle. Le mucose mediano e permettono gli scambi fra l’interno e l’esterno, mentre la pelle segna una separazione ed avrebbe la funzione di proteggere l’interno dalle insidie dell’esterno. E’ singolare che Bleger faccia riferimento alla funzione pelle di Bick per descrivere la funzione del depositario e in particolare del setting.
Il concetto di depositario è servito per analizzare le dinamiche delle istituzioni (Bleger e Pichon-Riviere) e, quindi le “dinamiche del setting psicoanalitico” (1967). Oltre al setting un depositario delle parti psicotiche della personalità è “il corpo” che “ammalandosi” funziona come “buffer” (ovvero, mediato dalla terminologia chimica: tampone) della rottura psicotica che permette il silenziamento del rischio delle angosce psicotiche. Allo stesso gruppo appartengono Madelaine e Willy Baranger che negli stessi anni (1982, ma la teorizzazione parte dagli anni 1961-62) propongono il concetto di “bastione”, ovvero un luogo del campo analitico in cui paziente ed analista colludono inconsciamente per evitare la frustrazione della discriminazione. In sostanza, nella evoluzione verso la discriminazione Sé-Oggetto, il soggetto può sempre rifugiarsi in una dimensione di simbiosi dove il processo evolutivo della discriminazione si sospende a fini difensivi per mantenere quella che oggi chiameremmo la “continuità del senso di Sé”.
Sono evidenti, in queste premesse, le convergenze verso la posizione di Loewald di una “matrice indifferenziata”. Non sappiamo quanto Bleger conoscesse le posizioni di Loewald, (che comunque non compare mai nelle sue citazioni…), ma comunque lo stato di simbiosi ha caratteristiche dinamiche differenti. Per Bleger la simbiosi si discrimina attraverso il riconoscimento di elementi non-Io che, appartenenti all’Io, possono evidenziarsi nel momento in cui si segnalano (vengono riconosciute) come mancanti. Mentre per Loewald l’emancipazione dalla “matrice indifferenziata” si compie in modo evolutivo e non conflittuale attraverso l’acquisizione del linguaggio e mediata dalla funzione di un Io che non è un luogo della frustrazione Io/Realtà/Super-Io (Freud), ma un dispositivo di continua integrazione e di sintesi.
Proponiamo in modo sintetico alcune definizioni generali:
La fusionalità è uno stato della mente disponibile all’incontro con l’oggetto attraverso una espansione dei confini del Sé. Simbiosi è una relazione originaria con l’oggetto che inizialmente si configura come “nucleo agglutinato” dove non c’è differenziazione fra dentro e fuori, fra il Sé e l’oggetto, tra l’Io e il non-Io. Forse è utile, a questo punto, introdurre una distinzione tra fusione e fusionalità: “la fusione è l’operazione […] nella condizione di fusionalità si crea il potenziale relazionale per poter fare nostri alcuni elementi interni dell’altro che ci vengono trasmessi, o viceversa” (Bolognini 2021, 108).
Altro punto. Per Bleger il nucleo agglutinato (ovvero dove non c’è differenziazione) viene fatto coincidere con la “parte psicotica della personalità”. Sul piano clinico significa che nella condizione simbiotica paziente ed analista, regressivamente e difensivamente, non sono differenziati (gli acting-out e gli enactment segnalano ed incidono a questi livelli…) per poter poi, magari, procedere ad una differenziazione. La differenziazione, per Bleger, si compie secondo due modalità. Una, fisiologica, che permette la separazione graduale fra “aspetti diversi indistintamente fusi” e che definisce come “discriminazione”. L’altra sarebbe una separazione netta fra aspetti nevrotici e psicotici della personalità con persistenza, quindi di un “nucleo agglutinato” non fluido ma ben organizzato che rappresenterebbe (la persistenza de)la parte psicotica della personalità. Questa seconda modalità di differenziazione, con un termine non a caso preso dalla chirurgia, Bleger la definisce “clivaggio”.
Sappiamo che la fusionalità può anche assumere carattere difensivo (Neri et al., 1990) nei confronti di emozioni spiacevoli (invidia, abbandono o altre forme di fusionalità gravemente regressive). A differenza della simbiosi, la difesa attraverso la fusione si ottiene rintracciando un oggetto (interno o esterno) o un contesto che permetta di evitare il riconoscimento della emozione o esperienza spiacevole, ma rimane un modo di essere del soggetto senza che queste modalità di risposte fusionali si strutturino in modo patologico. La simbiosi, invece è una modalità di funzionamento che fisiologicamente evolve verso una discriminazione Io/Non-Io oppure può organizzarsi secondo varie modalità di relazione indiscriminata con l’oggetto (ambigua, fattica, psicopatica, manichea). In sostanza la simbiosi segnala falle nella strutturazione della personalità, con prevalenza a vario titolo di persistenza di nuclei psicotici, mentre la fusionalità è da considerare come un funzionamento “anti-simbiotico”, una modalità di risposta ad esperienze frustranti o traumatiche.
Può essere utile riflettere su una progressione che implicitamente Bleger propone nel passaggio dalla Simbiosi alla Fusione: “La confusione non è propria dell’oggetto agglutinato, ma è uno stato che insorge quando l’Io viene invaso. L’oggetto agglutinato non è confuso, ma indiscriminato; quando però non è più immobilizzato o controllato diventa un oggetto che confonde” (87). Mettiamo in evidenza come, nella linea della nostra tesi, nella progressione dalla Simbiosi alla discriminazione, il passaggio sia attraverso la con-fusione che Bleger descrive come “uno stato dinamico
A differenza di quanto propongono Mahler, Tustin, Fachinelli, la posizione fusionale non deve essere superata, ma si tratta di una posizione di attesa e ricerca di oggetti con cui stabilire una relazione che comporta la ripresa di vitalità “che possa permettere poi momenti fusionali con oggetti esterni diversi, non necessariamente persone quali natura, arte, studio. Ritengo sia una delle mete da raggiungere oltre a quella dell’identità separata, e non da eliminare attraverso l’analisi” (Pallier, 94). Quindi, una ulteriore riflessione potrebbe essere che, a differenza di quanto la psicoanalisi classica propone per la fine dell’analisi, la fusionalità potrebbe descrivere una diversa modalità di fine analisi dove la dimensione di fusione potrebbe essere, oltre che un goal dell’analisi, anche una esperienza che l’analizzando (e l’analista?…) potrà recuperare positivamente in situazioni di frustrazione o traumatiche.
Infine. Possibili prospettive
Sul versante della Simbiosi, a differenza che nella clinica della fusionalità “il lavoro analitico ha una funzione antisimbiotica, ma esige in partenza una situazione di simbiosi sicura ed affidabile” (Bleger, 31). Pertanto, mentre per i clinici che vedono la fase simbiotica come una fase da cui emanciparsi, Bleger si pone alla intersezione fra quella che possiamo chiamare simbiosi difensiva e fusionalità evolutiva. Ovvero l’analisi deve muoversi verso il superamento della dimensione simbiotica, ma ha bisogno di riconoscere la dimensione di stabilità rappresentata da “una simbiosi sicura ed affidabile”
La possibilità che la simbiosi abbia una evoluzione felice e non ambigua (ovvero una cristallizzazione patologica) è nella funzione del setting, ovvero, nella linea della “funzione pelle” di Bick, un dispositivo capace di farsi carico e contenere in modo processuale le parti psicotiche della personalità che, quindi, attraverso la funzione depositaria del setting/pelle/istituzione, non evolvono verso le dimensioni ambigue, ma potremmo sostenere noi, fusionali.
Riferimenti bibliografici
Baranger W., Baranger M., Mom J. M. (1982). Processo e non processo nel lavoro analitico, in Baranger W., Baranger M. La situazione psicoanalitica come campo bipersonale, Cortina, Milano, 1990.
Bleger J. (1967). Simbiosi e ambiguità, Lauretana, Loreto, 1992. (il volume è stato poi ripubblicato da Armando, Roma, 2010)
Bolognini S. (2021). La fusionalità l’interpsichico, in Lombardozzi, Meterangelis (a cura di), cit.
Civitarese G. (2023). Sul concetto di intersoggettività in psicoanalisi, Psicoterapia e Scienze Umane, 57:3.
Fonda P. (2021). La fusionalità, in Lombardozzi, Meterangelis (a cura di), cit.
Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo, O.S.F., 7.
Gaddini E. (1982). Il Sé in psicoanalisi, In Scritti, Cortina, Milano, 1989.
Ginot E. (2015). Neuropsicologia dell’inconscio, Cortina Milano, 2017.
Lombardozzi A., Meterangelis G.,(a cura di) (2021). Forme della fusionalità. Attualità del concetto, Angeli, Milano.
Neri C., Pallier L., Petacchi G., Soavi G.C., Tagliacozzo R., (1990). Fusionalità. Scritti di psicoanalisi clinica, Borla, Roma.
Petrilli M. E., Rossetti M.(1992). Introduzione all’edizione italiana, in Bleger (1967) Simbiosi e Ambiguità, cit.