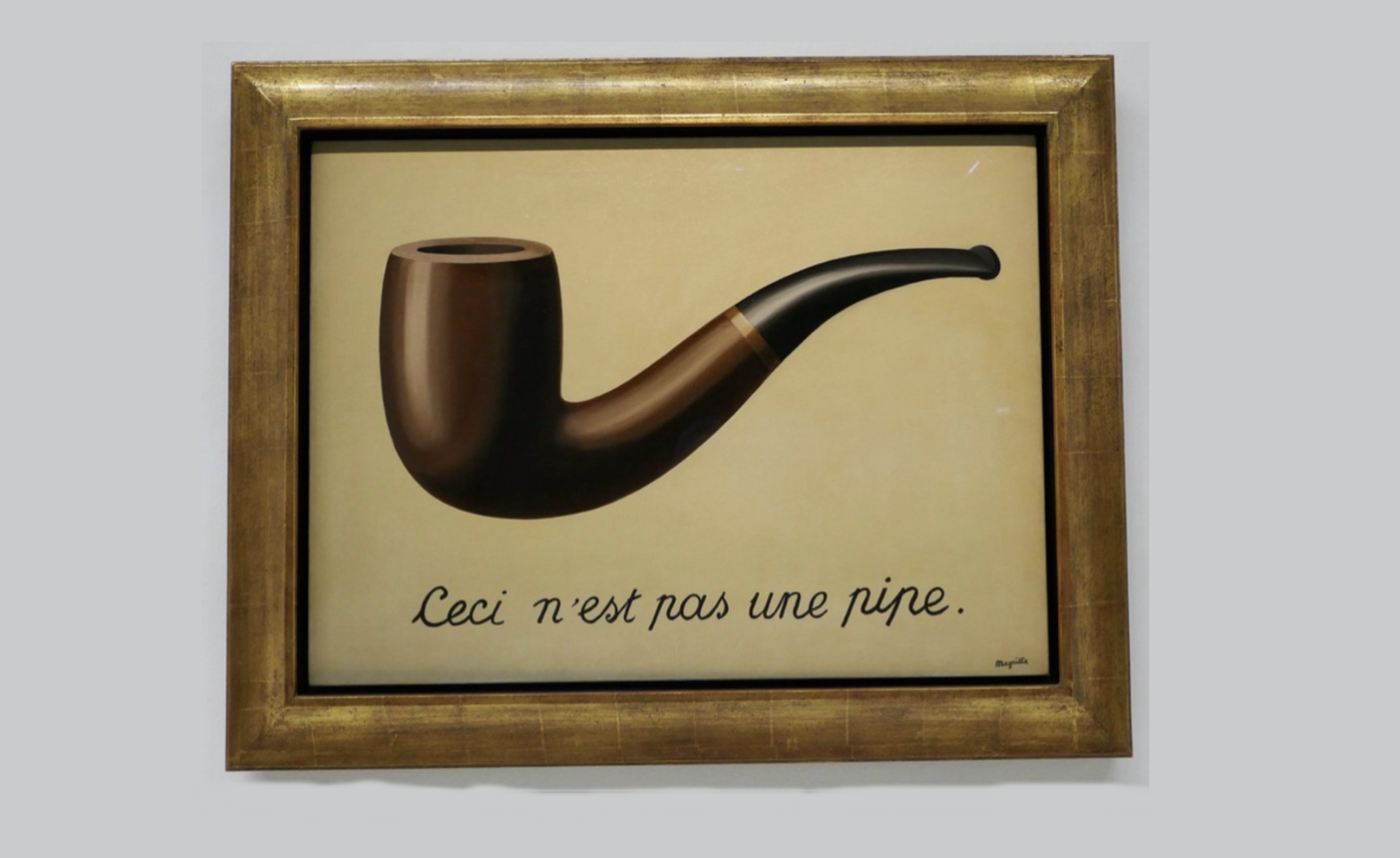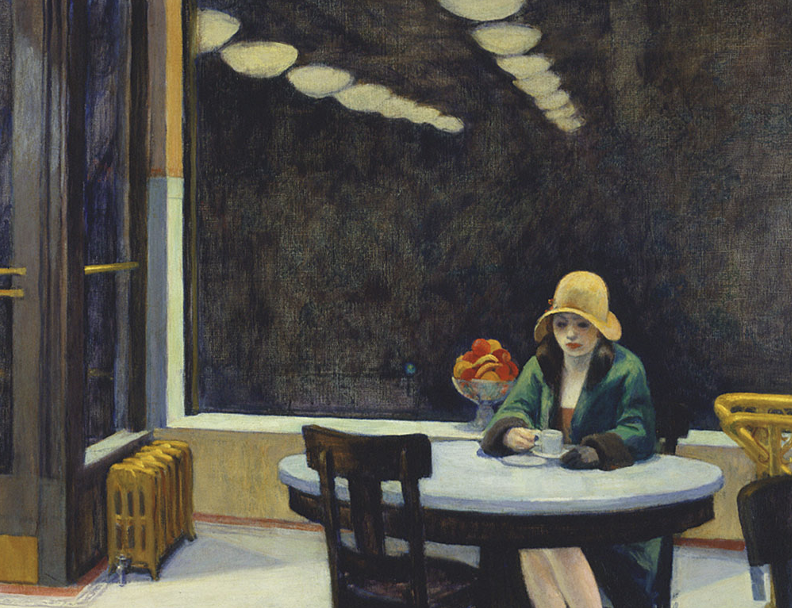
Parole chiave: violenza assistita, tutela dei minori, genitorialità, riparazione
Nelle giornate del 31 maggio e 15 giugno 2023 a Novara e dell’8 e 21 giugno a Torino, si sono svolti gli “Incontri di preparazione al convegno sulla compatibilità della applicazione della giustizia riparativa ai reati di violenza di genere: elaborazione di esperienze personali e di gruppo” incontri in cui, relatori di diversa provenienza professionale, hanno illustrato esperienze e problematiche utili a valutare il quesito proposto da differenti punti di vista.
Questo contributo, presentato dalla dott.ssa Palaziol al Convegno, permette diversi spunti di riflessione. Senza pretesa di esaustività ne indico solo alcuni. Palaziol parte dal punto di vista delle vittime (donne e bambini) e della riparazione secondo il modello della Giustizia riparativa. Questo la conduce a una critica, assolutamente fondata, degli automatismi con i quali la Giustizia Civile commina interventi “riparativi” che si rivelano spesso delle “vittimizzazioni secondarie”.
La prima osservazione critica di Palaziol è proprio sulla standardizzazione degli interventi, rivolti a ristabilire una continuità relazionale a volte senza una reale, precedente, comprensione della relazione tra persecutore e vittima e, pressochè in tutti i casi, senza che il bambino sia stato aiutato a capire cosa sia realmente accaduto e come un genitore, a volte profondamente amato, possa essere anche un abusante e un violento. In tal modo la “riparazione” è impossibile.
Altro tema toccato è “la confusione delle lingue”, in cui il suggerito riferimento a Ferenczi (1932) è inevitabile e necessario. Confusione tra conflitto e violenza, tra un comportamento vitale e uno mortifero, tra normalità e reato. Ma forse tale chiarezza deve, necessariamente, essere lasciata agli organi giudicanti e non agli operatori che operano, o dovrebbero farlo, secondo un principio di “beneficità” che deve, necessariamente, basarsi su un principio di “legalità” che spetta però ad altri definire (questione complessa e controversa sulla quale, attualmente, non è facile discutere).
Infine la dott.ssa Palaziol segnala quelli che potremmo definire i preconcetti patologici o “in mala fede”, che infestano le discussioni sulla violenza di genere per cui anche l’evidenza, ribadita dalla Cassazione, che chi è violento non può definirsi come un genitore adeguato viene, spesso, banalmente, ignorata.
Un intervento breve, quello di Loredana Palaziol, che solleva molti interrogativi sia per noi psicoanalisti sia per il mondo della giustizia.
“Violenza di genere e vittimizzazione secondaria: riflessioni su giustizia riparativa, processo civile e tutela psicologica dei minori” [1].
Loredana Palaziol [2]
Vorrei, con questo mio contributo, provare a riflettere insieme sul concetto di giustizia riparativa nei procedimenti civili di separazione e divorzio, in cui uno dei genitori è un violento e il minore è vittima diretta o indiretta delle condotte di maltrattamento agite in famiglia.
Il punto di partenza è il concetto di riparazione, nodale nella giustizia riparativa in ambito penale (con l’obbiettivo di rimediare alle conseguenze lesive delle condotte), che considero nel suo significato psicologico, con lo sguardo rivolto ai minori vittime di violenza assistita, ponendo degli interrogativi sulle modalità del percorso giudiziario che li coinvolge e che dovrebbe aiutarli a ricucire le ferite, e a significare le dissonanze affettive e cognitive sperimentate in tale contesto doloroso.
Ogni situazione deve essere affrontata nella sua specificità e non con l’applicazione di formule o cliché precostituiti, ma per esigenze espositive il mio discorso sarà necessariamente generale.
Il difficile percorso che porta la donna a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria non si conclude con la denuncia poiché proprio da qui inizia un cammino, della durata di anni, che la vede coinvolta con i figli in vicende processuali nelle quali la Consulenza tecnica per la valutazione della genitorialità delle parti assume un ruolo determinante, anche nel produrre quell’effetto collaterale noto come vittimizzazione secondaria, affrontato, per la sua rilevanza, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere nella precedente legislatura.
Le stesse procedure istituzionali, taloraconnotate da cattive prassi professionali, costringono infatti la parte offesa di un reato a rivivere le condizioni della sofferenza a cui è stata sottoposta con l’ulteriore effetto di scoraggiare le denunce.
La Commissione citata ha evidenziato, nelle Consulenze tecniche disposte per la valutazione della genitorialità, una serie di errori che potremmo considerare tipici, perfettamente illustrati dalla relazione La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale (aprile 2022).
Le criticità descritte sono molto interessanti e tutte completamente condivisibili sulla base dell’esperienza. Mi limito a segnalarne una, su cui si innestano diverse conseguenze: l’utilizzo di un linguaggio confusivo che, non distinguendo la violenza dal conflitto familiare, si presta a mistificare la realtà osservata arrivando a negarla, definendola conflitto.
Per il giurista la violenza è un reato, per il clinico sposta la relazione dal conflitto alla perversione relazionale. La sopraffazione, il dominio sull’altro de-umanizzato e non riconosciuto nella sua alterità di persona, il controllo della relazione con la minaccia e il terrore, il soggiogamento fisico, spesso accompagnato a quello psicologico, non sono conflitto; la confusione attraverso il linguaggio determina una re-interpretazione della vicenda familiare e giudiziaria secondo il paradigma “conflitto-litigio”, che vede aprirsi lo spazio alla teoria della provocatorietà della donna, al ridimensionamento degli agiti violenti o addirittura alla loro esclusione dalla valutazione peritale.
In questi casi la genitorialità viene valutata come se fosse un costrutto, sia clinico, sia giuridico, che può prescindere dalle reali condotte dei genitori e dalla qualità delle stesse nei confronti dei figli.
Questa metodologia si traduce in proposte operative, rivolte ai minori, idonee ad affrontare le situazioni di conflitto genitoriale, ma non altrettanto, a mio avviso, quelle di violenza: affido condiviso, collocazione presso la madre (non sempre così scontata), ampia frequentazione del padre (spesso per periodi variabili in luogo neutro), a volte, sin da subito, con l’introduzione di pernottamenti con il genitore violento non collocatario, e il progetto di una liberalizzazione di incontri, in tempi brevi, per salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità.
Un approccio all’insegna di una supposta necessità di ripristino di contatti, che dovrebbero favorire il mantenimento del legame, a prescindere dalla qualità dello stesso.
Tali procedure, largamente diffuse, non considerano a sufficienza l’esigenza di avviare un processo psichico di “riparazione” del danno inferto e subito: un processo che dovrebbe riguardare il maltrattante e, parallelamente, il minore, prima di poter realizzare un incontro tra di loro.
Si tratta di soluzioni che si prestano a sollecitare difese disfunzionali nei minori, favorendo allo stesso tempo anche la “negazione” in quei soggetti violenti che non riconoscono il disvalore dei loro atti e la loro responsabilità nella sofferenza causata ai figli e alla madre; soluzioni in cui l’incontro in luogo neutro con l’autore dei maltrattamenti avviene all’insegna del come se nulla fosse accaduto. Possiamo pensare che questo favorirà una relazione sana genitore-figlio?
Dovremmo domandarci che cosa succede nella mente di un bambino che incontra il genitore maltrattante, come se nulla fosse successo, in sedute “di gioco e due chiacchiere” in luogo neutro, dopo l’esperienza traumatica che glielo ha fatto percepire come “un mostro” e senza che nessuno si sia occupato di aiutarlo a comprendere la sua esperienza.
Dovremmo anche preoccuparci dell’attivazione di difese di scissione nella mente di questi bambini, ai quali chiediamo, senza un tempo e un aiuto adeguato, di mettere insieme il padre che ride e scherza con loro e il padre che colpiva per terra la loro madre tra urla e sangue.
Il punto diventa: come aiutarli, senza colludere con le difese del genitore violento? Come inventare un percorso riparativo che introduca per loro la figura del testimone soccorrevole, mirabilmente descritta dalla psicoanalista Alice Miller? Quando e come pensiamo di poter accogliere il racconto e il vissuto dei minori per aiutarli a dare significato all’esperienza violenta? Se è vero che la mente soffre quando non capisce, quando non è in grado di dare un senso, questo passaggio non possiamo continuare a ignorarlo.
Purtroppo, ciò che oggi accade è che il peso della riparazione, in troppi casi, sta tutto sulle fragili spalle dei bambini, ai quali non è consentito di capire, ai quali viene chiesto di agire incontri col genitore violento, anche grazie a stereotipi sui quali dovremmo riflettere, che ci dicono che un genitore maltrattante può essere un buon genitore “perché non ha mai picchiato il figlio, ma solo la madre”.
Vanno allora pensate anche adeguate condizioni perché quest’ultimo possa riavvicinarsi al figlio con la consapevolezza e la responsabilità del danno inferto, che di certo non si acquisiscono nei tempi brevi molto spesso applicati nel rispetto di un malinteso diritto alla bigenitorialità, trascurando così un dato di sconcertante evidenza clinica e giuridica: “Un genitore violento con l’altro, non può essere considerato un buon genitore, avendo esposto i figli alla violenza assistita, e avendo veicolato un modello educativo distorto e che l’ordinamento ha il dovere di censurare” (Massimario della Cassazione – commento alla riforma Cartabia).
In situazioni complesse come quelle descritte è fondamentale la presenza di operatori preparati e consapevoli della realtà clinica e giudiziaria che stanno affrontando, delle sue peculiarità, tra le quali, come psicoanalista, non posso non evidenziare l’importante sollecitazione emotivo-affettiva che i casi trattati innescano, soprattutto a livello inconscio: l’attivazione negli operatori (non solo nei genitori e nei minori), di difese che occorre saper riconoscere e gestire, che rischiano di oscurare la capacità di ascolto e di identificazione sia con la vittima, sia con l’autore.
In particolare, le difese di negazione e di scissione portano a non considerare gli aspetti del penale presenti nel fascicolo (“questo non c’entra”: scissione) e a minimizzare gli eventi, a negare la violenza, a interpretarla come conflitto di coppia, a invertire i ruoli, colpevolizzando le vittime (negazione).
È estremamente difficile identificarsi col dolore dell’altro (vittima), ma anche con la perversità dell’autore e la sua pericolosità, all’interno di storie che non sottostanno a trame rassicuranti come ci piacerebbe. Non è rassicurante, infatti, incontrare la “banalità del male”, non è rassicurante ammettere la sua difficile prevedibilità e non è facile rinunciare alla colpevolizzazione della vittima che, implicitamente o esplicitamente, viene considerata come colei che doveva accorgersi del potenziale maltrattante del suo compagno e non lo ha fatto a causa delle suefragilità: il peccato originale delle vittime, ovvero perché ha scelto proprio quell’uomo?, il testo non scritto di troppe vicende giudiziarie.
Concludo con un pensiero ancora di Alice Miller (Riprendersi la vita, 2007): “Non si può sfuggire ai propri genitori e quindi non si ha il diritto di smascherarli. In questo modo, essere ciechi consente di sopravvivere. Così funzionano, da sempre, gli abusi perpetrati sui bambini: far finta di non vedere e perdonare consentono di sopravvivere, ma troppo spesso portano a ripetere quei maltrattamenti e a danneggiare altri innocenti”.
Bibliografia:
Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza di genere –La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, aprile 2022.
Mannozzi,G., Lodigiani,G.A., Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, 2015.
Miller, A., Riprendersi la vita. I traumi infantili e l’origine del male, Bollati Boringhieri, 2009.
Miller, A., Il bambino inascoltato. Realtà infantile e dogma psicoanalitico, Bollati Boringhieri, 1989.
Patrizi, P., La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità, (nuova ed.) Carocci, 2024.
[1] Liberatoria:
L’editore e il Consiglio Direttivo dell’Associazione autorizzano la pubblicazione dell’articolo sulla rivista on line della Società Psicoanalitica Italiana, purché venga indicata la fonte, ossia il titolo dei volumi “Violenza di genere, giustizia riparativa, ascolto e comunicazione. Una sfida possibile?” a cura di Marilinda Mineccia, ed. 2025 Tipografia Duc, realizzati dalla Associazione di Studi e Ricerche di Psicologia Giuridica.
[2] Loredana Palaziol è psicologa – psicoterapeuta, psicologa forense e psicoanalista (membro associato della Società Italiana di Psicoanalisi e dell’International Psychoanalytic Association). E’ Professore a contratto di Psicologia clinica in ambito giuridico presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. È stata membro della Consulta psico-forense dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2015 al 2019.
Ha pubblicato alcuni contributi rivolti agli aspetti metodologici e deontologici dell’attività clinico forense. È consulente tecnico e perito del Tribunale di Torino. Come consulente tecnico di parte e psicoanalista, si occupa di donne vittime di violenza.
Vedi anche: Giornata Psicoanalisi e Giustizia 26 ottobre 2023