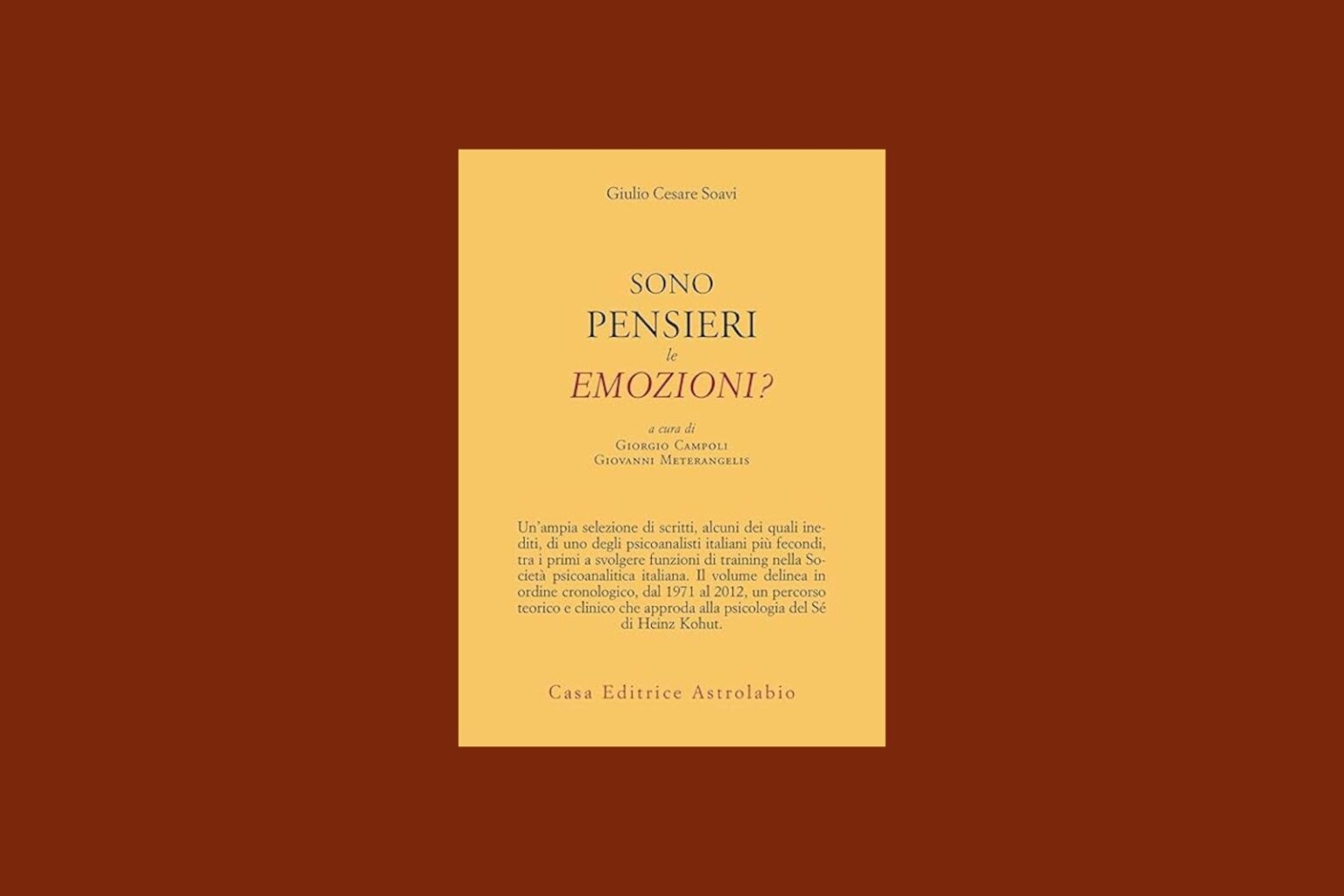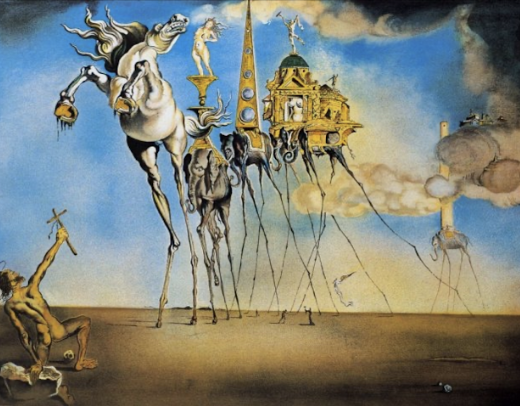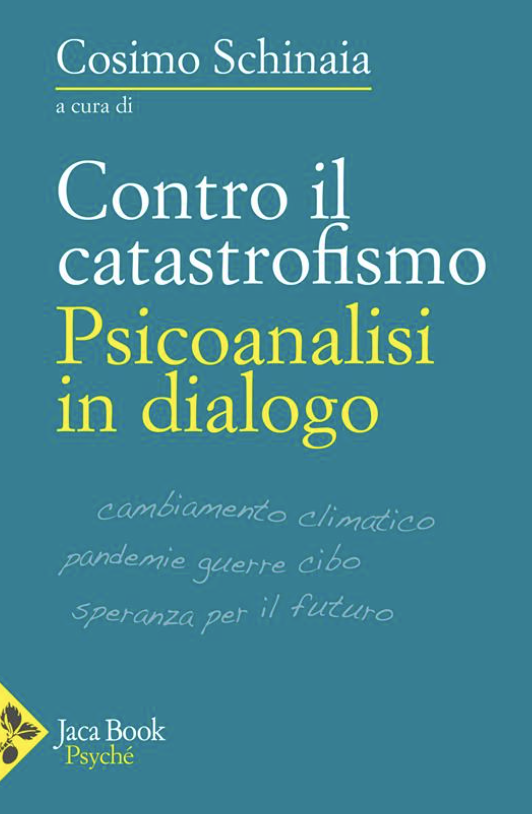
Parole chiave: Psicoanalisi, Catastrofismo, Simbolizzazione collettiva, Caducità, Speranza
Caducità radicale
Psicoanalisi, speranza e politica ai tempi della crisi planetaria
Di Tommaso Romani
Gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone.
Ci possono permettere di batterlo temporaneamente al suo stesso gioco,
ma non ci metteranno mai in condizione di attuare un vero cambiamento.
Audre Lorde
Ci sono scritture che nascono dal desiderio di riparare, di cucire lacerazioni simboliche, di trovare parole sufficientemente porose da contenere il trauma del presente. Scritture che non pretendono di guarire, ma si lasciano attraversare dalle faglie, ne fanno dimora. Il libro di Cosimo Schinaia, Contro il catastrofismo, appartiene a questa genealogia discreta e necessaria: è un gesto lucido e generoso che tenta di dare forma al disorientamento affettivo e cognitivo che attraversa il nostro tempo, un tempo in cui la crisi climatica, il collasso culturale e l’iperproduzione di “contenuti” convivono con una coazione al disconoscimento sistemico. Dove il trauma, più che evento, è struttura; e dove la cura non può che essere una pratica collettiva di dis-identificazione dal noto.
Schinaia non cede né al catastrofismo paralizzante né a una nostalgia regressiva. Muovendosi con rigore e grazia tra riferimenti psicoanalitici classici e aperture verso saperi altri — che non fanno da ornamento, ma da perturbazione — delinea i contorni di una speranza “costruttiva”, intesa non come escatologia positiva ma come forza immaginativa capace di accompagnare la trasformazione, senza però illudersi di neutralizzarne la complessità, senza cedere alla tentazione dell’armonia. Freud, Bion, Ogden, Bloch e tanti altri: le voci evocate nel testo compongono un’architettura leggera e accogliente, che trattiene e fa respirare. Una casa temporanea, una capanna simbolica, mai una fortezza.
Chissà se una capanna, poi… come quella della scena finale del film Melancholia, che ospita Justine, Claire e Leo, il piccolo nipote, in attesa che un gigantesco pianeta blu, figura del fuori assoluto, si schianti distruggendo la Terra. Se non una via di fuga, almeno un’uscita.
Eppure, è proprio in questo equilibrio — elegante, commovente, umanista — che può aprirsi anche una zona cieca. Perché viene da chiedersi: è davvero ancora possibile “costruire” la speranza? E quale speranza, per chi, in che corpo, su quale terra, con quale memoria? Non tutte le soggettività possono permettersi lo stesso accesso all’immaginario del futuro. Non tutti i corpi sono ascoltati quando tremano. E non tutte le terre sono sfondo neutro: molte sono già sfruttate, scartate, avvelenate, ontologicamente colonizzate.
Il rischio, forse, è che la speranza proposta da Schinaia possa sembrare, a tratti, ancora troppo universale, ancora troppo affidata a una simbolizzazione pacificata, quando invece il presente ci chiede di pensare a partire dalla crepa, dalla ferita, dal rifiuto come materia prima di nuove alleanze.
Ciò che ci serve, infatti, non è una simbolizzazione sobria, rassicurante, ma un pensiero che risenta del collasso, che ne porti le cicatrici. Un pensiero posizionato, attraversato, capace di nominare con lucidità il problema, senza ritrarsi di fronte alla violenza sistemica che lo costituisce. Vedremo perché.
Donna Haraway lo dice con forza: non si tratta di sognare un mondo perduto, ma di restare con il problema, di abitare la tossicità, di costruire alleanze tentacolari che non redimono ma contaminano, non salvano ma infettano.
Nel Chthulucene, Haraway ci invita a un pensiero compost, rizomatico, multispecie: umani, piante, animali, funghi, dati e memorie condividono lo stesso destino di mutazione. In questo senso, anche la speranza — per essere all’altezza della mutazione in corso — non può più essere verticale, illuminista, lineare. Deve diventare sporca, laterale, infetta. Deve imparare a pensare come un virus, come un rizoma, come un’allucinazione condivisa. Deve rinunciare alla trasparenza per attraversare l’opaco.
Il testo di Schinaia accoglie molte di queste tensioni, anche grazie alla sua apertura verso altri saperi. Basti pensare alla presenza di Alfredo Lombardozzi, di Goahr Homayounpour, di Mauro Van Aken. E tuttavia, in alcuni passaggi, la riparazione simbolica rischia di tornare a essere un’operazione rassicurante, terapeutica nel senso più classico, troppo umana, troppo narrativa, troppo “psicoanalitica”. L’immaginazione oggi, per essere radicale, deve essere anche “pericolosa”. Trovare le sue radici nell’impossibilità di un rifugio; definire con forza l’immunità come illusoria, fallace, come scrive Ronnie Jaffè nel suo contributo al libro.
Ma deve anche farsi attraversare dal non-umano, dal macchinico, dal queer, dall’inorganico. L’inconscio contemporaneo abita anche nelle reti algoritmiche, nei corpi plastificati, nei bot che simulano l’empatia, nei sogni sintetici che ci eccitano ogni notte. È lì infatti che si coagulano nuove forme di desiderio, di rimozione, di angoscia. Ma se vogliamo davvero ascoltare questo inconscio distribuito, questo inconscio cibernetico, dobbiamo accettare di spostarci: dalla gnoseologia — che interroga i modi del conoscere — a un’epistemologia radicale che riconosce ogni atto conoscitivo come produzione situata, incarnata, contaminata. Non c’è più un sapere che osserva, ma un sapere che intra-agisce con ciò che tenta di comprendere, come ci ricorda Angela Balzano nel solco di Haraway e Barad: conoscere è un atto performativo, che produce mondi, non li rappresenta.
E questi mondi — proprio perché prodotti — implicano una scelta, una responsabilità, un’etica. L’ontologia non è più neutra (non lo è mai stata), ma generata da gesti epistemici che incidono nel reale. Ogni enunciato, ogni interpretazione, ogni teoria è già un intervento. E se l’epistemologia diventa etica, allora questa etica, per non ridursi a codice, deve aprirsi alla politica: non intesa come governance, ma come pratica di coabitazione tra differenze, come negoziazione continua dei mondi possibili, come costruzione di ecologie affettive condivise.
È questo il passaggio che ci viene richiesto: abbandonare l’illusione di un sapere puro, disincarnato, per assumere fino in fondo il fatto che ogni conoscenza è anche un gesto onto-politico. Che ogni simbolizzazione è una presa di posizione sul mondo. E che la psicoanalisi, se vuole restare viva, deve farsi carico di questo slittamento: non più solo clinica del soggetto, ma cartografia instabile dei mondi che abitiamo e produciamo.
Che vuol dire tornare a sperare se sperare avviene ancora in un mondo capitalistico?
Ma c’è di più. Infatti oggi, più che mai, la speranza non può restare neutra. Deve prendere posizione. Non possiamo più permetterci una speranza generica, astratta, universale. Crediamo in una speranza che si posizioni, che sappia da dove parla e per chi parla, che riconosca il peso delle sue alleanze. Se stiamo parlando di sesta estinzione di massa, di collasso ecologico, di crisi climatica, non è perché “il mondo è impazzito” — ma perché lo abbiamo fatto impazzire. Perché l’antropocene, se ha un nome, ha anche dei responsabili.
Lo sfondo apparentemente stabile del mondo — natura, clima, ecosistemi, cicli biologici — è stato turbato da uno sfondo ben più instabile, sistematicamente distruttivo, che è il capitalismo fossile, coloniale, estrattivo. La “normalità” che rimpiangiamo era già catastrofe. Bisogna affermarlo con forza. Il disastro non è un’eccezione, è la regola. E come ci ricorda Rosi Braidotti, non possiamo parlare di speranza senza una chiara presa di posizione postumanista e postcapitalista: ogni affermazione di vita oggi è una scelta teorica e politica. Schinaia ci ricorda di non cedere ad una fuga nel consolatorio. Ci piacerebbe aggiungere una speranza come militanza del desiderio.
Senza una riflessione radicale sulle responsabilità storiche del capitalismo e senza un cambiamento di paradigma che includa anche le nostre categorie psichiche — il modo in cui desideriamo, in cui consumiamo, in cui ci relazioniamo all’alterità — è difficile pensare che ce la faremo. Anna Tsing lo scrive con lucidità in Il fungo alla fine del mondo: bisogna imparare a vivere nelle rovine del progresso, a riconoscere forme di sopravvivenza collaborative che sfuggono al modello produttivista. E T.J. Demos spinge oltre: non esiste ecologia senza giustizia sociale, senza un’antropologia critica del privilegio, senza una decostruzione della violenza sistemica dell’Occidente neoliberale.
La speranza, allora, non è più un afflato interiore, ma una pratica situata. Un atto posizionale. Un’ecologia del desiderio capace di smascherare le narrazioni tossiche dell’adattamento resiliente e di aprire spazi per una diserzione condivisa. Come ci invita a fare Donna Haraway, si tratta di restare con il problema, non di risolverlo: di abitarlo, di lasciarci modellare da esso, di generare nuove forme di senso da ciò che non si lascia pacificare.
Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Gazprom, Shell, Coca-Cola, Bayer-Monsanto, le grandi multinazionali dell’agrobusiness e della chimica alimentare, le big family farm che devastano territori e genealogie: solo per citarne alcune, sono tra le maggiori responsabili dell’attuale situazione ecologica e psichica. Sono le responsabili della catastrofe. Nominarle non è una forma di accusa morale, ma un atto necessario di mappatura materiale della catastrofe. Perché la crisi che attraversiamo non è il frutto di un destino cieco, né di un errore generalizzato dell’umanità — è il risultato di decisioni precise, di politiche economiche, di logiche di profitto portate avanti consapevolmente da soggetti identificabili. Le mani che stringono il mondo sono mani ben precise. Hanno nome, capitale, sede legale.
Come può esserci speranza senza fare i conti con queste responsabilità? Come può la psicoanalisi — se vuole davvero interrogare il desiderio e le sue condizioni di possibilità — eludere la questione della colpa sistemica, del trauma imposto, dell’inconscio colonizzato dalla pubblicità e dalla logica del consumo? La speranza, se vuole essere più di un balsamo narcisistico, deve diventare un’istanza critica. Un’arma contro l’invisibilizzazione della violenza. Deve sapere che il dolore non è distribuito equamente, che i corpi colpiti per primi sono quelli già marginalizzati: razzializzati, sessualizzati, impoveriti, precarizzati.
In questo senso, la speranza non è solo un orizzonte affettivo ma un campo di battaglia. Prendere posizione significa anche prendere parte: denunciare, nominare, de-feticcizzare. Significa disinnescare l’ideologia del “siamo tutti sulla stessa barca”, perché alcune barche sono yacht blindati e altre sono zattere bucate. Come scrive Achille Mbembe, l’ingiustizia climatica è la continuazione del colonialismo con altri mezzi: l’aria stessa è diventata una frontiera, un privilegio. Chi ha diritto a respirare?
E allora la speranza, se deve esistere, dovrà esistere contro qualcosa: contro l’imperativo del progresso lineare, contro la neutralizzazione della memoria, contro la retorica della crescita infinita. Dovrà farsi linguaggio di sabotaggio, macchina da guerra poetica, ecologia del dissenso. Non c’è guarigione senza giustizia. Non c’è futuro senza memoria. Non c’è sogno senza lotta.
Decarbonizzare, come scrive Van Aken nel libro, non è altro che questo.
Lo psicoanalista, oggi, non può più essere solo il garante simbolico di un ritorno all’ordine. È un hacker del transfert, un infettologo dell’anima, un archivista del perturbante, un custode di soglie. La stanza d’analisi è un laboratorio biopolitico, un’interfaccia instabile in cui il soggetto si espone al rischio di pensarsi altro da sé, di diventare con. È da questo luogo liminale — e non dal tempio simbolico — che può emergere una speranza non redentiva ma trasformativa, contagiata dalla complessità, capace di reggere l’alterità senza metabolizzarla.
Schinaia ha ragione nel riconoscere che nelle pieghe del sistema esistono già esperienze collettive alternative, forme di resistenza minoritaria, comunità che coltivano mondi — spesso invisibili, spesso fragili, eppure reali. Il suo sguardo è vicino a quello di De Martino, quando distingue tra una fine distruttiva e una fine generativa, capace di aprire nuove ontologie. E ci ricorda che l’elaborazione psichica ha bisogno di un discorso culturale condiviso: senza una simbolizzazione collettiva, anche il lavoro analitico rischia di svuotarsi, di ripiegarsi su se stesso, di diventare solo clinica senza etica.
Tuttavia, l’epoca che abitiamo — segnata da mutazioni climatiche, ontologiche, affettive — ci costringe a ripensare anche gli strumenti stessi del pensiero. Non basta più “capacità negativa”: serve una disponibilità a restare negativi, a sospendere ogni pacificazione, a lasciarsi toccare dal caos, dal rumore di fondo, dal fallimento. Haraway parla di tentacular thinking: un pensiero che non separa, ma intreccia. Che non cerca salvezza, ma abita l’alterazione.
Contro il catastrofismo è un libro importante, scritto con onestà e passione. È proprio per questo che possiamo, anzi dobbiamo, chiedergli di fare un passo ulteriore. Non verso il disincanto, ma verso una speranza contaminata, relazionale, postumana, queer, scomoda. Una speranza che non costruisce, ma infetta. Che non promette ritorni, ma apre varchi. Una speranza che non redime. Che non consola. Ma che tenta, e ritenta. Una speranza che si sporca, come il pensiero. Che balbetta, come il desiderio. Che disattiva il senso, per lasciare spazio all’impossibile. Solo questo può fare da nuovo sfondo di una simbolizzazione collettiva.
E come la psicoanalisi, se vuole ancora dire qualcosa, deve imparare a sporcarsi. A smettere di spiegare. A iniziare a sognare — non un futuro migliore, ma un presente abitabile. Che sappia fallire. Che sappia stare.
E allora, nel mezzo di questo paesaggio turbato, ricordiamo quella passeggiata: Freud, Lou Salomé, Rilke. Tre figure che camminano insieme — forse in un pomeriggio di fine primavera— mentre parlano di psiche, di desiderio, di poesia. È il 1915. Le stagioni ancora sembrano succedersi con una regolarità leggibile: l’autunno con le sue foglie dorate, l’inverno che punge, la primavera come promessa, l’estate che ritorna. Anche il rammarico per il gelo poteva allora contenere, in filigrana, la rassicurante attesa del disgelo. Era ancora possibile affidarsi al ritmo della natura, come a una partitura emotiva collettiva. Era ancora possibile illudersi che la storia fosse lontana, e che i paesaggi avessero un futuro.
Ma sullo sfondo di quella passeggiata, già si addensava la guerra. Le trincee sono a un passo. I corpi, già destinati a diventare carne da fango. La Caducità — come la chiamava Freud — non è una tragedia, ma una rivelazione: ci ricorda che nulla è garantito, che la bellezza è effimera, che l’ordine del mondo può frantumarsi in un istante. Come nelle ultime pagine della Montagna incantata, dove l’aria rarefatta del sanatorio viene squarciata dalle note marziali di una guerra che irrompe — e che porta via tutto: i corpi, i dialoghi, l’amore, la possibilità stessa del pensiero.
È vero: non serve la nostalgia. Serve una memoria politica. Perché senza guardare questo sfondo — senza sentire il peso di ciò che lo attraversa, senza nominare le forze che lo muovono — si rischia di non comprendere quanto profondo sia oggi il cambiamento. E quanto radicale debba essere la nostra risposta.
La speranza, allora, non è più attesa. È pratica. Non è più fiducia. È gesto. Non è più ricompensa. È rischio. E forse, solo se saremo capaci di abitare questo rischio con lucidità, con desiderio e con diserzione, potremo ancora, camminando tra le rovine, immaginare un paesaggio diverso. Non migliore. Ma possibile.
Roma, aprile 2025