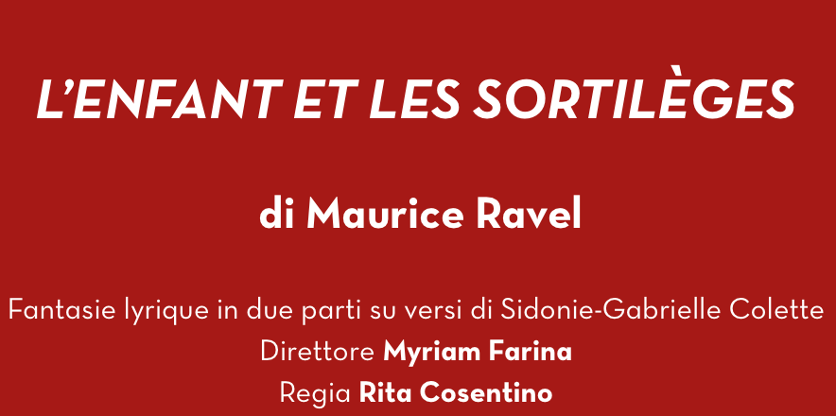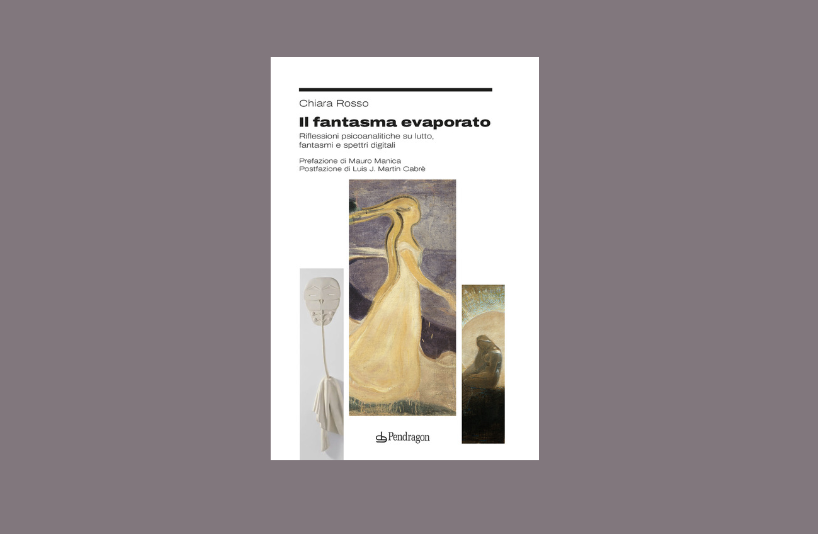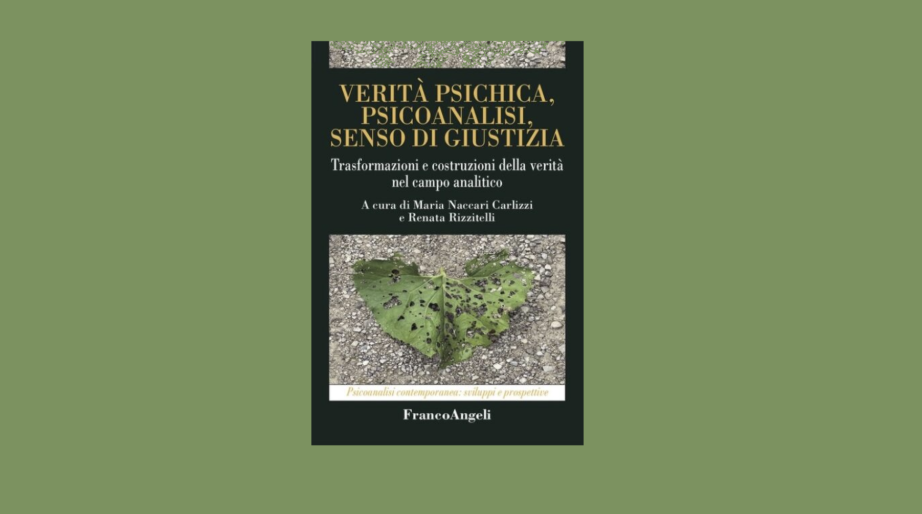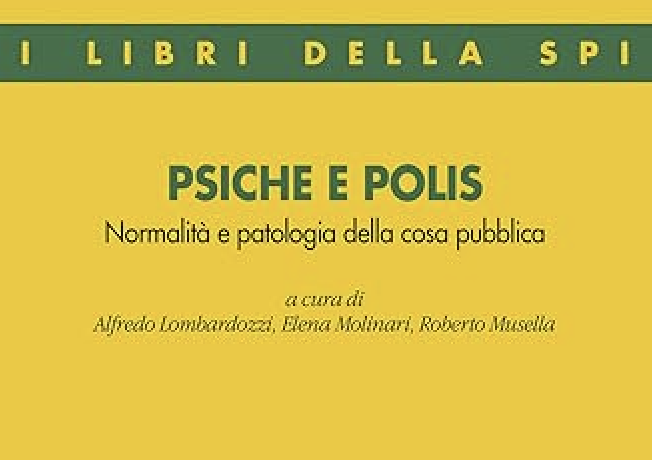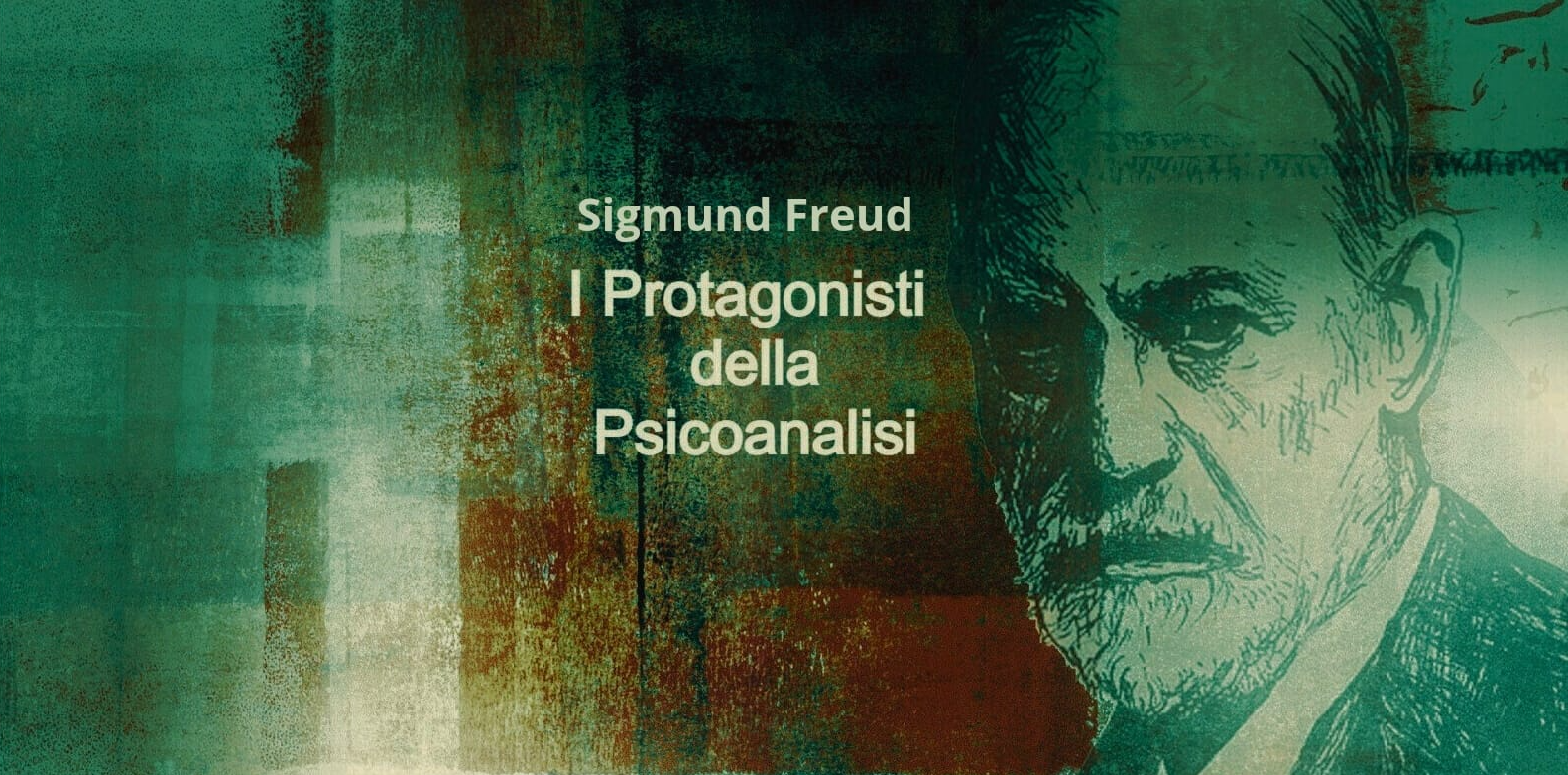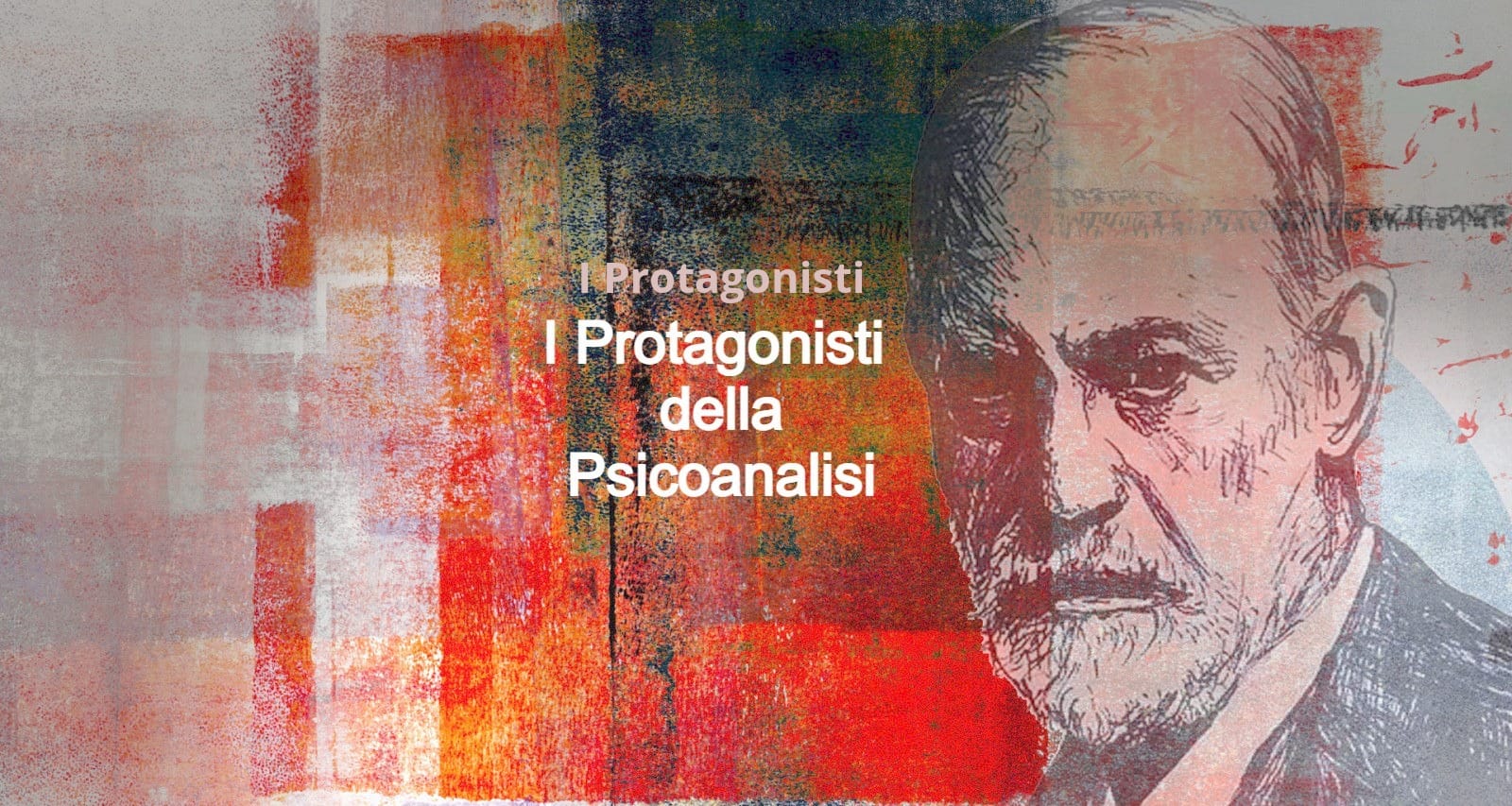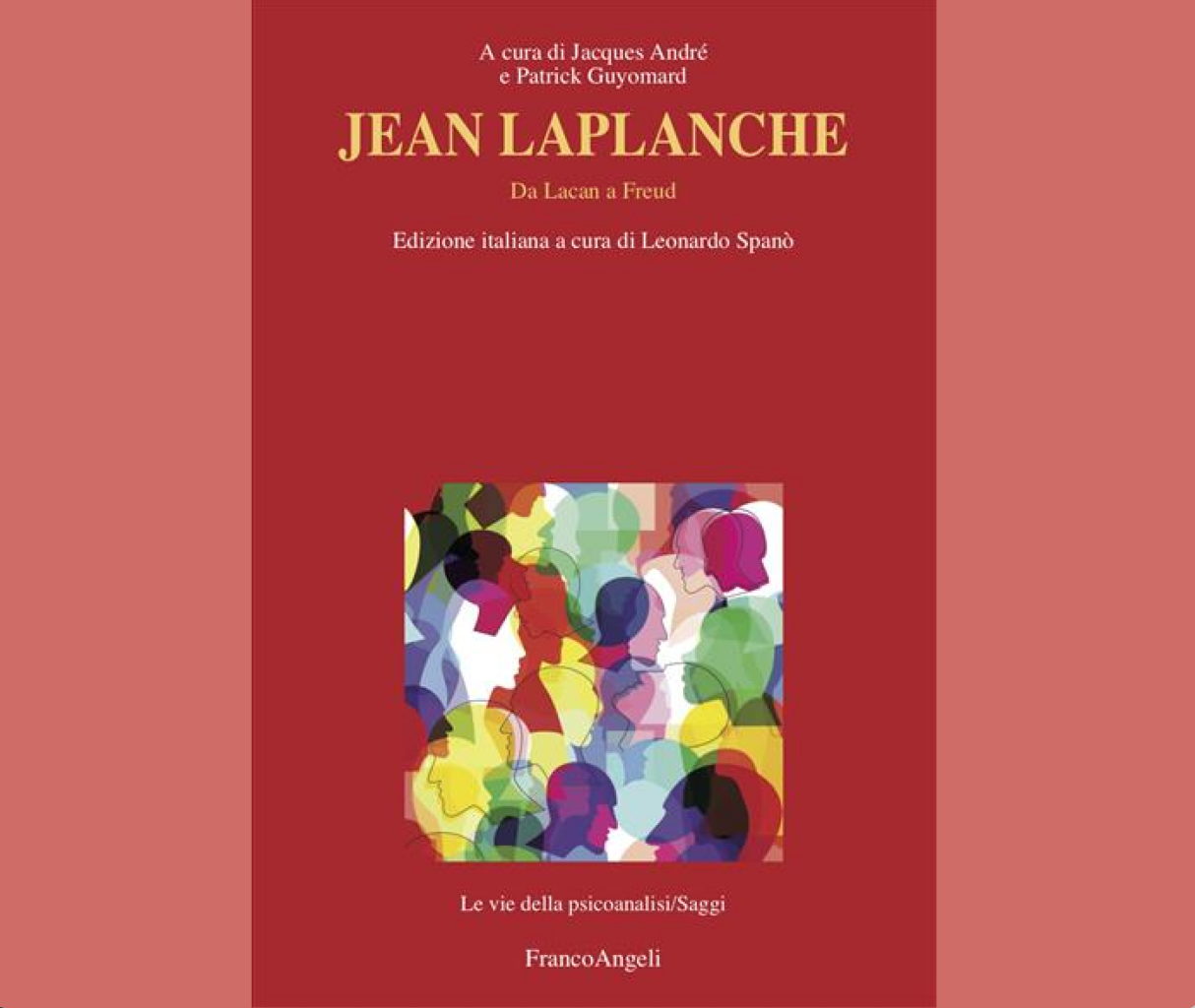
Parole chiave: Laplanche, Psicoanalisi, Freud, Resto, Seduzione
Jean Laplanche. Da Lacan a Freud
A cura di L. Spano
Franco Angeli, Milano 2025
Recensione di Anna Migliozzi
Il lavoro collettaneo, Jean Laplanche. Da Lacan a Freud, edito da Franco Angeli – edizione italiana a cura L. Spano, (2025) è un omaggio ad uno dei maestri indiscussi della Psicoanalisi Francese nel centenario della nascita ed è l’occasione per tornare a studiarlo e (ri)scoprirlo. Operazione pericolosa la celebrazione e, per evitare tale rischio, gli autori fin dalla presentazione dichiarano il loro intento, ovvero mettere al lavoro il pensiero di quello che è stato uno dei maggiori psicoanalisti francesi del nostro tempo. Un ritorno a/su Laplanche, dunque, per maltrattare l’opera, individuarne le macchie cieche, i nodi irrisolti, le piste abbandonate, al fine di mescolare di nuovo le carte, di rianimarla, di renderla viva, “mettendola al servizio di inedite ipotesi cliniche, piegandola all’esigenza di nuove necessità di teorizzazione, operando deformazioni e trasformazioni per continuare a far progredire un pensiero, a farlo correre, a proiettarlo verso il futuro” (p.8).
Non da meno potremmo affermare che è l’occasione per lo psicoanalista militante di dare il benvenuto ad un autore che ha fatto del problematizzare il suo verbo ed è stato capace di ri-mettere al lavoro l’inconscio, a partire proprio da quello di Freud. “Da anni cerco di problematizzare, mettere in questione, mettere al lavoro la teoria analitica, sia nelle sue contraddizioni sincroniche che nelle contraddizioni del suo movimento storico” (p.50).
Nel compito di ri-scoperta siamo aiutati dagli autori quali Maurizio Balsamo, Jacques Andre, Patrick Guyomard, Isée Bernateau, Alain Braconnier, Vladimir Marinov, Mi-Kyung Yi che hanno lavorato con/su Laplanche e sono stati partecipi di quel clima arroventato ma vivace degli anni dello sviluppo e delle scissioni della psicoanalisi francofona che si è nutrita di Freud, di Lacan e del rapporto conflittuale degli allievi con il maestro Lacan e delle, non meno importanti, influenze che via via arrivavano dalla psicoanalisi britannica. Troviamo anche la trascrizione di un intenso dialogo tra Laplanche e Braconnier che ci mostra come lavorare, in un dialogo sempre aperto con le teorie che ci hanno preceduto. Non potremo dare conto di tutti i lavori presentati ma è saggio menzionare le controversie che fanno affiorare. Desiderio verso seduzione, fino a formulare l’ipotesi del desiderio come limite alla seduzione stessa (Patrick Guyomard); il difficile rapporto tra ermeneutica e psicoanalisi, individuando i presupposti e le conseguenze del dibattito sulla “svolta ermeneutica” della psicoanalisi (Mi-Kyung Yi); intreccio tra arte, letteratura e psicoanalisi, in cui vengono affrontate alcune tematiche eminentemente laplanciane, come quella della seduzione e la questione del padre (Vladimir Marinov).
È utile ricordare che Laplanche è stato sì analizzato da Lacan ma che, grazie alla turbolenta separazione, porterà avanti una sua ricerca originale, orientata alla ‘re-interrogazione rinnovata’ dell’opera freudiana, operazione che non sarebbe stata possibile se gli fosse rimasto fedele, come lui stesso ricorda, in quanto avrebbe subito, “un divieto di pensare.” Sceglierà, invece, di continuare infedelmente a lavorare e sarà tra i fondatori della scuola Francofona di Psicoanalisi, contribuendo alla diffusione del pensiero psicoanalitico dal secondo dopoguerra, traducendo, con Jean Pontalis, l’intera opera di Freud.
Nel capitolo “Laplanche, con e contro Lacan. Un dialogo” Guiomar, insieme a Andre e Bernateau, ripercorre il rapporto Laplanche – Lacan e la rottura, forse mai completamente compiuta. Gli autori suggeriscono che se una separazione dal maestro è stata possibile quella è dovuta proprio grazie ad un ritorno a Freud, o meglio, utilizzare Freud per creare uno spazio necessario a riconoscere che Lacan era stato si “ uno straordinario stimolo al pensiero e alla ricerca in un mondo post-freudiano addormentato” (p.50), ma era poi diventato oggetto di critica feroce in quanto autore della più dannosa delle trasgressioni, la confusione tra analizzante e allievo con la creazione di discepoli. Compiuta la rottura Laplanche porterà avanti la sua ricerca fondata sul metodo che Freud stesso ha fornito, inteso come associazioni libere, attenzione ‘ugualmente distribuita’ per indagare gli intoppi, gli smarrimenti e gli errori di Freud perché è lì, ribadisce, che bisogna scavare in quanto Freud non sbaglia mai ‘a caso’ e non perde mai di vista l’oggetto che ha sempre cercato di raggiungere, ovvero l’inconscio.
Laplanche parla spesso di un decentramento della psiche intorno all’altro, dove l’inconscio sarebbe come una galassia che non si può spostare né modificare ma con la quale possiamo soltanto modificare il tipo di relazione (Scarfone, 2022). Se avvertiamo l’eco del primato dell’Altro di Lacaniana memoria, è perché Laplanche gliene riconosce il merito “Il pensatore ha fatto prevalere una certezza senza precedenti nel freudismo […] l’inconscio e la pulsione […] la loro genesi e la loro natura sono indissociabili dal mondo umano e dalla comunicazione interumana” ma allo stesso tempo lo troviamo qui trasformato in un altro essere umano, con l’a minuscola. “Quell’essere prossimo a noi che accompagna la nascita di ogni bambino: padre, madre, adulto in generale. E non più l’Altro assoluto” (p.51). La scelta della minuscola a aiuta Laplanche ad uscire dall’ideologia, a non usare un numero eccessivo di concetti, a riportare le cose all’essenziale fino a condurlo alla domanda quando inizia l’essere umano che siamo diventatie allargandosi fino a suggerire che possa essere l’esito dei molti messaggi precoci, anche sensoriali. Anche se nel testo troviamo un chiarimento offerto da Laplanche stesso: “ciò che rende l’alterità dell’altro, che non è né grande A né piccolo a, è la presenza dell’inconscio, che considero, come credo Freud, individuale. Non è senza storia, è il prodotto di traduzioni successive” (p.29).
Andrè nel suo contributo ricorda Laplanche con ammirazione, come un autore che ha saputo combinare fermezza sulle fondamenta dell’edificio freudiano e innovazione, messa in discussione, rifiuto della teoria convenzionale. Fatica, però, a condividerlo quando sostiene che una teoria possa rendere conto di tutta la vita psichica, possa sovrastare tutta Psiche senza che nulla sfugga al suo angolo visuale. Questa posizione, a suo dire, ha qualcosa in comune sia con Melanie Klein sia con il primo Lacan con le sue triadi (Reale, Simbolico, Immaginario etc.etc.) e che ha trovato una forte opposizione in quel milieux francofono. Non da meno, mostra quali siano le linee di intersezione con il pensiero di Laplanche, ad esempio sul controverso tema della sessualità femminile: “Il mio contributo all’analisi della femminilità primitiva, profondamente radicata nell’inconscio di bambine e bambini, è stato quello di mettere in relazione la passività originaria del neonato con la prima formazione di una posizione femminile […] Il bambino sedotto è un bambino femminilizzato” (p.35), mentre sull’Edipo e la sua iscrizione o meno nell’inconscio, pone diverse questioni.
Sempre il capitolo sul rapporto Laplanche – Lacan, affronta anche la questione della formazione dei futuri analisti (p.74-75), la risoluzione del transfert (se sia possibile) e il ruolo dell’Istituzione Psicoanalitica stessa, di cui si consiglia un’attenta lettura.
Il lavoro di Balsamo ‘Storia, archeologia, sopravvivenze’, prendendo spunto dal lavoro di Laplanche “La psychanalyse: histoire ou archéologie (1981),” è l’occasione per affrontare il tema della ricostruzione in analisi. L’autore si chiede se sia lecito arrivare in analisi ad una comprensione ‘totale’ che integri nel presente il passato ritrovato/rivelato oppure sia, invece, auspicabile accettare una posizione più insatura che si confronti con l’inevitabile lacunosità di tale ricostruzione. Balsamo suggerisce che Laplanche rifiuti “…la megalomania di capire e integrare tutto” (p.78), a favore di una posizione, definita archeologica ovvero capace di resistere ad una comprensione esaustiva e totalizzante, che riconosce quale valore ultimo della psicoanalisi proprio una certa opacità che si manifesta in quell’elemento che resiste: “al movimento inesauribile del recupero simbolico delle tracce, della storicizzazione come necessità di ritorno della psiche su sé stessa, e di quell’aspetto inevitabile di ricostituzione narcisistica della storia fatta dall’Io” (p.78). La posizione archeologica permetterebbe, inoltre, di sfuggire al pericolo di un eccesivo, e improprio, uso dell’hic et nunc che priverebbe la psiche di una pluralità dei tempi, di una sua stratificazione e di un va-e-vieni all’opera nei sogni. Di contro, rischieremmo di avere una narrazione che riguarda ciò che accade in seduta scevra da ogni riferimento alla storia, a ciò che siamo stati, agli enigmi con cui ci saremmo confrontati e a un modo di percepire il mondo.
Balsamo, inoltre, si domanda se una eccessiva fiducia nella relazione analitica, come unico tempo esistente, possa rischiare di appiattire e arrivare a far perdere la pluralità dei tempi nei quali siamo immersi, dei transfert, di quegli oggetti incrostati che si trovano in più traiettorie, in più tempi, in più versioni del soggetto. Riprendendo Pontalis, ci ricorda che finiremmo per perdere quello specifico psicoanalitico che rappresenta il tempo anacronistico che scava il presente dando vita ad una molteplicità di tempi, di verità, di funzionamenti psichici e di tracce. Qui si avverte una non-velata critica all’intersoggettivismo che, con la sua estrema fiducia nella cura come un viaggio in cui non c’è più storia e nemmeno sessualità, rischia di non lasciare niente di incompreso o irriducibile, producendo una teoria che sembrerebbe erroneamente digerire tutto con il rischio di cadere nella facile manipolazione.
L’antidoto a tutto questo, come ricorda Laplanche, starebbe nei resti non elaborati, ribelli alla storia, capaci di assorbire i movimenti del transfert e catturare le stratificazioni temporali della psiche e garantirebbero lo sgonfiamento di una posizione narcisistica. “La psicoanalisi, come l’archeologia, è un tentativo di ritrovare pazientemente l’oggetto vero” (p.80). Il processo di storicizzazione, osserva Laplanche, si ritrova soprattutto nelle teorie sessuali infantili, nel complesso organizzatore dell’Edipo e, infine, nella psicoanalisi stessa. Si potrebbe dire, tuttavia, che anche accettando la dimensione storicizzante dell’esperienza analitica (“la psicoanalisi è forse più storia della storia stessa”), Laplanche senta il bisogno di precisare che la storia è un tipo particolare di storia. “Ciò a cui Freud mira è una sorta di storia dell’inconscio o, meglio, della sua genesi. Una storia con sincopi, nella quale i momenti di seppellimento e di risorgiva sono quelli che contano al di sopra di tutto” (p.81).
Balsamo suggerisce che i resti/traccia tentano di inscriversi nella coscienza, di presentare ciò che è stato rimosso dalla dimensione rappresentativa, la necessità delle loro ragioni e la necessità di un lavoro quasi infinito da pensare. “La traccia allude a una storia di sparizioni e ricomparse: riapparizioni, a volte deformate o mascherate, di ciò che è scomparso, rimasto sepolto, assente dalla scena psichica, ma che può riapparire nel soggetto o nelle generazioni successive” (p.81). Per questo potremmo concordare con l’autore quando riconosce che la possibilità di far rivivere in seduta ciò che il soggetto non ha mai potuto sperimentare – traccia come un creato-trovato sia segno di un’operazione che dà esistenza e le permette di ritornare in scena. Dunque, se la psicoanalisi è una pratica, come amava ripetere Laplanche, la longevità della psicoanalisi dipende dalla sua pratica quale messa in scena dell’inconscio.
Jean Laplanche. Da Lacan a Freud. A cura di L. Spano. Franco Angeli, Milano 2025