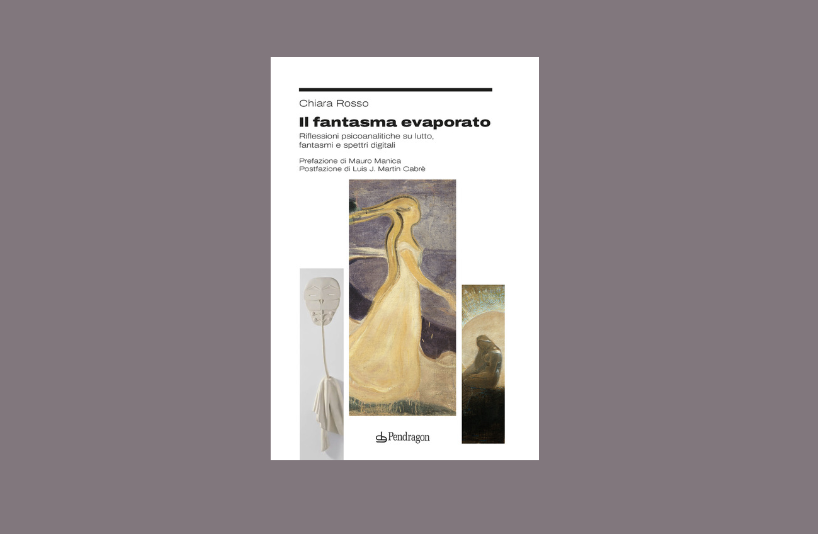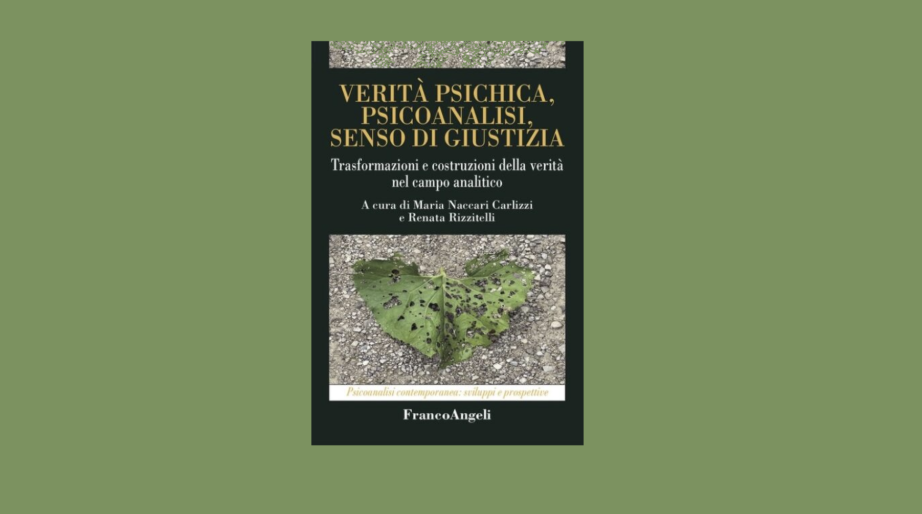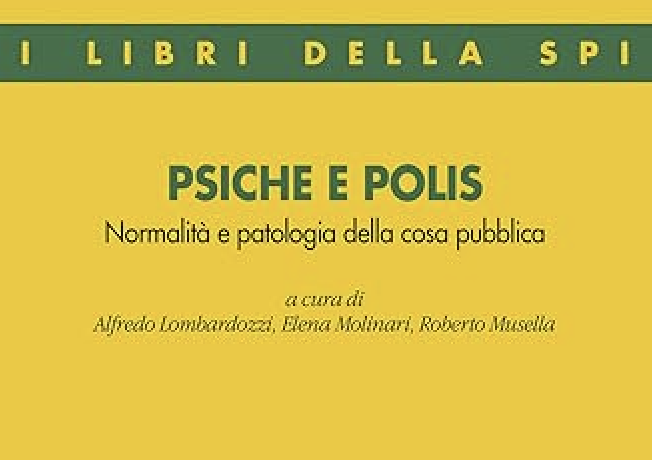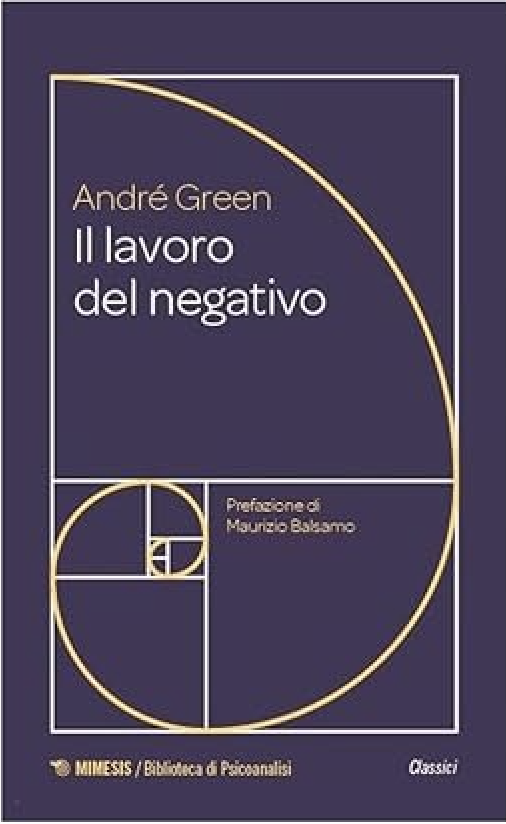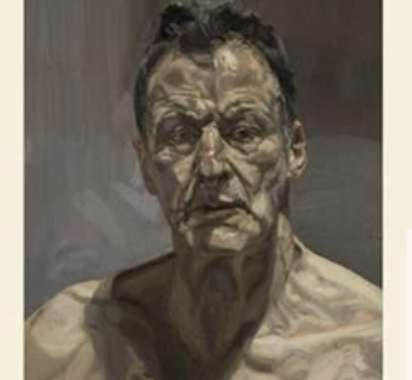
Parole chiave: dualismo pulsionale, narcisismo di vita e di morte, Il negativo, l’Infinito
Andrea Baldassarro
L’inquietudine dell’analista. Teoria e pratica analitica
AlpesItalia, 2024, Roma, pp. 192
di Alfredo Lombardozzi
Leggere il libro di Andrea Baldassarro è come intraprendere un viaggio psicoanalitico che segue la regola fondamentale delle libere associazioni. Ispirandomi all’esempio di Freud, potrei immaginare di essermi ritrovato a guardare da un finestrino del treno nella posizione dell’analista che, attraverso l’attenzione fluttuante, osserva mutevoli paesaggi che passano di fronte ai suoi occhi.
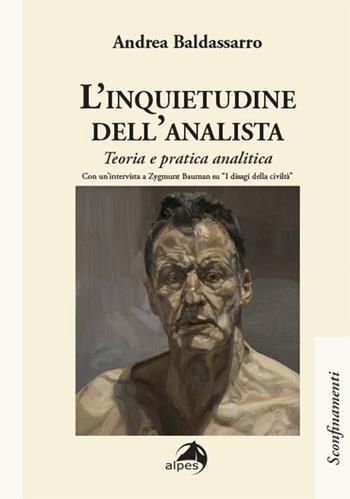
I paesaggi sono rappresentati da varie figure che descrivono il percorso temporale della riflessione di Baldassarro che, nella loro plasticità, mantengono una coerenza che trova la sua principale motivazione in una ricerca approfondita con un’adesione e rispetto non ‘religioso’ alle complesse articolazioni dell’opera freudiana.
Si delinea un’idea del pensiero freudiano, e della psicoanalisi in senso più generale, che pone in evidenza i suoi aspetti più ‘rivoluzionari’, in un certo senso ‘eversivi’, nei quali l’autore individua la propensione ad essere ‘inattuale’. Questo comporta ritrovarsi inevitabilmente in una posizione che sposti l’ottica di osservazione rispetto alle vicissitudini della realtà sociale e della dimensione inconscia, verso panorami psichici che altrimenti resterebbero relegati nello sfondo.
In un percorso, che prende forma nei vari capitoli del libro, vengono affrontati alcuni nodi centrali del pensiero psicoanalitico letti con una lente raffinata che, riprendendo Freud stesso, consente un’attenta analisi metapsicologica. Questo avviene nell’approfondimento del complesso passaggio tra le due topiche: la prima (conscio, preconscio e inconscio) e la seconda (Io, Es e SuperIo) e nella formulazione di concetti chiave, che l’autore rende attuali, ponendoli in relazione con i cambiamenti nella società contemporanea ed ispirandosi a parametri epistemologici, corrispondenti ad una teoria critica, specifici della filosofia continentale contemporanea.
C’è un’attenzione costante all’Inconscio in tutte le sue manifestazioni, i sintomi, i sogni, le sublimazioni che avvengono nell’arte, nelle forme sociali e culturali dell’umano. Inoltre Baldassarro propone acute osservazioni sulla complessità della dimensione del tempo nel modo in cui lo percepiamo sia a livello conscio che inconscio. Il tempo è un fattore cruciale in quanto si presenta in diverse modalità nella mente, nella vita soggettiva, nella storia individuale e collettiva e nei livelli consci e inconsci dell’esperienza. Tanto l’inconscio è infatti atemporale, come Freud stesso ha sottolineato, quanto il soggetto, l’Io, o direi il Sé, ha bisogno di un tempo che garantisca una continuità nell’esistenza. Inoltre il senso della continuità del Sé non è mai compiuto, infatti siamo per definizione incompleti.
La storia del soggetto, allora, sia nella vita che nell’analisi, si definisce nella ricostruzione del modo in cui si percepiscono quelli che potremmo chiamare i ‘fatti psichici’ in una ‘narrazione’ che dà forma ai ‘fantasmi’ depositati nella realtà intrapsichica. In questo senso la dimensione fantasmatica, che l’autore riprende principalmente dal pensiero di André Green ed altri autori della tradizione psicoanalitica francese (Aulagner, Botella, Laplanche), costituisce l’elaborazione inconscia del traumatismo che, pur correlandosi alla realtà, traduce questa nella formazione intrapsichica del soggetto.
In fondo, ispirandosi soprattutto a Green, in un suo modo originale, Baldassarro sembra cogliere come aspetto fondamentale della vita psichica l’elemento della ‘mancanza’, già presente in Freud in relazione al tema della nascita del pensiero. Questo concetto diviene per Baldassarro (2023) quello che definisce la funzione del ‘negativo’. Il ‘negativo’ in realtà, per come ho inteso, consiste nella possibilità di elaborare il lutto dell’assenza, soprattutto quando l’oggetto si presenta assente proprio per la sua presenza intrusiva. Allora l’oggetto assente e irraggiungibile nella depressione grave diviene iper-presente, assumendo un carattere intrusivo, nella psicosi. Entrambe le due condizioni si correlano alle diverse qualità della relazione primaria, che crea le condizioni per ospitare nell’inconscio, sia quegli aspetti passibili di rimozione, sia quelli che potrebbero corrispondere a quelle che Mauro Mancia (2004) definisce ‘memorie implicite’. Parliamo di quei fantasmi originari che sono la condizione potenziale, quando entrino nell’area della rappresentazione, della spinta alla soggettivazione.
Proseguendo nel percorso indicato dall’autore si incontrano necessariamente le vicissitudini del ‘soggetto’ dalla modernità dei tempi della nascita della psicoanalisi, alla postmodernità caratterizzata dalla prevalenza del paradigma relazionale, che viene inteso da Baldassarro non nei termini dell’intersoggettività, ma di un’epistemologia della relazione ‘osservatore-osservato’, mutuata dal paradigma conoscitivo della scienza fisica quantistica e del principio di indeterminazione. Nel discorso di Baldassarro l’apertura, l’insaturo, l’incompletezza costituiscono i fattori peculiari della propensione del pensiero psicoanalitico ad accogliere gli elementi della precarietà dell’esperienza umana, sia in termini emotivi che cognitivi. Questo avviene senza impigliarsi nella rete della ricerca di un’oggettività a tutti i costi e valutando, allo stesso tempo, la qualità del discorso metapsicologico in quanto contenitore concettuale che dà corpo alla realtà psichica, costruendo un metodo per orientarsi nella sua complessità.
Sappiamo che questo discorso viene affrontato diversamente in molti modelli psicoanalitici e il modo in cui viene proposto da Baldassarro ha il pregio della chiarezza, pur non rinunciando al dialogo critico con altri punti di vista e di esercitarlo con rispetto costruttivo.
Il concentrarsi sui processi della costruzione e decostruzione del soggetto, la critica alla dissoluzione postmoderna dello stesso oggetto con cui il soggetto entra in relazione, sono motivi importanti che conducono l’autore a interrogarsi sulla contemporaneità. L’immersione nell’attualità che ci circonda comporta infatti il misurarsi con fenomeni inquietanti, che vanno oltre le criticità dei precedenti paradigmi, ponendoci nella posizione di spettatori di una comunicazione mediatica iperreale. Inoltre assistiamo ad una preoccupante aumento della distruttività che si esprime sia nella violenza, nei cruenti scenari di guerra ben conosciuti nel corso della storia, sia nella inedita pervasività dei modi in cui viene percepita.
Incontriamo alcuni temi centrali, seguendo il percorso del libro che approfondisce sia le dinamiche intrapsichiche che l’analisi delle vicissitudini della contemporaneità: il narcisismo e la pulsione di morte e, in qualche modo correlati a queste figure, l’infinità e la dimensione del misticismo, distinto dalla forme religiose istituzionali, nelle sue declinazioni nella psiche e nell’inconscio.
Baldassarro segue perciò il discorso freudiano articolandolo principalmente con la lettura di Green del narcisismo in quanto considerato nei suoi lati ‘negativi’ ma anche nell’investimento ‘positivo’ sull’Io. Le pulsioni di vita e di morte conseguentemente si articolano, come suggerisce l’autore, non tanto in una relazione di opposizione ma di compresenza dinamica. Questa oscillazione tra ‘narcisismo di vita’ e ‘narcisismo di morte’, tra legamento e slegamento (Green, 1983, 1992), sembra corrispondere sia ad un funzionamento della psiche individuale che alle espressioni che prendono forma nella psiche collettiva e nei processi politico-sociali e culturali nel mondo attuale.
Da qui emerge nel pensiero dell’autore un modo di riprendere le tematiche del Disagio della civiltà (Freud, 1929). Infatti, pur conservandone l’aspetto drammatico, sottolinea le condizioni per poterle superare e aspirare a contrastarle con efficacia, nella speranza del prevalere del processo della civilizzazione e dei legami caratterizzati dall’Eros.
Per Baldassarro oggi il ‘negativo’ nei suoi aspetti distruttivi e destabilizzanti si manifesta in forme nuove, confuse e difficilmente definibili. Tendenza al conformismo, negazione dell’alterità, superficialità nelle relazioni affettive, manifestazioni distruttive gratuite, costituiscono forme di ‘non pensiero’ e mortifere che prevalgono nella comunicazione interpersonale nella rete. Nel linguaggio di Green siamo nella forma più radicale dello ‘slegame’ e dell’annichilimento della vita psichica. Qualcosa di simile sul piano sociale corrispondente a quella che è stata definita la ‘clinica del vuoto’, espressione di una mancanza senza speranza che non prende una forma se non nell’identificazione dell’oggetto assente o ‘morto’, o nelle manifestazioni estreme della ‘psicosi bianca’.
A questo punto viene introdotto nel libro un discorso che Baldassarro articola in modo originale e che può costituire un elemento nuovo e di speranza in questo paesaggio di desolazione. Questo consiste nella sua attenzione a quegli aspetti della vita psichica che hanno a che fare con il ‘sentimento oceanico’. In questo caso l’autore coglie il limite di Freud che, come sappiamo, nella famosa lettera a Roman Rolland si è fermato sulla soglia della ‘giungla indiana’. In ultima analisi Freud si ‘ferma’, se così si può dire, di fronte al materno, a quella condizione psichica ‘ineffabile’, attinente alla relazione primaria con la madre, che ha le qualità dell’infinito e della fusione con l’oggetto. Fusione che denota una relazione indifferenziata che è anche la condizione dell’individuazione.
Nella visione di Baldassaro l’individuazione avviene seguendo il modello, ripreso da Lacan, della ‘castrazione’ e della riproposizione della terzietà edipica come fattore di crescita. E’ il manifestarsi di una pulsionalità, come spinta propulsiva alla vita, a cui soggiace la costante presenza della tendenza dell’organismo, anche dell’Io già strutturato, verso il soddisfacimento a cui più aspira nel raggiungimento della condizione dell’inorganico assimilabile al ‘Nirvana’ (Freud, 1920).
Forse andare più in profondità nelle parti più segrete e irraggiungibili della mente o psiche inconscia, come la psicoanalisi nei suoi più diversi orientamenti e proposte teoriche stanno tentando di fare (il protomentale in Bion, l’imitazione in Gaddini, la posizione contiguo-autistica di Odgen, quella glischro-carica di Bleger, la fantasia fusionale del gruppo di Neri, Pallier, Petacchi, Soavi, Tagliacozzo), può aiutarci a comprendere meglio quali siano i fattori, ora non del tutto chiari, che intervengono nei processi delle attuali forme sociali e culturali. La bellissima intervista al grande sociologo Baumann, riportata nel libro e la sua proposta di una modernità caratterizzata da una identità liquida, anche se ha anticipato sviluppi successivi, non è più sufficiente a comprendere l’inquietudine dell’attualità, che è anche, come recita il titolo del libro ‘l’inquietudine dell’analista’.
Trovo un’affinità del discorso di Baldassarro con l’idea che ho recentemente sostenuto, riprendendo Bion e integrandolo con Erikson, che è necessario per l’analista sperimentare ‘l’inquietudine della catastrofe’ (Lombardozzi, 2025) senza perdere il senso della speranza.
Bibliografia
Baldassarro A. (2023), La passione del negativo. Omaggio al pensiero di André Green, FrancoAngeli, Milano.
Freud S. (1920), Al di là del principio del piacere, in OSF. 9.
Freud S. (1929), Il disagio della civiltà, in OSF. 10.
Green A. (1983), Narcisismo di vita, narcisismo di morte, Borla, Roma, 1985.
Green A. (1992), Slegare. Psicoanalisi, antropologia e letteratura, Borla, Roma, 1994.
Lombardozzi A. (2025), Un mondo che cambia: la psicoanalisi tra catastrofe e speranza, in C. Schinaia (a cura di), Contro il catastrofismo. Psicoanalisi in dialogo, Jaka Book, Milano.
Mancia M. (2004), Sentire le parole. Archivi sonori della memoria implicita e musicalità del transfert, Boringhieri, Torino.