
Parole chiave: Consulenza psichiatrica, Consultazione psicoanalitica, Setting dinamico, Psicoanalisi e ospedale
UN TEMPO “PICCOLO”?
LA CONSULENZA PSICHIATRICA A ORIENTAMENTO PSICOANALITICO
di Maria Moscara – Giorgio Mattei
ALPES, 2025
Recensione di Giuseppe Riefolo
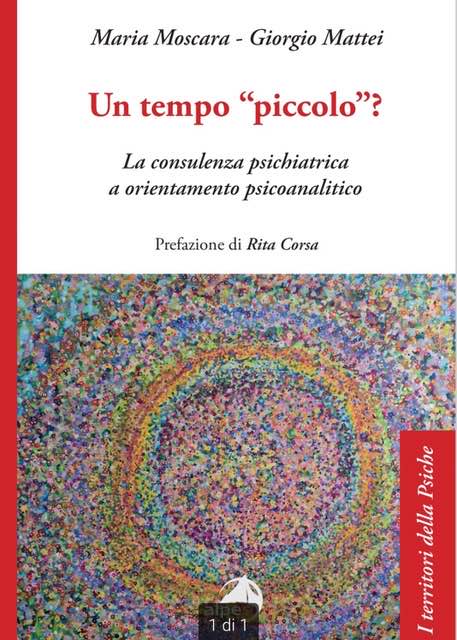
Entro subito nel merito di questo “piccolo” libro. Il titolo è bello e porta immediatamente nella dimensione dove, se sei psicoanalista, è solo perché la psicoanalisi è il codice del tuo linguaggio clinico e delle tue passioni vive. Non centra quanto tempo hai a disposizione. La durata dei processi non è la psicoanalisi, ma la durata può essere un elemento (quindi una variabile…) del setting che, come si sa, è un dispositivo per permettere che i processi accadano. Poi scopri – non lo immaginavi – che è già stato il titolo di una canzone dove, non a caso, non ha importanza quanto tempo ci metti per entrare nella vita: “diventai grande in un tempo piccolo…Scesi nella strada mi mischiai nel traffico” (F. Califano, 2005). La durata limitata e “piccola”, quindi, non inficia la psicoanalisi che, nei luoghi comuni, viene associata ai tempi lunghi o infiniti delle cure. La consulenza è l’occasione di un incontro che si organizza secondo il dispositivo dell’inconscio: “anche quando si vede un paziente per solo poche volte in tutta la sua vita, in certi casi si riesce ad aiutarlo con l’impiego di concetti psicoanalitici” (Matte Blanco, 1989, 34).
A questo punto la posizione dei due autori si può cercare nello spazio dichiarato della “consulenza psichiatrica” dove il tempo è segnato prima che dalla posizione del consulente, dai bisogni, spesso anche organici, dei pazienti (p.40). Si inizia a leggere il “piccolo” libro e ci si accorge che la dichiarazione non è proprio vera. Il libro, sin dalla introduzione di Maria Moscara, dichiara che manterrà “uno sguardo sui punti di contatto con la consultazione psicoanalitica” (p. XIV).
A me la lettura del libro è servita per soffermarmi sulle differenze strutturali tra consulenza e consultazione che gli autori pongono in continuità, e riescono a delineare nelle loro specificità e potenzialità dinamiche specifiche (p.13). Nella consulenza l’analista è accolto (è persino sollecitato…) in uno scenario in cui la psicoanalisi è sostanzialmente esclusa e le motivazioni della richiesta spesso sono confuse nell’urgenza di dover trovare una giustificazione, magari anche psicologica, dove il medico sente disagio o impotenza e “la consulenza può svolgersi anche senza una motivazione soggettiva del paziente” (p.43). L’analista occupa un luogo non suo e si dispone a prestare la propria competenza ad una disciplina che immediatamente non gli riconosce specificità. Moscara sottolinea l’importanza del contesto dove lo psichiatra (mi chiedo: e lo psicologo?) “si misura anche con le attese dell’istituzione in cui opera e le finalità della stessa” (p.37).
In questo caso l’occasione della consulenza è una opportunità per insinuare un sospetto che il registro solo organico e meccanico non siano sufficienti a sintonizzarsi verso il dolore del paziente: “l’incontro non è orientato alla diagnosi o alla cura, ma…finisce per diventare un’occasione” (Ferruta, 2018, 19).
La consultazione, invece, avviene in una cornice curata ed usata dall’analista. La consulenza viene soprattutto restituita ad un sistema, mentre la consultazione deve essere restituita al paziente. Nel codice della clinica ospedaliera e della medicina i due termini possono coincidere, ma solo la posizione analitica – pur accogliendoli, magari come sinonimi – li differenzia.
La differenza è nella precisa convinzione psicoanalitica che ogni domanda può essere letta solo nella cornice significante di un setting. Mentre nella consulenza il paziente si dispone al servizio delle preoccupazioni diagnostiche del medico, nella consultazione il paziente, con il suo corpo e la sua confusione, accetta di entrare in una dimensione di cui sospetta le potenzialità, ma anche i rischi.
Il libro affronta in modo preciso non solo le differenze, ma soprattutto le dinamiche che possono segnare una evoluzione dalla consulenza alla consultazione.
Il caso di Elio, riportato all’inizio (p.19) descrive in modo chiaro questo percorso e persino quella che può essere considerata il prototipo della consultazione “ante-litteram”. L’incontro fortuito di Freud con Katharina descrive – gli autori lo sottolineano – questa fertile evoluzione. In questi casi l’analista può trovarsi nella felice posizione evolutiva di “traghettare” (Bolognini, 2006) una semplice domanda concreta verso una dimensione più articolata dove il paziente può sospettare soluzioni psicologiche alla sua iniziale domanda concreta. Nelle consulenze che nel libro sono definite laiche (p.18) e che magari sono portate non solo direttamente dal paziente, ma dai reparti ospedalieri, spesso la richiesta si muove nell’assunto improprio di una equazione (culturale?) fra psicoanalisi e psichiatria. Personalmente ritengo che questa strana e scomoda condizione di fraintendimento di codici vada comunque accettata come “metasetting” (Liberman, 1972) prima che un non riconoscimento. Per quanto mi riguarda è il cavallo di Troia attraverso cui la posizione psicoanalitica può essere presentata come dispositivo potente che esalta la comunicazione effettiva tra sistema curante (il reparto della medicina) e il dolore del paziente che, in quel caso ha il linguaggio del corpo. Elio, uno dei primi casi clinici proposti attraverso lo spazio (il dispositivo?) della consulenza, sospetta che il farmaco sia depositario (Pichon-Rieviere, 1971) di una particolare relazione che si compie attraverso oggetti concreti: “mi ragguaglia sugli effetti della terapia farmacologica e chiede ‘un incontro per capire meglio” (p.19). Racamier e Carrettier (1972) colgono questo felice sospetto del paziente nella precisa dimensione della “relazione farmacologica”, ovvero dove lo psicoanalista si emancipa dallo psichiatra e, rispettando la biologia, investe nella infinita variabilità del porgere il farmaco. Lo psicoanalista, allora, scopre la potenza e la fortuna della funzione placebo del farmaco e l’onnipotenza sottile che la posizione di bisogno del paziente gli consegna: “ciò che il malato pensa della sua malattia, ciò che si aspetta, teme, augura e spera, tutto questo sembra essere un fattore che incide sul decorso stesso della malattia” (Jaspers, 1953, 6).
L’analista ha il delicato compito di sintonizzarsi con la domanda inconscia e complessa del paziente rispettando ed usando le potenzialità del setting, depositario di una domanda concreta portata dal corpo che, inevitabilmente, coinvolge la dimensione fantasmatica della rappresentazione di quel dolore sul piano psichico. La delicatezza concerne il rispetto del corpo come entità ferita evitando che il corpo sia negato da una lettura solo psicologica di quella ferita. Nel libro si riporta del precoce fraintendimento che riguarda il gruppo di Alexander a cui viene attribuita una “fuorviante specificity hypothesis” che alcune “condizioni mediche fossero caratterizzate da pattern psicodinamici specifici” (p. 5). Paradossalmente, spesso ci si trova a contenere le simmetriche posizioni proprio dei clinici che ci chiedono la consulenza orientati a una lettura solo psicologica del dolore portato dal paziente (in queste situazioni spesso al paziente viene comunicato che “non ha niente”!). In questa posizione, il consulente psicoanalista si trova nella delicata ma difficile posizione di consulente non solo del paziente, ma soprattutto del reparto che gli ha posto la domanda. In questo, ha ragione Moscara quando nella introduzione suggerisce che “il curante che ha richiesto la consulenza, va tenuto nella mente della coppia paziente-consulente come primum movens” (p. XV).
Il tema delle interconnessioni mente-corpo, questo libro lo tiene giustamente ed onestamente come complesso e sostanzialmente sospeso. Una complessità ulteriormente acuita dal concetto di embodied recentemente riproposto da Rizzolati e Gallese ed introdotto, come ricorda Mattei, da Varela che ribadiva la stretta interconnessione fra corpo e processi cognitivi (p.6). A questo punto, gli autori non possono evitare il delicato e difficile campo dello “psicosomatico”. Personalmente ritengo che ci sia una differenza di accento significante fra “psiche-soma” e “psicosomatico”. Il primo, che a mio parere parte soprattutto da Winnicott, si incarna nel protomentale di Bion e nella primitiva Organizzazione Mentale di Base (OMB) di Gaddini, coglie il corpo nella sua dimensione di psiche preriflessiva, quando la mente non può che presentarsi come corpo e organizzarsi nella coincidenza con la fisiologia. In questa dimensione è la fisiologia del corpo che presta un linguaggio preriflessivo e non simbolico al soggetto impegnato ad organizzare una mente. È un linguaggio che, peraltro, rimane attivo tutta la vita dove la mente coincide con il corpo e la fisiologia registra e propone stati affettivi non simbolizzati simultaneamente al registro simbolico. Moscara e Mattei, in questo libro indagano soprattutto il campo dello “psicosomatico” dove l’accento, invece, viene posto sul corpo che porta il suo dolore attraverso la dimensione psichica. Gli autori riconoscono come le radici di questa “posizione psicosomatica” origini soprattutto dalle “specificity hypothesis” della scuola psicoanalitica di Chigago facente capo soprattutto a Franz Alexander che negli anni ’30 individua persino sette ambiti clinici (holy sevens) specifici di quadri psicosomatici. Citando Marty, David e de M’Uzan (1963) dell’Ecole Psychosomatique de Paris, gli autori ribadiscono la propria posizione verso questo ambito dove “il fine essenziale dell’indagine psicosomatica è valutare […] i livelli funzionali investiti e utilizzati col ruolo dei vari elementi in causa” (p.29). Ciò permette anche di individuare un preciso “identikit del paziente psicosomatico” che presenterebbe “un buon adattamento sociale parallelamente ad assenza di sintomi psicopatologici evidenti (nevrotici o psicotici…)”. Questa posizione viene ulteriormente ribadita attraverso le posizioni di Joyce McDougall (1990) dove è il gastroenterologo a chiedere una consulenza per (attraverso?) una paziente a cui, alla fine del percorso della consulenza, è possibile connettere le crisi di rettocolite con antiche e sospese esperienze di separazione. Nella stessa linea fa riflettere positivamente l’accoglienza di Enrico, un paziente incontrato in dermatologia da Moscara, che ha avuto in altri contesti di cura il consiglio di “andare a fare un giro per il parco dell’ospedale…se qualcuno o qualcosa ti infastidisce” (p.45). In questo caso il consiglio concreto è il precipitato della dimensione relazionale, mentre la stessa indicazione avrebbe potuto avere una dimensione espulsiva.
Sul piano teorico la posizione degli autori è nettamente organizzata sulle posizioni di Kernberg e Clarkin che si fonda su relazioni oggettuali internalizzate inconsce. Il consulente/analista si pone come oggetto che sollecita rappresentazioni diadiche nel paziente. Sappiamo che queste posizioni teoriche sono particolarmente espresse nell’approccio con pazienti borderline, ma gli Autori tentano una coraggiosa e, alla fine, utile integrazione del modello della TFP nel contesto della consulenza. Le posizioni suggerite dalla TFP, nella linea di Zapparoli, possono, alla fine, essere integrate con la riformulazione anche catamnestica del discorso del paziente.
La relazione oggettuale che emerge durante la consulenza si amplia, quindi, con la rappresentazione dell’esperienza di quel preciso paziente con le cure fino in quel momento.
A questo punto, torno alle considerazioni iniziali dove gli autori ribadiscono l’interesse a muoversi in contesti clinici estranei alla psicoanalisi ed appartenenti alla medicina o alla psichiatria fino a contesti altamente delicati quali quelli dei trapianti (cap. 10). Qui la posizione psicoanalitica, come notano gli autori, è chiamata a integrare e sostenere, magari nell’approccio della TFP, la riproposizione eccitante di aperture di vita con l’invasione di un organo da cui il proprio corpo tenta di difendersi: “si possono osservare modalità collaborative fino alla compiacenza così come modalità intrise di incredulità, sospettosità e diffidenza” (p.68).
Ho apprezzato molto il capitolo finale sul tema delle valutazioni economiche, per i servizi, della psichiatria di liaison psicoanaliticamente orientata. Sono interessato a queste posizioni perché come analista sono certo che, come sosteneva Freud, la sofferenza psicologica è anche molto costosa e il benessere permette la maggiore disponibilità di risorse per la propria vita. L’analisi dei costi-benefici della consulenza/consultazione psichiatrica nell’ambito della medicina soprattutto ospedaliera – per quanto intuitivamente di indubbio vantaggio – risulta però di difficile applicazione soprattutto per la difficoltà ad individuare precisi elementi discriminanti specifici (durata del ricovero, uso dei farmaci, necessità di esami diagnostici, necessità di ulteriori contatti specialistici?). Peraltro, come notano gli autori, è indubbio che “la consulenza psichiatrica non dia un beneficio diretto a breve termine” (p.83) e l’impatto economico va comunque a diluirsi nell’ambito della specialità a cui, comunque, si offre la consulenza. Il tema della funzione delle risorse diventa ancora più complesso se ci si ponesse nella linea di cogliere (e documentare) le differenze che un approccio psicoanalitico può sostenere rispetto al semplice approccio psichiatrico.
Mi fa piacere che finisco di leggere questo “piccolo” libro soprattutto con alcuni quesiti che gli autori sollevano e a cui cercano di suggerire proposte.
Quindi: un analista può sicuramente uscire dal proprio comodo setting e muoversi in setting più complessi: la fede è nella dinamicità prima che nella staticità degli elementi del setting. La consulenza permette interessanti riflessioni sulle differenze rispetto alla consultazione. Infine, quando e in base a quali elementi una consulenza può dirsi psichiatrica o psicoanalitica? Ovviamente non è sufficiente la presenza del solo analista! Quindi: di cosa si compone e se è possibile che un reparto ospedaliero possa essere colto come “situazione analizzante” (Donnet, 2001)? Maria Moscara e Giorgio Mattei (ed anche io) ritengono che questo non solo sia possibile, ma persino peculiare proprio per uno psicoanalista. Perché, da Freud a Bion, gli analisti sanno che il dolore viene dal corpo ed assume diverse forme prima di (e magari, indipendentemente dall’) essere trasformato in qualcosa di mentale.
Riferimenti bibliografici
- Bleger, J. (1966). Psicoanalisi del setting psicoanalitico, in: Genovese C. (a cura di) Setting e processo psicoanalitico, Cortina, Milano, 1988, 243-256.
- Donnet J. L., De la règle fondamentale a la situazion analysante, Int. J. Psychoanal, 82, 1, 129, (2001); relazione al XLII Congresso IPA, Nice, 23 – 27 luglio. (trad it., Dalla regola fondamentale alla situazione analizzante, Psicoanalisi, 6, 2, 115-129, 2002).
- Jaspers K. (1953). Il medico nell’età della tecnica, Cortina, Milano, 1991.
- Liberman D. (1972). Linguistica, Interaciòn comyunicativa y processo psicoanalitico. Buenos Aires, Galerna, cit. in Etchegoyen H.R. (1986). I fondamenti della tecnica, Astrolabio, Roma, 1990.
- Matte Blanco I. (1989). La Società Psicoanalitica Italiana. Un punto di vista personale. In L’Italia nella psicoanalisi, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, pp.29-37.
- Pichon-Riviere E. (1971). Il processo gruppale. Dalla psicoanalisi alla psicologia sociale, Lauretana, Loreto, 1985.
- Racamier P.C., Carretier L. (1965). Relation psychothérapeutique et relation médicamenteuse dans l’institution psychiatrique. In : Lambert P. A. (a cura di), La relation medecin-malade au cours des chimiothérapies psychiatriques. Masson, Paris, 58-62.
