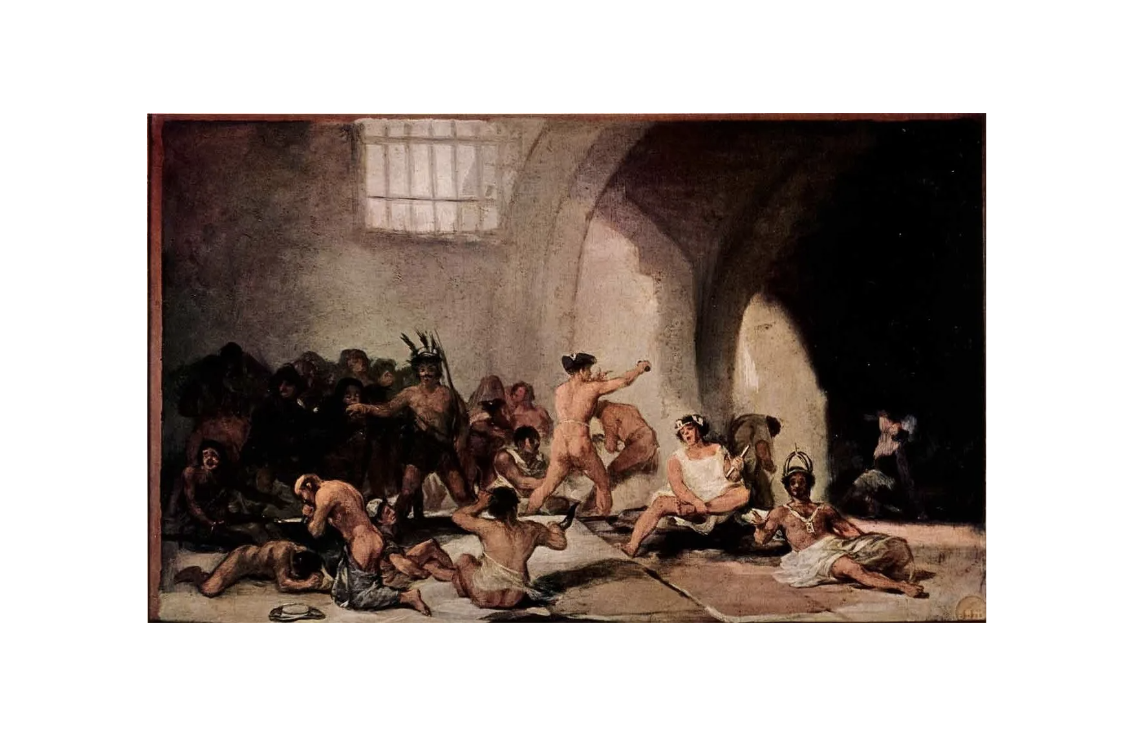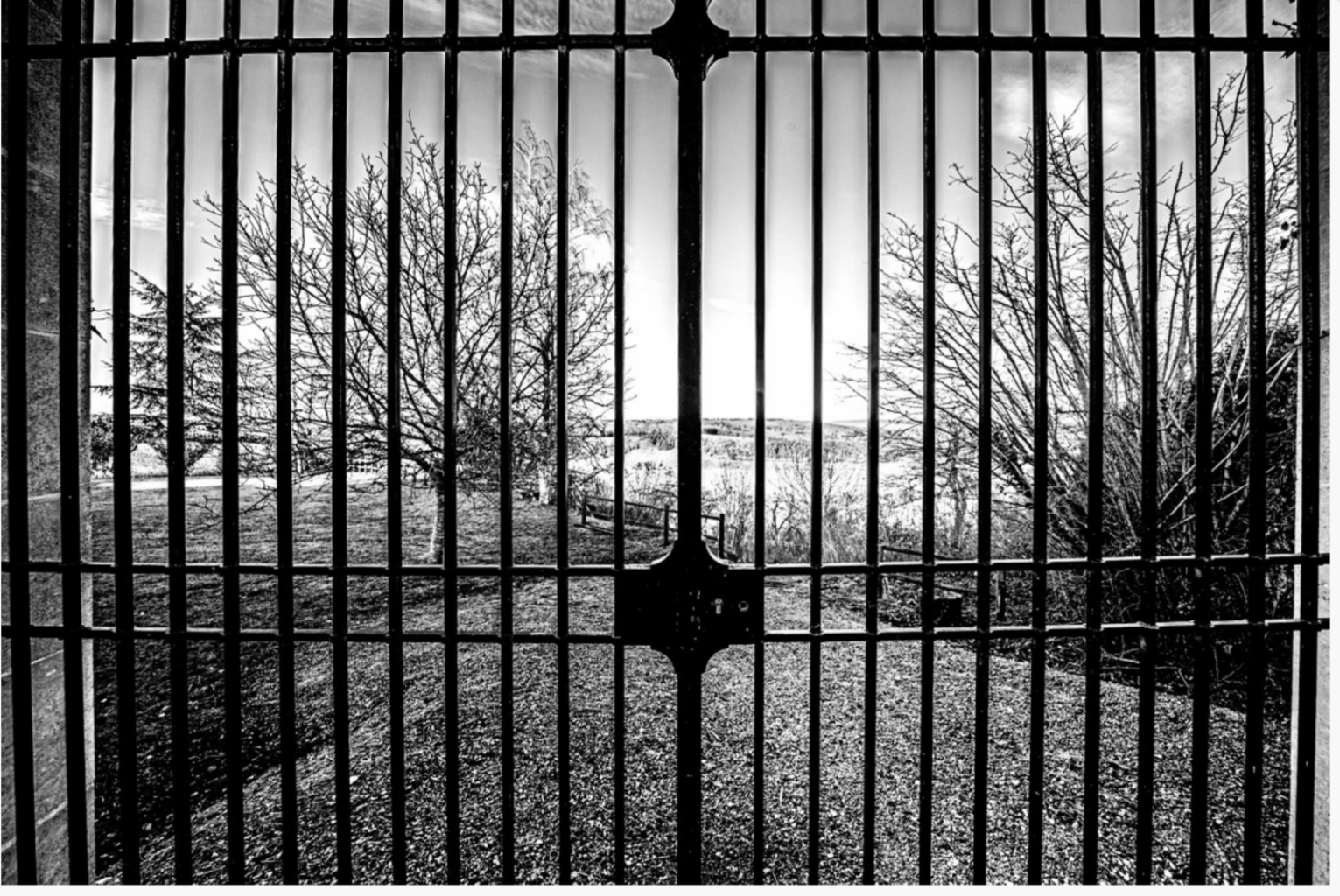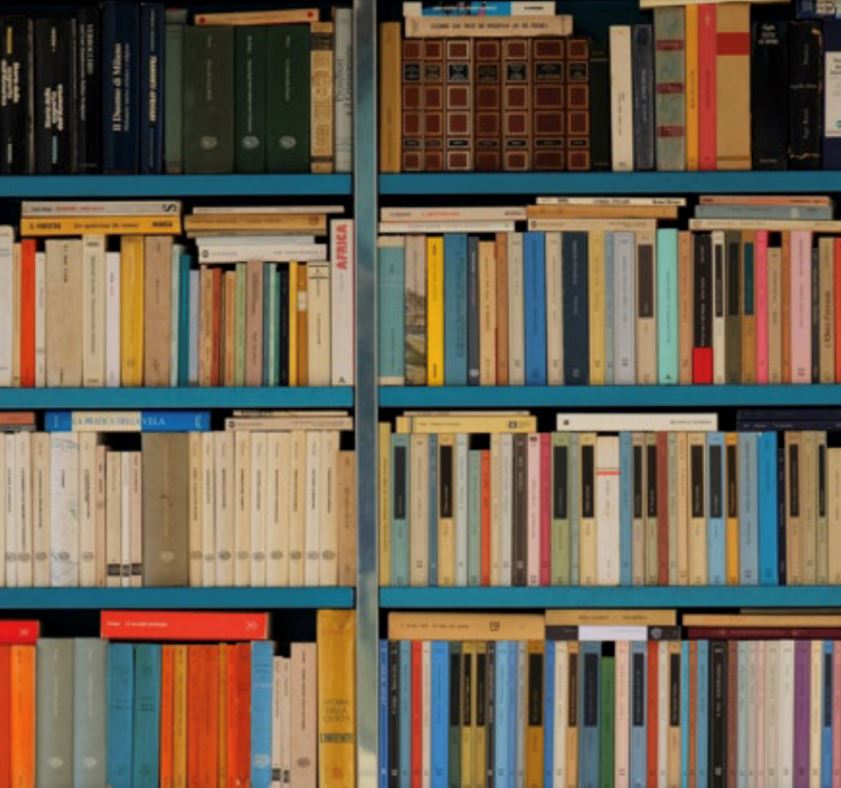Parole chiave: Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), Corte Costituzionale, legge Basaglia, legge n. 833/1978
17-9-2025
La redazione di SPIweb ha deciso di proporre una riflessione su un importante pronunciamento della Corte Costituzionale del 30 maggio 2025 che modifica, a favore del paziente e delle sue garanzie costituzionali la prassi del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) rendendo ancora più cogente il diritto del paziente ad essere realmente informato in ogni fase dell’effettuazione del ricovero sia dal Medico che dal Giudice Tutelare.
Il pronunciamento della Corte Costituzionale assume un valore etico e storico di enorme valore in quanto giunge a distanza di molti anni dalla Legge del 1978 che ha normato il TSO ed è giunto, come sottolinea l’Autore, a seguito di un ricorso presentato da una paziente.
Molti sono gli psichiatri – psicoanalisti che operano nei Servizi di Salute Mentale del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che quindi si stanno già confrontando con le novità introdotte da questo pronunciamento, molti psicoanalisti lavorano in Ospedali o strutture accreditate col SSN e possono, per la loro funzione, svolgere un ruolo in una richiesta di TSO e altri psicoanalisti sono in contatto con i Servizi della Salute Mentale nella funzione di consulenti e supervisori.
Ci auguriamo quindi che si possa attivare uno scambio di esperienze e un confronto tra le prassi che si sono avviate.
La redazione ha richiesto questo intervento al prof. Marco Marchetti, psicoanalista e già professore ordinario di Medicina Legale c/o Università del Molise.
Maria Moscara
Al di là dei principi della Corte Costituzionale.
Brevi note a margine della sentenza 76/2025
Marco Marchetti
Con la sentenza n. 76 del 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 giugno u.s., la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n 833/1978 (la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale all’interno della quale viene pressoché integralmente riportata la cosiddetta legge Basaglia) là dove non prevede la comunicazione alla persona sottoposta a ricovero in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) dell’ordinanza del Sindaco e là dove non prevede che il Giudice Tutelare, che ha l’onere di convalidare il TSO, ascolti di persona il/la paziente : una piccola rivoluzione.
Di estremo interesse per noi psicoanalisti è, a mio avviso, il come si è arrivati alla pronuncia della Corte Costituzionale cui è stato posto il quesito sulla costituzionalità dell’art. 35 della 833/78 da parte della 1ma Sezione Civile della Corte di Cassazione che, a sua volta, si è trovata a dover discutere il ricorso di una paziente che riteneva, ora possiamo dire con piena ragione, di non essere stata pienamente garantita dalle procedure di legge al momento in cui veniva, seppur temporaneamente, privata della sua libertà personale per via del ricovero in TSO. Paziente che, dopo che non aveva viste riconosciute le sue ragioni sia in primo che in secondo grado, è arrivata sino al vaglio della Cassazione che si è rivolta alla Corte Costituzionale con l’esito che abbiamo riportato.
Credo che dobbiamo molto a questa persona che in fondo ha chiesto con forza solo di essere maggiormente ascoltata opponendosi a certi automatismi che la Corte Costituzionale ha considerato illegittimi.
Se andiamo al di là delle pur rilevanti modifiche procedurali per la corretta esecuzione di un ricovero in TSO, modifiche che però, alla fine, ben poco riguardano direttamente il medico, nelle articolate e complesse motivazioni la Corte Costituzionale ribadisce un punto per me fondamentale, che di fatto vale per ogni paziente psichiatrico, in ogni momento del suo trattamento: anche una persona affetta da una infermità psichica rimane pienamente titolare dei suoi diritti costituzionali cosi che, sia prima che durante un TSO, ci si deve impegnare ad ottenerne il consenso e comunque, anche in una fase di scompenso psichico, la persona ha sia il diritto di comunicare con chi desidera, sia quello di opporsi legalmente ad un provvedimento, qualora lo ritenga illegittimo, sia, infine, quello di essere ascoltata non solo (o soltanto) a livello medico psichiatrico ma anche da un orecchio addestrato ad un ascolto diverso, ma non per questo meno sensibile quale quello di un Giudice. Quest’ultimo può, tra l’altro, arrivare a svolgere la funzione di terzo tra paziente e curanti e potrebbe essere sicuramente molto utile se si arrivasse ad istituire una sorta di registro nazionale per raccogliere tutte le motivazioni, sia di convalida che di rigetto, del TSO da parte dei Giudici Tutelari cosi da iniziare a valutare le caratteristiche di un diverso punto di vista rispetto alla sofferenza mentale e alle modalità di intervento.
D’altra parte se volgiamo lo sguardo ai più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali (vedi la legge 219/2017 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento e la sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 sul caso Cappato e l’aiuto al suicidio) appare evidente come sia sempre più valorizzato il tema dell’autodeterminazione del paziente, che appare comunque prevalere rispetto anche alla migliore posizione del terapeuta, medico o psicologo che sia, cosi che si può legittimamente arrivare all’estremo del rifiuto anche delle terapie cosiddette salvavita con il medico, ma se lo desidera il paziente, anche lo psicoanalista, che, in ogni caso dovrebbe comunque rimanere accanto al paziente.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione troviamo però anche costante il richiamo alla particolare fragilità del paziente, specie di quello che presenta una sofferenza mentale, fragilità che dovrebbe, in ogni caso, rimanere protetta dalla cosiddetta posizione di garanzia cui è tenuto ogni terapeuta.
Proprio perché il paziente è un soggetto fragile andranno quindi, nei limiti del possibile, ancor di più protette e garantite sia la sua libertà di espressione sia quella di autodeterminazione e non coercite o ritenute inesistenti.
Ritengo che questi principi siano assolutamente noti alla Psicoanalisi e agli Psicoanalisti, la vera sfida è poterli seguire e rispettare fino in fondo in situazioni che possono risultare del tutto particolari quali quelle dei Servizi di Salute Mentale.
D’altronde non credo che sia un caso che nel Codice Deontologico dell’IPA (2015) vi sia un chiaro richiamo (vedi il punto 4 della terza parte) al rischio che anche in ambito psicoanalitico si possa verificare un “abuso di potere”: “Uno psicoanalista deve tenere in debita considerazione durante un analisi e dopo che si è conclusa, lo squilibrio di potere che potrebbe esistere tra analista e analizzando e non deve agire in alcun modo che sia in contrasto con l’autonomia del paziente o ex paziente”.
Questi sviluppi normativi, mettendo ancor di più al centro della cura il paziente e la sua libertà di scelta, di fatto non fanno che confermare la validità di tante esperienze nelle quali psicoanalisti impegnati in prima persona nei servizi pubblici o chiamati a svolgere un ruolo di supervisione o di consulenti hanno portato direttamente o hanno promosso una diversa attenzione ai bisogni e alla incoercibile soggettività del paziente (Boccara, De Sanctis e Riefolo, 2005; Bonfiglio,2016) (*).
Forse implicitamente la Consulta invita chi si occupa di salute mentale a ritornare al significato autentico delle parole.
Com’è noto uno dei presupposti per poter (e dover) effettuare un TSO in condizioni di degenza ospedaliera è la presenza di “alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”, se tali interventi terapeutici vengono rifiutati dal paziente. Sembrerebbe del tutto scontato che gli “interventi terapeutici” siano in primo luogo interventi di natura farmacologica e la terapia appunto un’idonea terapia farmacologica, ma se appunto teniamo presente il significato etimologico del termine terapia troviamo l’indicazione anche di un altro intervento, non alternativo di per sé alla terapia farmacologica, ma altrettanto importante e, in alcuni casi, decisivo.
Come ci ricorda Umberto Curi (2017), filosofo molto attento alla psicoanalisi, il significato originario di therapeia è “servizio” e secondo Curi “colui che si assume la therapeia nei confronti di un altro si pone totalmente al suo servizio ascoltandolo”. Non è quindi necessariamente un “fare qualcosa”, ma certo è auspicabile un “intervenire” nel senso di provare ad avvicinarsi al mondo del paziente, un essere presente accanto alla persona, ascoltandola e cogliendone le angosce profonde.
Curi per illustrare il therapon per eccellenza parla di Patroclo come therapon di Achille non perché “faccia” qualcosa di specifico, ma perché è sempre pronto ad ascoltare l’amico. Fra i due tra l’altro c’è un’asimmetria che ci può ricordare qualcosa. Patroclo è più anziano di Achille e ha ascendenze regali di più alto lignaggio che lo potrebbero porre in una posizione di privilegio. Ma al momento dell’ascolto diventa il “servitore” di Achille, il therapon appunto.
Terapia peraltro è un termine più volte usato da Freud, basti pensare a “Vie della terapia psicoanalitica” (1918) e particolarmente toccante è per me il richiamo alla funzione, ai possibili “limiti” nonché ai possibili sviluppi della “terapia” psicoanalitica che fa nel compendio (1938) là dove profeticamente vede sia la possibilità che in futuro “speciali sostanze chimiche” possano “influenzare…le quantità energetiche e la loro ripartizione nell’apparato psichico” sia la possibilità che si realizzino “altre potenzialità della terapia che adesso non possiamo neppure sospettare” ma comprendo quanto il termine terapia rischi, oggi più di ieri, di essere confusivo dato il diffuso e incontrollato uso del termine composto “psicoterapia” usato per ogni forma, anche la più improbabile, di intervento psicologico nei confronti della sofferenza mentale.
In Italia la Società Psicoanalitica (SPI) ha scelto di usare su SPIWeb il termine “cura” vale a dire quella che è a tutti gli effetti la traduzione latina del termine greco terapia termine che, se vogliamo, è ancora più evocativo di un avere una particolare attenzione, avere cura appunto, per qualcuno.
D’altronde Anna O, altra paziente a cui qualcosa dobbiamo, parlando tra l’altro una lingua non propria, definì la sua con Breuer (1893) una “talking cure”: ancora oggi continuiamo ad usare quella definizione (Garella, 2002; Argentieri,2025).(*)
A volerla leggere da un vertice psicoanalitico la sentenza della Consulta sembrerebbe quindi indicare e indicarci qualcosa di più di un cambio di prassi, invitarci, anche al di fuori della stanza di analisi (**) ad una attenzione diversa e, in fondo, dovuta al paziente.
Ci invita a quell’ascolto particolare che caratterizza comunque la posizione dello psicoanalista (Akhtar, 2015) e che oggi tende sempre di più ad essere rispettoso (Nissim Momigliano, 2001). Come ricorda Ezio Maria Izzo (2024), collega che ha a lungo lavorato in difficili contesti istituzionali, “la cura psicoanalitica rimarrà sempre detentrice del primato dell’ascolto” della sofferenza umana (*).
Infine riguardo ad una nostra possibile (ma superabile) difficoltà nel confrontarci con delle norme “esterne” non posso che concordare appieno con Riefolo quando afferma, intervistato da Paolo Boccara (2021) che una posizione di responsabilità verso il paziente, mediata, dico io, dalla realtà delle norme vigenti, “non è una posizione buonista” ma uno strumento di efficacia clinica .
“Cosa vale la pena di fare in medicina?” si domanda Winnicott (1917-1923) “fare del proprio meglio con compassione” è la sua straordinaria risposta . Questo ne sono convinto è quello che ci viene chiesto questo è quello che con tutti i nostri limiti proviamo costantemente a fare con i nostri pazienti nella (e al di fuori della ) stanza di analisi.
(*) La letteratura scientifica sulla psicoanalisi nelle istituzioni, sulla cura con la parola e sull’ascolto psicoanalitico è ovviamente molto più ricca e articolata ma la sua disamina esula dagli scopi di queste brevi note.
(**) Come non pensare che durante l’emergenza Covid abbiamo dovuto un po’ tutti inventarci qualcosa di diverso dal ricevere il paziente nella nostra stanza di analisi: con una immagine efficace Bolognini (2021) ha suggerito che è come se ci fossimo trasferiti tutti in una tenda da campo durante un periodo di scosse sismiche.
Bibliografia
Akhtar S. (2015): L’ascolto psicoanalitico. Casa Editrice Astrolabio, Roma.
Argentieri S. (in corso di stampa): La parola che cura. Uso e maluso della psicoanalisi oggi. La Nave di Teseo, Milano.
Boccara P. (2021): Quale responsabilità nei Servizi. Intervista a Giuseppe Riefolo. Psiche,1:311-323.
Boccara P., De Sanctis R., Riefolo G. (2005): Lo psicoanalista e le sue istituzioni: La posizione dell’analista nei servizi pubblici e nella stanza di analisi. Rivista di Psicoanalisi 51:69-86.
Bolognini S. (2020) La psicoanalisi al tempo del Coronavirus . Pol It Psychiatry on line Italia e su Spi Web.
Bonfiglio B. (2016): Psicoanalisi e urgenze psichiatriche. Rivista di Psicoanalisi, 62:419-434.
Curi U. (2017): Le parole della cura – medicina e filosofia. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Freud S., Breuer J. (1893-5): Studi sull’isteria. Casi clinici. Signorina Anna O. OSF, I , Boringhieri, Torino.
Freud S. (1918): Vie della terapia psicoanalitica. OSF IX. Bollati Boringhieri, Torino.
Freud S. (1938): Compendio di Psicoanalisi. OSF XI. Bollati Boringhieri, Torino.
Garella A. (2002) Talking cure. Rivista di Psicoanalisi, 48:851-871.
It.IPA, World (2015): La nostra organizzazione; Governance LPI; Codice etico.
Izzo E. I. (2024): L’ora non è finita. Per una Metapsicologia concreta Eros e Arbeit, Franco Angeli, Roma.
Nissim Momigliano L. (2001): L’ascolto rispettoso. Scritti psicoanalitici. Raffaello Cortina Editore, Milano.
Winnicott D. (1917-1923): Quel che più vale in Medicina. In Il sentimento del reale- scritti inediti. Raffaello Cortina Ed. Milano, 2025
Marco Marchetti, Psichiatra e Psicoanalista SPI – IPA, Associato CPB.