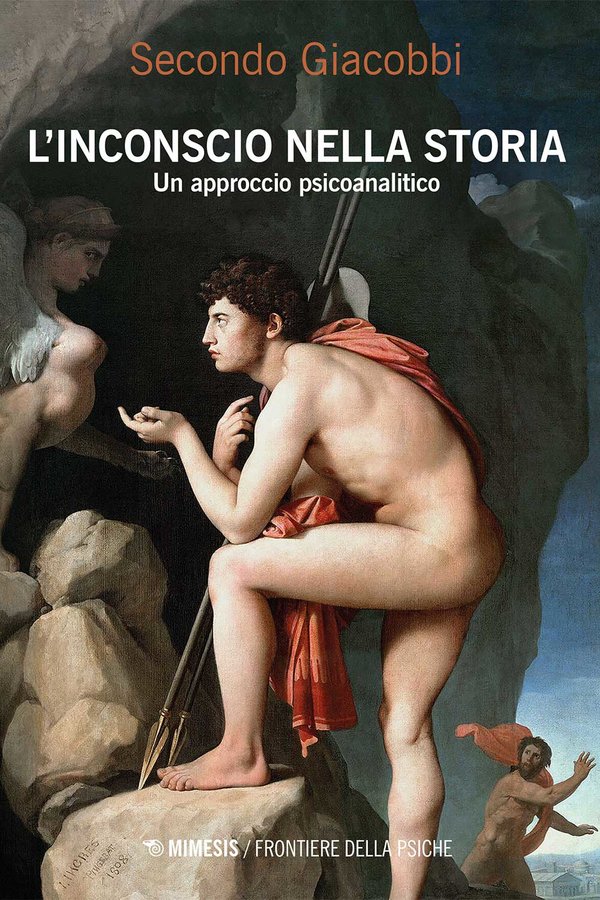
Parole chiave: Inconscio, Storia, Psicostoria, Post-modernità
L’inconscio nella storia – Un approccio psicoanalitico di Secondo Giacobbi
Mimesis, 2025
Recensione di Rita Corsa
In questa sua ultima monografia, Secondo Giacobbi, un autore di psicoanalisi molto colto e libero da convenzioni conformistiche, pare voler racchiudere la summa del suo pensiero. Un pensiero maturato in un lungo corpo a corpo con le teorie della psicoanalisi, applicate non solo alla clinica, come in altri suoi precedenti libri, ma qui usate come chiave di lettura di discipline affini, quali l’antropologia, la filosofia e la stessa storia dell’uomo.
Lo stimolo, che è diventato un’urgenza, è senz’altro originato dal confronto profondamente disorientante con le straordinarie “accelerazioni” cui sono sottoposti i tempi presenti. Giacobbi rileva che il “pensiero lento”, quello riflessivo capace di insight e di legame con l’altro e con l’ambiente, è inesorabilmente condannato al declino (2025, 12). Egli, allora, si accinge a far proprio il monito di Bollas, che sollecita la psicoanalisi a cercar di sanare la “grave compromissione del mentale”, tipica della nostra epoca (Bollas, 2015, 431), adoperando le coordinate psicoanalitiche per rileggere alcuni passaggi dello sviluppo umano, sino a giungere a una rimappatura psicoanalitica della contemporaneità. Un tentativo di uscire dalla deriva conformistica, che tende all’omologazione con il dissolvimento della soggettività e all’indifferenziazione tra soggetto e oggetto (Corsa, 2021). E non vi è terreno migliore di quello della storia per avviare tale audace operazione investigativa dell’umano.
Nei primi capitoli del volume, Giacobbi, invero, propone un recupero riaggiornato del metodo “psicostorico”, che ipotizza “un ruolo attivo dell’Inconscio umano, inteso in termini psicodinamici” negli accadimenti storici (2025, 47). La psicostoria si affermò, soprattutto negli Stati Uniti, dagli anni Cinquanta in poi. In gran sintesi, si tratta di un metodo storiografico che fa riferimento al fattore psicologico come agente fondamentale del processo storico. E va considerato sia l’Inconscio individuale, nelle sue varie declinazioni e teorizzazioni, che quello collettivo, derivato dagli archetipi di matrice junghiana. D’altronde è un cruccio costante degli storici quello di coniugare un metodo storiografico basato sulla raccolta di tracce del passato (documenti archivistici, testi, diari, epistolari, testimonianze, resoconti biografici, etc.) con “i processi inconsci” del ricercatore e delle stesse fonti cui è intimamente collegato l’archivio interno, il registro della memoria (Federn, 1985, 92).
Altro problema affrontato da Giacobbi, che affligge da sempre gli storiografi, è quello della scrittura della storia. In un noto saggio del 1975, L’écriture de l’histoire, il filosofo francese di formazione lacaniana, de Certeau, si sofferma sulle costrizioni che la narrazione della storia, attraverso la scrittura, impone alla prassi della ricerca e di come questo procedimento sia massicciamente influenzato dall’inconscio dello storico. Per de Certau, la trascrizione storica (la scrittura della storia) traduce il lavoro scientifico in una fiction (teoria della finzione) e in tale cornice andrebbe inserito pure il discorso di Freud che, a partire dai casi clinici, ha restituito al testo letterario il ruolo di finzione teorica costituiva e necessaria per riconoscere e produrre i modelli logici a loro volta necessari per ogni “spiegazione” storica. Nel carteggio con Arnold Zweig, lo stesso Freud parla del ruolo assunto dalla letteratura nel suo discorso scientifico come di un ritorno alla terra materna (Muttererde), all’antica Palestina, la cui specificità rispetto alle altre civiltà consiste, secondo lui, nell’aver prodotto soltanto “religioni, deliri sacri” e strane stravaganze, vale a dire a finzioni (Freud a Zweig, 8 maggio 1932; in 1968, 84). Così nel discorso psicoanalitico la “maniera” romanzesca si fa scrittura teorica.
Giacobbi riconosce che gli analisti che si sono cimentati con la psicostoria, fornendo interpretazioni psicologiche di personalità storiche e di fenomeni sociali, spesso sono stati tacciati di ingenuo riduzionismo.
Il modello di indagine indicato da Giacobbi, che mi piace chiamare “neo-psicostorico”, si allarga e si appoggia al concetto fornariano di psicostoria, derivante da una teoria onirica della conoscenza che postula una coesistenza tra mito e logos. A parere dell’Autore, seguendo l’inconscio dei protagonisti, si potrebbero così riscrivere la filosofia della storia, la storia della psicoanalisi e dell’uomo, nonché di discipline contigue, quali l’antropologia.
I codici affettivi teorizzati da Fornari, insieme ad altri postulati concettuali, saranno inoltre preziosa bussola nell’indagare i rapporti tra natura e cultura, l’odierna funzione materna e quella paterna, l’organizzazione e il ruolo della famiglia ai nostri giorni. Di assoluta attualità sono i capitoli dedicati da Giacobbi al tramonto del patriarcato, al materno e al matriarcato, alla “sacralizzazione del figlio immaginario” (Gauchet, 2010, 3), che si trasforma in autarchico “puerocentrismo” alla nascita del figlio reale. Sono temi cari a Giacobbi, già esaminati in altri suoi saggi (2019).
L’ultima, ampia parte del ricco e dotto volume è riservata all’analisi di altri due, complessi, fenomeni storico-sociali, quali la politica e la religione. Una cornice teorica che declina il problema dell’aggressività e della guerra, collegate al significato e all’azione del potere e alla forza delle ideologie, consente di scandagliare in senso psicoanalitico e psicostorico le questioni cruciali della politica e dei monoteismi.
La riflessione di Giacobbi si conclude con uno sguardo preoccupato agli orizzonti futuri, con la speranza, però, che il pensiero psicoanalitico conservi la sua grande potenzialità di “tenere viva e accesa anche in questa nostra società contemporanea una posizione della mente ispirata allo spirito della critica e alla libertà del pensare” (2025, 257).
Bibliografia
BOLLAS C. (2015). La psicoanalisi nell’epoca dello smarrimento: sul ritorno dell’oppresso. Riv. Psicoanal., 2, 411-434.
CORSA R. (2021). Ibridi incarnati. Psicoanalisi e biotecnologie. In: Monterosa L., Iannitelli A. e Buonanno A. (a cura di), L’Ultracorpo. Psicoanalisi, corpi e biotecnologie. Roma, Alpes, 13-34.
DE CERTEAU M. (1975). L’écriture de l’histoire. Paris, Gallimard [La scrittura della storia. Milano, Jaca Book, 2006].
FEDERN E. (1985). È possibile scrivere una storia della psicoanalisi? In A.M. Accerboni (a cura di). La cultura psicoanalitica. Atti del Convegno Trieste 5-8 dicembre 1985. Pordenone, Studio Tesi, 1987, 89-96.
FREUD S., ZWEIG A. (1968). Briefwechsel. Frankfurt am Main, Fischer [Lettere sullo sfondo di una tragedia. Mhttps://www.spiweb.it/la-ricerca/libri-psicoanalisi/linconscio-e-les-di-j-laplanche-recensione-di-d-dalessandro/eghnagi D. (a cura di). Venezia, Marsilio, 2000].
GAUCHET M. (2010). Il figlio del desiderio. Una rivoluzione antropologica. Milano, Vita e Pensiero.
GIACOBBI S. (2019). Omogenitorialità. Ideologia, pratiche, interrogativi. Milano, Mimesis.
