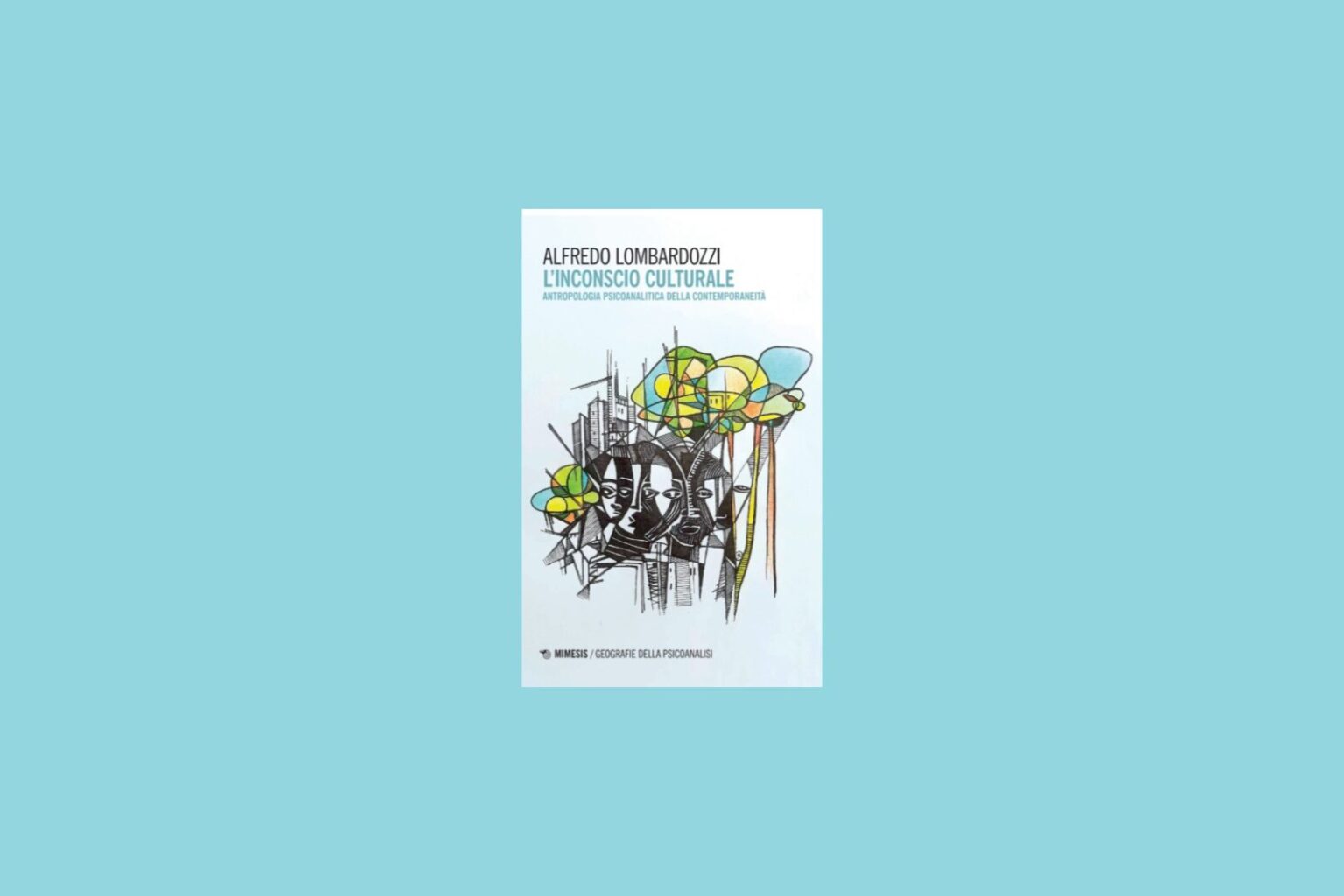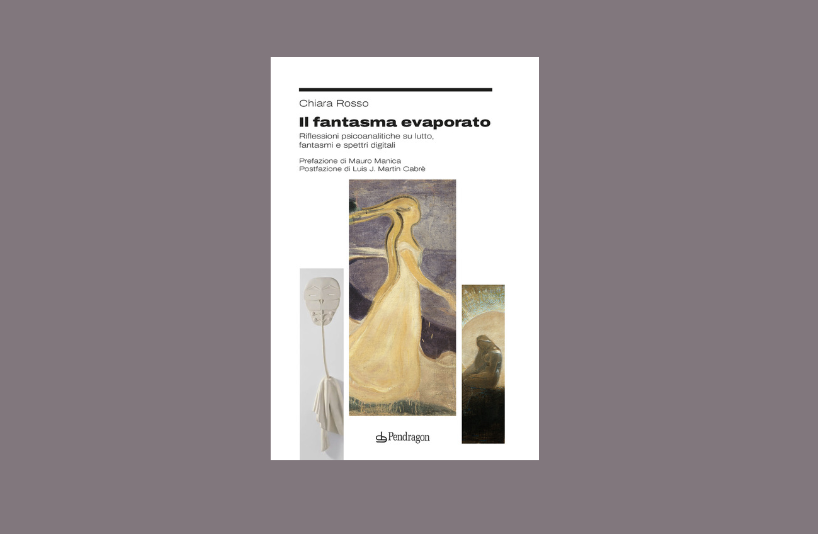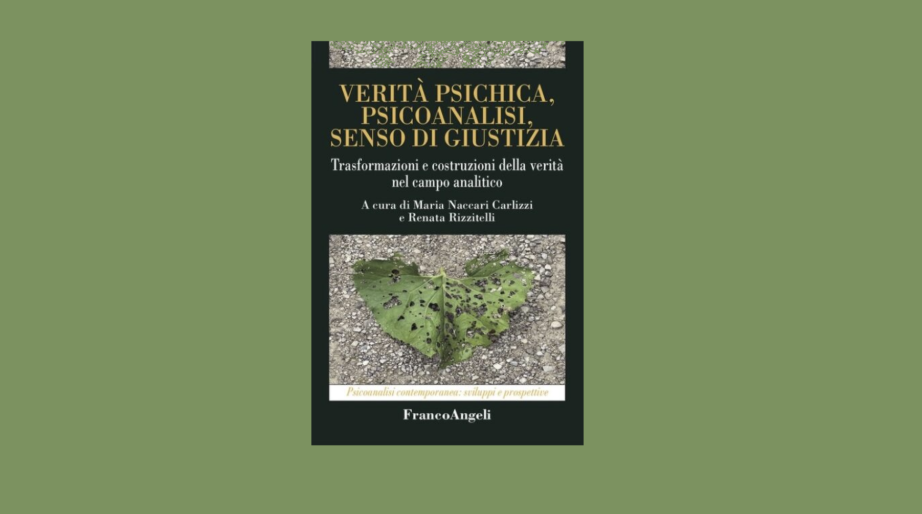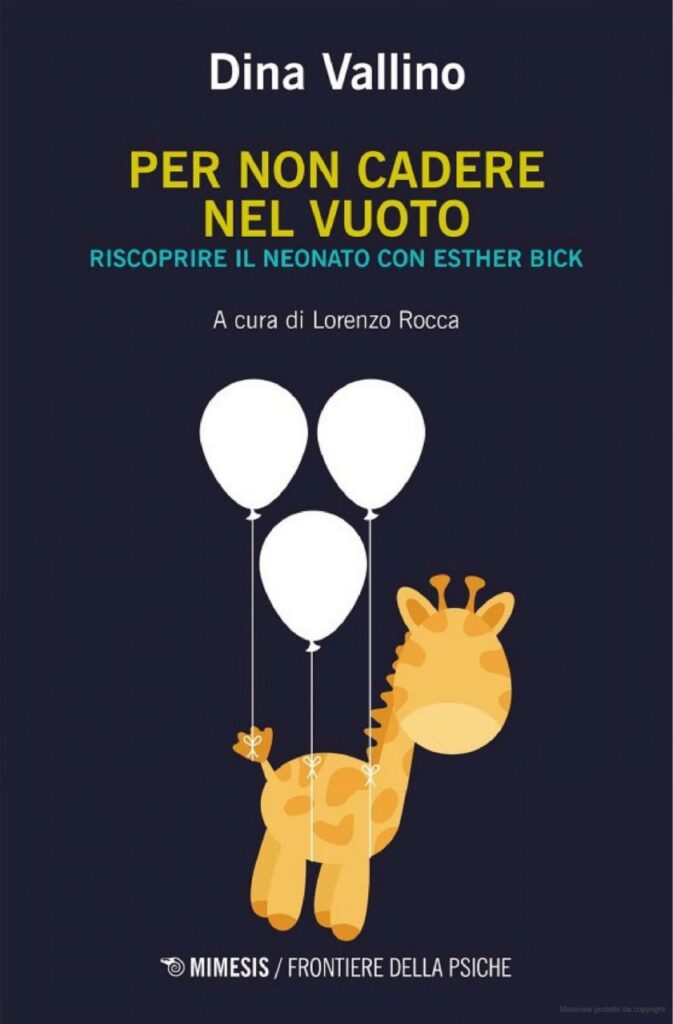
Parole chiave:angosce primarie, adesività, mente pre-simbolica, oggetto contenitivo
Con la recensione di Simona Pesce del libro di Dina Vallino “Per non cadere nel vuoto” inauguriamo uno spazio dedicato alle recensioni di quei libri che sono stati significativi per la propria formazione, quelli che “non passano”.
Cristina Sarno
“Per non cadere nel vuoto. Riscoprire il neonato con Esther Bick”
Dina Vallino. Mimesis 2019
Recensione di Simona Pesce
Nascere significa entrare nel regno della gravità.
“Quando un bambino nasce
si trova nella condizione di un astronauta
che è stato sparato fuori nello
spazio senza una tuta spaziale”
Esther Bick 1975
Si può dire che Dina Vallino sia una delle analiste che maggiormente ha diffuso l’opera di Esther Bick in Italia. Nel libroche presento l’autrice offre un’approfondita analisi dell’opera di Esther Bick mettendo in luce la sua originale concezione del neonato e la funzione contenitiva delle prime relazioni oggettuali. Nell’analizzare l’opera della Bick Vallino esplora i concetti di auto-contenimento, seconda pelle e adesività, ricostruendone l’evoluzione concettuale attraverso un’attenta lettura dei suoi scritti. Nel saggio inoltre si trovano materiali inediti come la nuova traduzione della conferenza di Esther Bick del 1975 e passi salienti del suo insegnamento orale del 1970 e del 1977. Si aggiunge il contributo di Donald Meltzer a questa tematica con la traduzione di tre suoi importanti scritti, che approfondiscono le nozioni di identificazione adesiva, looping e punto-morto.
Mi pare necessario rileggere oggi Esther Bick perché la sua è una voce fondamentale per comprendere aspetti dell’esperienza e della comunicazione neonatale che sta al cuore dell’esperienza umana precoce così cara alla ricerca psicoanalitica contemporanea.
Esther Bick, di origini ebraiche, fa un’analisi con Michael Balint a Londra dove entrambi emigrano negli anni ‘40 per sfuggire all’occupazione nazista: Bick dalla Polonia, Balint dall’Ungheria. Solo dopo aver concluso il training analitico farà una seconda analisi con Melanie Klein, ma fin dal 1949 John Bowlby le chiede di istituire un corso di formazione analitica presso la Tavistock Clinic di Londra e il suo metodo osservativo del neonato è ancora oggi utilizzato.
Il valore della rilettura della Bick ad opera della Vallino sta nel mostrare quanto questa analista sia stata influenzata dalla scuola di Budapest permettendole una descrizione originale delle angosce primarie e della teoria sul sadismo. L’intero capitolo V del libro è dedicato a questo tema rivalutando l’importanza del concetto di amore primario di Balint che è visto in una prima fase come un istinto di aggrappamento, ma che dopo il 1950 viene descritto come “un desiderio di essere tenuto saldamente dalla madre, un bisogno passivo, che del resto ben si accorda con il carattere passivo dell’amore primario, il voler essere amato non amando” (Vallino, pag 102). Dina Vallino inoltre mostra quanto Esther Bick si sia avvicinata alla teorizzazione bioniana della proto-comunicazione del neonato con la madre più che alla teorizzazione winnicottiana dell’holding materno. Il saggio offre quindi un’originale e ricca descrizione di concetti analitici chiave come la nozione di holding winnicottiana, che va differenziata dall’oggetto contenitivo primario, e la visione della scuola di Budapest dell’amore primario.
Il volume è composto da una Introduzione che descrive la genesi del volume nato da un saggio inedito di Dina Vallino, pubblicato dopo la sua scomparsa nel 2014. Lo scritto deriva dalla messa in bella della Conferenza di Bologna che nel 2006 l’autrice fece presso il Centro psicoanalitico Glauco Carloni per la presentazione della sua monografia “Essere Neonati”. Questo secondo volume ne sarebbe la prosecuzione, con la particolarità di voler mostrare il pensiero teorico della Bick, confrontandolo con gli autori a lei più cari: Winnicott, Klein, Bion, Ferenczi e Balint.
Nella prima parte del volume si riportano alcuni momenti salienti della vita di Esther Bick insieme alla storia della nascita del metodo osservativo per comprendere l’inconscio del neonato. Nei capitoli successivi viene discusso con attenzione il saggio più celebre del 1967: “L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali” e l’irrompere del concetto di Adesività del 1975.
Nell’articolo del 1967 la Bick parla dell’esperienza che il neonato fa di tenersi/essere tenuto insieme riferendosi all’esperienza primaria della pelle.
Il nucleo fondamentale della teorizzazione di Esther Bick è che il neonato, dopo il parto, abbia bisogno urgente di sentirsi tenuto insieme, ciò è dovuto al fatto che il neonato entra in un mondo che ha una forza di gravità che lui non conosce avendo vissuto dentro la placenta, che è per lui come una pelle, e immerso nei suoni intra addominali, nel calore e nella voce materna. Inizialmente non può sentirsi sicuro senza il contatto con un corpo che lo fa sentire integro. L’oggetto contenitore ottimale per il neonato è caratterizzato dall’esperienza di tenere in bocca il capezzolo, sentire l’abbraccio della madre, sentirne il calore e la voce arrivando a un’esperienza del corpo completo della madre. Secondo Esther Bick il rapporto con l’oggetto contenitore viene percepito dal neonato come una pelle.
“Le parti della personalità non si sentono intrinsecamente tenute insieme e si spandono fuori, a meno che non siano tenute insieme: è questa un’esperienza indistinguibile da quella del corpo che è tenuto insieme dalla pelle” (Bick, 1967).
L’assenza dell’esperienza dell’oggetto contenitore materno determina nel neonato una non integrazione corporea che si accompagna ad angosce catastrofiche.
La Bick formula quindi una teoria somato-psichica per cui il neonato è inteso con un soggetto dotato di una spinta al nutrirsi: la fame, una spinta determinata dal piacere: la sessualità infantile, e una spinta a cercare un oggetto contenitore: la comunicazione e l’attenzione che dirige alla madre. L’autocontenimento di cui parla la Bick, secondario a un difetto di funzione contenitiva dall’oggetto primario, si rifà ad alcune caratteristiche dell’esperienza di accudimento della madre, e in particolare a quella vocale e muscolare, in quella che lei teorizza la costituzione di una funzione di seconda pelle.
Il secondo lavoro del 1975 ripresenta la storia clinica di Mary, paziente già descritta nel ‘67, ma sotto una luce differente. Viene esplicitato come “questa storia era stata letta alla luce della nozione di identificazione proiettiva, mentre ora viene vista alla luce della nozione di identificazione adesiva. Risiede dunque qui il mutamento di idee tra i due saggi” (Vallino pag. 55). In realtà Dina Vallino ci dice che la Bick, nelle supervisioni e nei gruppi di discussione delle osservazioni del neonato, parlava di identità adesiva piuttosto che di identificazione adesiva, sviluppando un concetto solo accennato nel lavoro del ‘67 che riferiva l’adesività all’analisi di adulti e bambini e non di neonati. La Vallino insiste sull’idea di una identità adesiva perché il processo di identificazione presuppone l’esistenza e il riconoscimento di un secondo oggetto ancora inesistente per il neonato.
Nella rielaborazione teorica di questo articolo l’aspetto originale sta nelle riflessioni “sull’ attaccarsi”, argomento sviluppato nel quarto capitolo di questa prima parte del volume che si concentra sulla differenza tra “afferrare e aggrapparsi” e sul senso della uni- e bi-dimensionalità nelle esperienze primarie. La Bick scopre l’importanza della sensazione di adesione nello sviluppo del senso di continuità del sé, concetto da riferire a Winnicott ma collocabile in una fase più tardiva dello sviluppo, e si concentra sulla bi-dimensionalità dell’identità adesiva ritrovabile anche nell’adulto:
“L’angoscia catastrofica di cadere nello spazio, la situazione senza via d’uscita, blocca ogni richiesta e bisogno di cambiamento e genera uno stretto conservatorismo e la esigenza di essere, rimanere sempre lo stesso, di avere una stabilità e un sostegno da parte del mondo esterno. Questo può restare mascherato, laddove la formazione di seconda pelle costituisce un aspetto preminente del carattere; ma un improvviso collasso in condizioni di stress rivela la personalità sommersa, che fino allora sembrava abbastanza bene aggiustata, e produce la paura di esistere. Secondo la mia esperienza di analisi, questi pazienti richiedono un lento, continuo e saldo processo di contenimento” (Bick, 1975).
Sulla base dei pensieri presentati in questi due articoli Esther Bick ipotizza che nelle prime settimane di vita il neonato non sia in grado di interiorizzare un oggetto materno ma solo di farne esperienza come se fosse una pelle. Al contrario Dina Vallino ritiene che fin dalla nascita l’esperienza di essere contenuto dalla madre, di sentire il capezzolo in bocca contemporaneamente alla voce all’odore e al calore della madre, permette al neonato di mantenere la sua attenzione al corpo materno e attiva la sua memoria, nelle sue varie forme, creando una prima differenziare tra l’interno e l’esterno per poi poter operare un processo introiettivo. In ogni caso non poter introiettare e interiorizzare porta a un grave difetto della crescita mentale del neonato. Senza esperienza di oggetto contenitivo e senza capacità di introiettare non ci possono essere meccanismi successivi come la scissione e l’idealizzazione necessari nella fase SP.
La prima parte del saggio si conclude con un’appendice che contiene diversi brevi scritti sul rapporto tra il pensiero della Bick e quello di Melanie Klein, John Bowlby, Wilfred Bion e la Scuola di Budapest.
La seconda parte del volume contiene la traduzione di una supervisione condotta da Esther Bick per un seminario di gruppo di Infant observation tenutosi a Montevideo nell’agosto del 1970, ed è la prima pubblicazione in lingua italiana di questo documento. Segue un suo seminario presentato al 29° precongresso di Psicoanalisi, tenutosi a Londra nel luglio del 1975. Entrambi gli scritti sono estremamente interessanti perché, rispondendo alle domande dei partecipanti, la Bick offre pensieri illuminanti come, ad esempio, alla domanda di cosa si debba intendere con “holding” lei risponde:
“con il termine holding io mi riferisco alla pelle, la pelle che contiene. Questa pelle si rifà all’esperienza del bambino quando ha un capezzolo nella sua bocca e la madre lo nutre…la fantasia più primitiva…è di riversarsi fuori (splash out) come se si fosse un liquido” (Vallino, pag.107) o ancora quando riflette sulle difficoltà della tecnica analitica quando ci si trova nell’analisi di pazienti con le difficoltà che sta cercando di descrivere.
“I problemi della forza dell’Io, della bi-dimensionalità, dell’identificazione adesiva e della formazione di una seconda pelle risiedono in profondità nell’inconscio e hanno la loro origine precoce nel periodo pre-verbale. Per queste ragioni e per via delle ansie catastrofiche del punto-morto, del cadere attraverso lo spazio, del liquefarsi, della varietà del fuoriuscire-dalla-vita (life-spilling-out) che li aspetta, questi pazienti non si rendono disponibili a uno scrutinio analitico nel transfert a meno che il setting sia stato estremamente costante e la tecnica assai ferma” (Vallino, pag.134).
Seguono tre articoli di Meltzer, il primo sull’identificazione adesiva del 1974, il secondo è una discussione dell’articolo del 1975 della Bick, il terzo è sul Looping e il punto morto e risale al 1994.
Nell’articolo su l’identificazione adesiva Meltzer mostra come i pazienti che hanno una visione bi-dimensionale e non tri-dimensionale, che corrisponde all’esperienza dello spazio, o quadri-dimensionale, che corrisponde all’esperienza del tempo, hanno una sfiducia emotiva nel tempo come processo lineare. Meltzer arriva alla concettualizzazione sull’adesività lavorando con pazienti autistici e si concentra sulla bi-dimensionalità di questi pazienti, giungendo a scrivere che per questi bambini non ci sono realmente spazi, ma solo superfici a due dimensioni, le cose non sono solide ma soltanto superfici contro le quali possono appoggiarsi, sono bambini che fanno fatica a fare esperienza di uno spazio che può essere chiuso e quindi non riescono a utilizzarlo. Nella visione di Meltzer se non c’è strutturazione di uno spazio psichico il bambino fatica a costruire un linguaggio.
“Poi c’era la relazione bidimensionale alla superficie, nella quale non c’erano spazi, nella quale dunque non potevano aver luogo processi di identificazione e lo sviluppo non sembrava avviarsi perché non poteva usare né l’identificazione proiettiva, che richiede uno spazio nel quale entrare, né l’identificazione Introiettiva, che richiede spazio nel quale poter accogliere qualcosa” (Vallino, pag 153). All’interno del gruppo di ricerca sull’autismo si iniziò a pensare che quello che osservavano nei bambini autistici aveva a che fare con quanto studiato da Esther Bick nei suoi pazienti adulti e nei neonati e decisero di chiamarla identificazione adesiva. Secondo Meltzer questo processo ha origine prima della posizione schizo -paranoide e si può ritrovare in alcuni pazienti adulti che possono disorganizzarsi perchè non hanno una buona funzione dell’Io-pelle, e faticano ad utilizzare gli spazi interni degli oggetti per attuare veri processi di identificazione. Il centro di questo saggio sull’identificazione adesiva sta proprio nella differenza tra una identificazione proiettiva strutturante, che favorisce una soggettiva costruzione dell’identità e l’identificazione adesiva che si appiccica su una dimensione bi-dimensionale, e non avendo esperienza né di spazi né di tempo non porta ad apprendimento. Tutta la teoria dell’identificazione proiettiva di Melanie Klein, che deriva dal lavoro fatto insieme ad Abraham, è una teoria degli spazi psichici, e la grande importanza del suo studio è indirizzata a interrogarsi sugli spazi dentro sé e dentro gli oggetti, luoghi in cui avvengono cose concrete.
Interessante è la differenziazione che Meltzer fa tra l’identificazione adesiva e il falso sé di Winnicott, quest’ultimo non fa parte della fenomenologia dell’identificazione proiettiva e ha a che fare con un tipo di adattamento all’ambiente. L’identificazione adesiva assomiglia di più alle personalità “come se” di cui parlava Hellen Deutsch nel 1942.
Gli ultimi capitoli del libro riportano due scritti inediti di Meltzer nei quali l’autore mette in comunicazione quelli che ritiene essere i due più brillanti allievi della Klein: Bion e Bick. Secondo Meltzer la personalità che si tiene con la pelle (skin-container personality), la descrizione di bi-dimensionalità nei bambini nello stato post autistico e la distinzione di Bion tra struttura della personalità eso e endo-scheletrica possono essere viste come identiche.
Le osservazioni cliniche che hanno portato Ester Bick a formulare l’ipotesi della seconda pelle e hanno dato la possibilità a Meltzer stesso di teorizzare la bi-dimensionalità nell’autismo sono poi state spiegate dalla teoria del pensiero di Bion come aree non simbolizzate della mente.
Il saggio si chiude con alcune acute riflessioni sull’esperienza dello sviluppo infantile, viene riportata l’idea che la Bick aveva della spinta alla crescita. Lei riteneva che quest’azione avesse un andamento spiraliforme, unita a una spinta a procedere nello sviluppo, presente nella maggior parte dei neonati con un ritmo e un movimento specifico; in alcuni neonati al contrario aveva osservato la mancanza di questa spinta in avanti, che l’autrice chiama il fenomeno del Looping che fa ritornare ogni giorno allo stesso punto. L’intuizione della funzione di Looping si associa a quello che la Bick chiama il punto-morto, o impasse mortale, che è l’impossibilità ad arrivare “ad una fine”, dovendo continuare a ripetere e ripetere qualcosa finché non divenga qualcos’altro, che sia un verso, un movimento o un’azione. Il Looping e il punto morto sarebbero due potenti freni alla forza dello sviluppo psiche/corpo del bambino.
Dina Vallino ci porta a rileggere questi lavori ricordandoci così l’insegnamento fondamentale del metodo dell’osservazione diretta del bambino, insegnamento che riguarda l’assoluta unicità di ogni coppia madre-bambino e di ogni processo di sviluppo infantile con ritmi e andamenti specifici di quella particolare situazione, che porta l’analista a mantenere un’elasticità nel guardare e osservare senza ricorrere immediatamente ad alcuna spiegazione teorica.
Bick E. (1963). Note sull’osservazione del lattante nell’addestramento psicoanalitico. In Bonaminio V., Iaccarino B. (a cura), L’osservazione diretta del bambino, Torino, Bollati Boringhieri, 1984.
Bick E. (1968). L’esperienza della pelle nelle prime relazioni oggettuali. In Bonaminio V., Iaccarino B. (a cura), L’osservazione diretta del bambino, Torino, Bollati Boringhieri, 1984.
Bick E. (1975). Ulteriori considerazioni sulle funzioni della pelle nelle prime relazioni oggettuali: integrando i dati dell’“infant observation” con quelli dell’analisi dei bambini e degli adulti. Riv. Psicoanal., 30, 341-355, 1984.