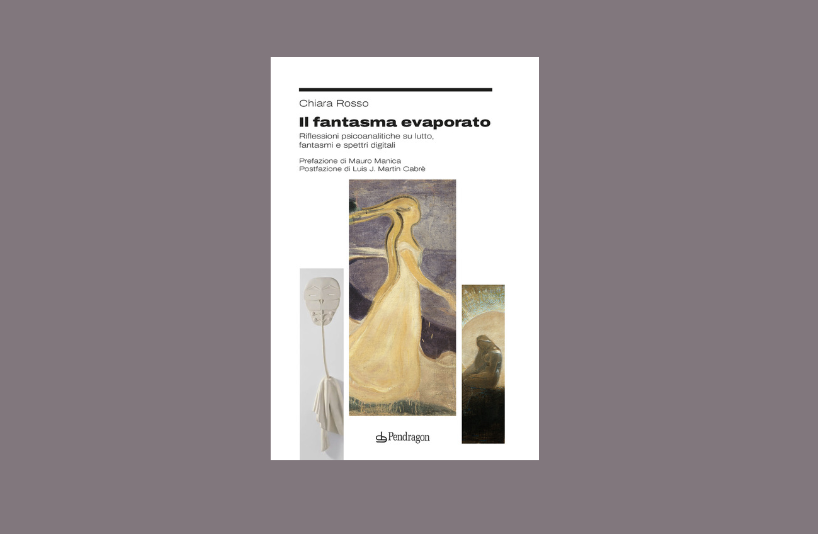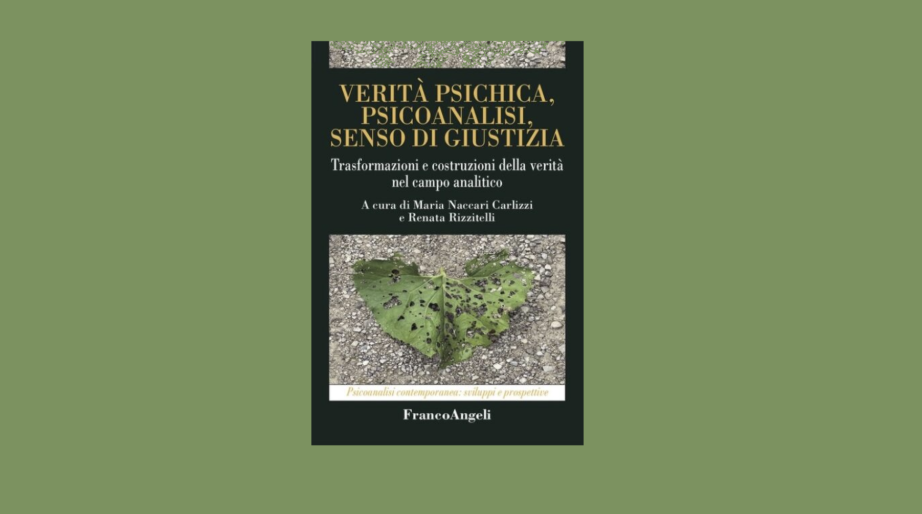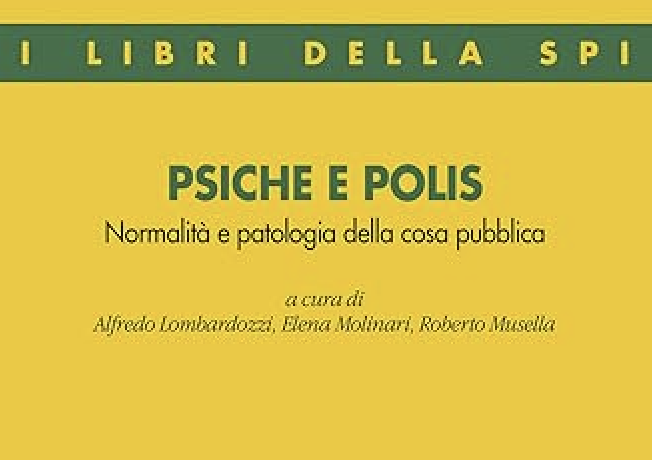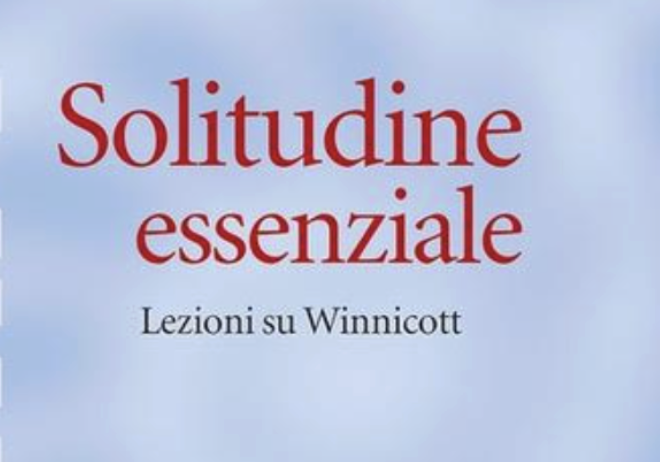
Parole chiave: Oggetto trasformativo, Conosciuto non pensato, Illusione, Realtà
“Solitudine essenziale. Lezioni su Winnicott”, Christopher Bollas, Raffaello Cortina Editore, 2025
Recensione di Annalisa Amadori
“… Winnicott discute elementi di psicoanalisi che abbiamo trascurato, che abbiamo permesso sfuggissero alla nostra attenzione. La storia della psicoanalisi … è, in parte, la storia degli spostamenti di persone che hanno sofferto persecuzioni. Pertanto, è comprensibile che la psicoanalisi si sia concentrata sulla distruzione, la perdita, il dolore, il lutto. Credo, tuttavia, che sia ora necessario cercare di riscoprire gli argomenti su cui Freud ha scritto, in molti modi, negli anni antecedenti alla Prima guerra mondiale, quando si occupò della natura della sessualità, della storia della libido e del costituirsi del desiderio” (p. 28). Lo sguardo diretto al recupero delle radici della psicoanalisi rappresenta lo spirito che anima il testo di Bollas; esso è formato dalla raccolta delle lezioni da lui tenute all’Università La Sapienza di Roma tra il 1986 e il 1987. La ricerca psicoanalitica di Winnicott, in questa luce, si arricchisce non solo di sfumature, ma viene ricondotta, attraverso l’approfondimento dei concetti cardine, alla sua originalità.
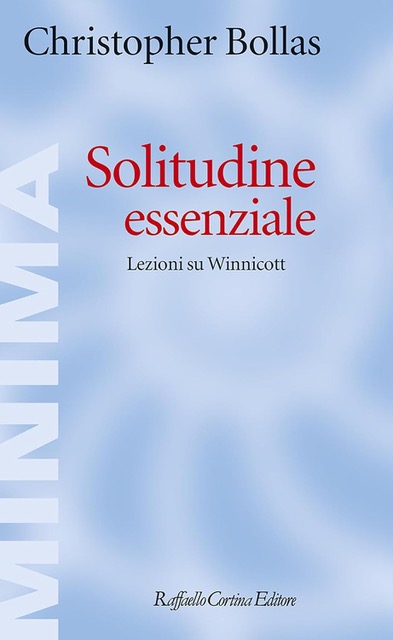
Partiamo dal titolo: “Solitudine essenziale”. Il termine inglese impiegato da Winnicott è “aloneness” e descrive uno stato dell’essere coincidente con la condizione di poter essere soli. Non si tratta, dunque, di un sentimento di abbandono e di tristezza (come espresso da “loneliness”), ma di una fase fisiologica nello sviluppo del bambino: “la solitudine dell’infante pre-dipendente” (p. 1) sovrapponibile al concetto di “conosciuto non pensato” elaborato dallo stesso Bollas. La solitudine del neonato che emerge dallo stato di “non essere” (definito “condizione inorganica” da Freud) precede la consapevolezza di essere vivo; l’intervento della madre è fondamentale per rendere positiva questa solitudine e offrire una mediazione nei confronti della realtà: “il feto evolve da uno stato di non-vita a uno stato di solitudine” (p. 2). Tale transizione resterà nell’inconscio a influenzare l’idea soggettiva di vita e di morte. La radice di questa riflessione è contenuta in “The Primer”, il libro segreto che Winnicott scrisse tra il 1954 e il 1971, per conservare il nucleo delle proprie teorie e procedere a ulteriori elaborazioni, senza aver pensato di pubblicarlo. Una posizione simile era stata espressa da Heidegger nel 1927, quando aveva indicato che l’essere non precedeva l’esistenza, ma formava un luogo in cui l’esistenza era resa possibile e poteva realizzarsi. Winnicott amplia il concetto di essere e di esistenza, descrivendo i passaggi evolutivi che vanno dalla solitudine all’istinto, alla dipendenza assoluta, alla dipendenza relativa, all’autonomia. Essenziale risulta l’espressione dell’aggressività, già presente, secondo lui, nell’illusione dell’infante di avere, grazie a questa, prodotto la propria nascita. “Vi è un legame cruciale tra l’essere e l’aggressività” (p. 4), come base della vitalità aggressiva che crea lo spazio per i primi atti d’amore. Siamo in una fase antecedente la “preoccupazione responsabile”; per uno sviluppo sano, è importante che il bambino sperimenti la propria aggressività e che questa sia accolta e tollerata dalla madre fin dall’inizio della vita. Su tali presupposti il bambino potrà arrivare all’uso dell’oggetto e a esprimere forme di “distruttività positiva” (p. 45) mediante le quali egli riesce a “divorare” il seno, a distruggere, poi a ritrovare la madre. L’espressione della distruttività positiva richiama un concetto analogo espresso da Hegel nella “Fenomenologia dello spirito”, dove, lungo il processo di definizione della realtà, attraverso la formulazione di tesi, antitesi e sintesi, considera come la negazione, manifesta nell’antitesi, costituisca un progresso e generi una nuova affermazione. Ciò che viene negato non è, però, superato e cancellato, ma incluso a un livello superiore per essere trasformato e impiegato in ulteriori forme di conoscenza e di contatto con la realtà. Allo stesso modo, per Winnicott, l’uso spietato dell’oggetto è espressione dell’“amore primario” (p. 45) e permette la conservazione e recupero dell’oggetto dopo averlo “consumato”.
Il concetto di “uso dell’oggetto” è uno dei più controversi nella teoria winnicottiana, anche per le differenze con Melanie Klein. A questo livello primitivo di sviluppo, Winnicott osserva che l’infante non è in grado di attuare meccanismi di riparazione; questi competono alla madre e alla sua capacità di far sentire accolto il bambino, rispecchiando il suo bisogno aggressivo. Tutto ciò ha ripercussioni nella clinica, laddove la schizofrenia assume i caratteri della morte psichica per un soggetto non sufficientemente visto, accolto o rispecchiato al punto che “la sua vita istintuale non può essere integrata col suo sviluppo cognitivo” (p. 46). Affini difficoltà si rintracciano nella patologia maniacale, dove la riparazione non è possibile a causa dell’odio, mentre il paziente entra in una dimensione senza tempo, “poiché non è riuscito a vincolare un senso del tempo attraverso la relazione con l’oggetto” (p. 47)
Su questa linea, è possibile esplorare la differenza esistente fra “madre oggetto” e “madre ambiente”: la prima “è il bersaglio dell’esperienza eccitata sostenuta dalla tensione istintuale allo stato grezzo”, mentre la seconda “riceve tutto quanto è definito come affetto e come sentire condivisibile” (p. 97). Di fatto, l’uso dell’oggetto presuppone l’esistenza di una scissione tra le due funzioni materne: scissione che è la stessa madre a mantenere. La scissione individuata da Winnicott differisce da quella kleiniana, nella quale è, invece, il bambino a creare una separazione tra oggetti buoni e cattivi; dopo aver idealizzato il seno buono e averlo protetto dagli attacchi distruttivi del seno cattivo, l’infante raggiunge la posizione depressiva, in cui i due oggetti devono mescolarsi per diventare reali internamente. “Winnicott non dissentirebbe totalmente da questa concettualizzazione, ma aggiungerebbe che la madre sostiene la scissione e -potremmo aggiungere noi- ne trae piacere” (p. 99). Il piacere della madre nel ricevere l’attacco del bambino (relazione d’oggetto “in-formativa”) consente di realizzare, attraverso la poppata, la sequenza formata da “bisogno – attacco – piacere” (p. 100). Ciò che Winnicott sottolinea è come la madre buona sia una creazione reciproca del rapporto mamma – lattante nel contesto della fusione istintuale. Rispetto a Freud, Winnicott introduce questa funzione materna; rispetto alla Klein (estranea all’idea di una madre contenta di essere usata) egli esprime il concetto di “jouissance”: diritto universale all’estasi, in questo caso reciproca.
La precisazione dei concetti principali riesce a rendere meglio espliciti aspetti della teoria ormai d’uso comune, che acquistano maggior spessore se si segue il percorso teorico con cui Winnicott li sviluppò. Prendiamo la formulazione riservata agli oggetti e ai fenomeni transizionali. Transizionale è un termine che designa l’area intermedia dell’esperienza (in-between): né all’interno della psiche (spazio dell’illusione e dell’allucinazione) e neppure nel mondo esterno (luogo degli oggetti reali). Va sottolineato come proprio la qualità dello spazio intermedio sia all’origine esclusiva degli aspetti transizionali che investono i fenomeni e gli oggetti, rappresentando “il primo possesso non me”; la loro consistenza è di non poter essere il soggetto e di non incarnare le caratteristiche della realtà esterna. Allo stesso modo, quando lo spazio intermedio è rappresentato dalla seduta d’analisi, esso offre al vero Sé del paziente quella capacità creativa che può renderlo animato “nella propria aggressività, sensualità, giocosità” (p. 52). Anche per questo, l’eccesso di interpretazione da parte dell’analista rischia di escludere nel paziente l’esperienza del reale, in quanto finisce per ricondurre continuamente la sua narrazione a scopi psicoanalitici. Si può osservare come la formulazione dello spazio transizionale di Winnicott richiami la risposta di Hegel alla kantiana “Critica della ragion pura”, quando il filosofo afferma che “non afferriamo la cosa in sé, ma facciamo esperienza della cosa in sé. Anche se non siamo in grado di rappresentare la cosa, l’abbiamo sperimentata e da essa siamo stati plasmati” (p. 51).
“All’interno della capacità di far uso dell’illusione, compare il vero Sé” (p. 152). L’impiego dell’illusione è centrale tanto nella teoria quanto nella tecnica winnicottiana al punto di essere paragonabile all’utilizzo delle libere associazioni in Freud (p. 151). La centralità dell’illusione nello sviluppo infantile è collegata alla continuità offerta dalla preoccupazione materna primaria, quando la madre sufficientemente buona consente al bambino l’illusione “che il seno buono sia sempre disponibile” (p. 61), permettendogli di mantenere il sentimento di onnipotenza di avere lui stesso creato il seno. Alla base della fiducia sta il poter sperimentare l’illusione e poi di fare ritorno alla concretezza della realtà. Lo sviluppo di allucinazioni è, dunque, il risultato di un viaggio compiuto attraverso l’illusione senza la possibilità di un ritorno a causa di carenze nella continuità offerta dalla madre.
Il vero Sé fu inteso inizialmente da Winnicott come un termine “in grado di rappresentare l’opposto di quello stato d’ansia che genera il falso Sé” (23). Esso nasce come conseguenza dell’unità formata dall’ambiente e dall’individuo ed emerge dal potenziale ereditato grazie alle cure materne. “In un certo senso, il vero Sé è essere vivi” (p. 24); esso nasce primariamente, a partire dai dati sensoriali e motori, come spinta vitale alla quale l’ambiente e le cure materne conferiscono senso e possibilità di manifestarsi. Espressioni della spinta vitale sono i gesti creativi e gli atti di spontaneità, la sensualità (“integrazione psicosomatica e narcisismo positivo”) e l’apprezzamento del piacere, l’espressione della vita istintuale e l’acquisizione di una realtà personale interna. Il mondo interno differisce dalla realtà personale interna, in quanto questa mantiene una continuità con l’ambiente così da farci percepire “che siamo gli artefici della nostra esistenza” (p. 26). E su questo piano, non va trascurato come, a partire dalla solitudine essenziale, la continuità dell’essere contenga già, nel patrimonio del “nocciolo” di esistenza ereditato, alcuni nuclei del vero Sé che potranno successivamente svilupparsi.
Creazione della realtà: è questa la visione del bambino che si pone all’opera attraverso l’impiego dell’illusione e l’espressione del vero Sé. A questo aspetto di integrazione viene dato valore nell’analisi winnicottiana soprattutto per trovare il modo di “affrontare la scissione di base della personalità” (p. 27). Anche la creazione del simbolo è un atto connesso al piacere, in quanto il bambino, attraverso la soggettività, giunge alla simbolizzazione grazie alla presentazione degli oggetti piacevoli che la madre gli offre. La simbolizzazione è la creazione di un sostituto dell’oggetto; la Klein la descriveva come un’operazione condotta sotto la spinta dell’ansia connessa al seno come oggetto primario.
Il valore di questa ampia lettura di Winnicott consiste anche nella “celebrazione” di uno stato creativo continuo che attraversa l’intera vita umana, dove il piacere della relazione con l’oggetto e del contatto con sé stessi viene mediato da uno stato di fiducia primaria, fiducia che a livelli profondi può essere recuperata attraverso la ripetizione di buone relazioni, includendovi anche un’esperienza psicoanalitica ben condivisa tra paziente e analista.
BIBLIOGRAFIA
Hegel G. W. F. (1807). La fenomenologia dello spirito. Einaudi, Torino, 2008.
Heidegger M. (1927). Essere e tempo. Mondadori, Milano, 2017.
Kant I. (1787). Critica della ragion pura. Bompiani, Milano, 2024.
Winnicott D. W. (1958). Dalla pediatria alla psicoanalisi. Martinelli, Firenze, 1975.
Winnicott D. W. (1971). Gioco e realtà. Armando, Roma, 2006.
Winnicott D. W. (1945-71). Il sentimento del reale. R. Cortina ed., Milano, 2025.