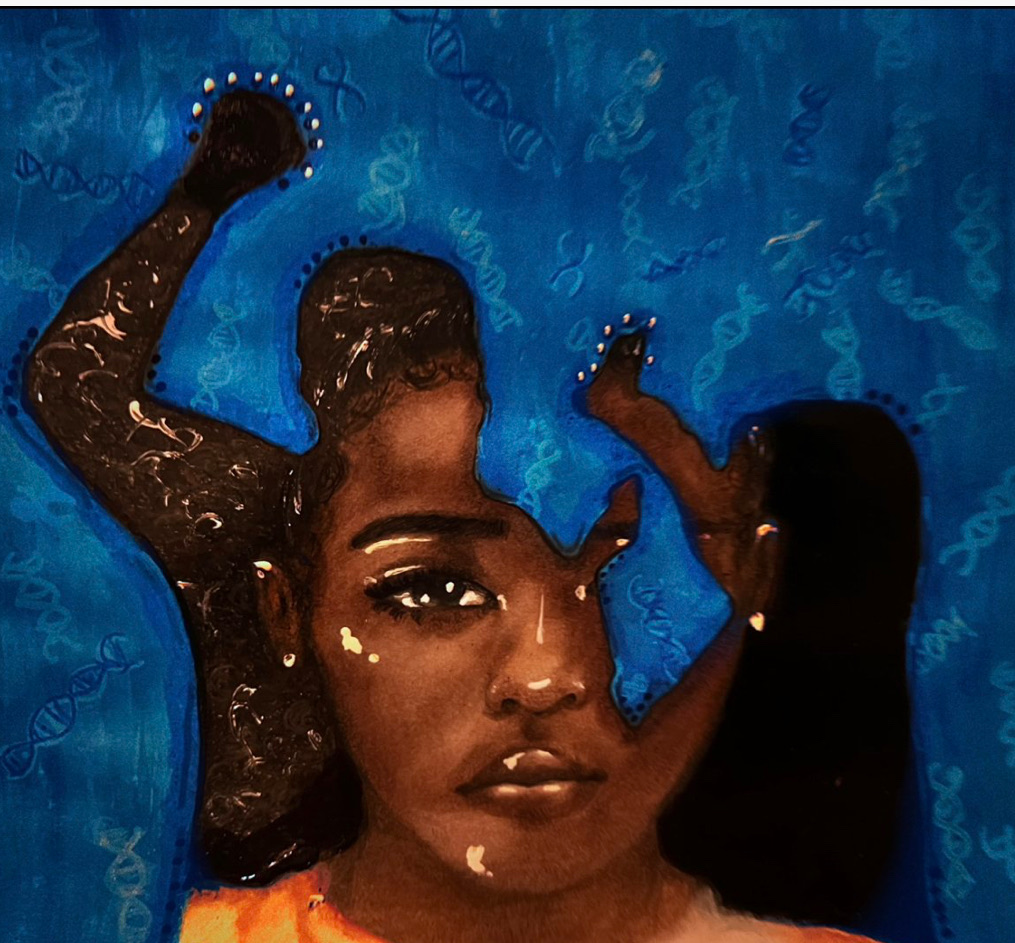Parole chiave: Mirror neurons, Neuroscienze affettive, Neuroscienze sociali, Psicoanalisi e informatica, Psicoanalisi e intelligenza artificiale, Psicoanalisi e psicoterapia, Ricerca evolutiva
Presentiamo la prima delle interviste che SPIWEB intende proporre a psicoanalisti della SPI che, nel corso degli anni, sono stati attivi promotori di dialogo tra la psicoanalisi, la ricerca neuroscientifica e le discipline della mente. Iniziamo da Silvio Merciai per il suo antesignano ruolo nell’avvio di quel confronto tra la psicoanalisi e le neuroscienze che adesso è al centro di più ampi riconoscimenti nella nostra società.
INTERVISTA A SILVIO MERCIAI
a cura di Amedeo Falci
(Merciai) Caro Amedeo, grazie per l’interesse tuo e di SPIWEB – Psicoanalisi e neuroscienze nei miei confronti. Ho letto le domande che mi proponi per l’intervista (avviso al lettore che sono ben dieci!); mi sono sembrate molto interessanti e stimolanti, ma anche tali da mettere a dura prova il contenimento del mio narcisismo…, spero di cavarmela!
(Falci) Caro Silvio, intanto, ben ritrovato! Come prima domanda ti chiederei di tracciare un tuo profilo professionale: la tua laurea in medicina, i tuoi interessi successivi, i tuoi primi contatti con la psicoanalisi, il tuo iter formativo, il tuo lavoro clinico, ed infine, quali i tuoi impegni didattici, formativi ed istituzionali.
(M) Sai, credo di essere e di essere sempre stato solo una persona curiosa e ben disponibile allo studiare per seguire il filo delle mie passioni; credo anche di avere avuto la fortuna di incontrare maestri generosi che si sono presi cura della mia crescita personale.
Mi piace pensare che la filosofia, che ho molto amato durante il mio percorso liceale, abbia concorso a costruire in me un’attitudine critica di disponibilità al dubbio, di apertura al dialogo con posizioni diverse dalle mie, di consapevolezza delle limitazioni e delle aporie delle mie conoscenze; a costruire quel senso della libertà, mi verrebbe da dire, che, certo, mi ha spesso messo in difficoltà con i vincoli delle appartenenze, ma che poi si è consolidato durante la mia analisi con Tommaso Senise, che di libertà scriveva e che del perseguimento di essa aveva fatto il suo canone etico di riferimento.
La laurea in medicina a Torino (1971), la specialità in psichiatria a Milano (1975), la scuola di psicoterapia di via Ariosto a Milano (dal 1976 al 1980), ed infine, quando potei permettermelo, il training alla SPI, conclusosi con l’associatura nel 1990, furono come una specie di viaggio abbastanza lineare in quello che avevo disegnato come il percorso ottimale della mia formazione.
Per una serie di circostanze sfavorevoli dovetti rinunciare al progetto, che si prospettava per me molto gratificante, di intraprendere la carriera universitaria, dove immaginavo avrei potuto ben coniugare il mio interesse per la ricerca con la possibilità di insegnare. Fui in parte risarcito, anni dopo (dal 2005 al 2013), dalla possibilità di diventare docente a contratto alla Facoltà di Psicologia (a Torino, poi ad Aosta e infine al San Raffaele di Milano, in un corso gestito insieme a Vittorio Gallese), e di insegnare in alcune scuole di specializzazione in psicoterapia (a Milano, a Prato e a Ravenna, a partire dal 2015, un impegno tuttora in atto).
Mi ero nel frattempo dedicato, secondo lo spirito del tempo, al lavoro di deistituzionalizzazione dei pazienti psichiatrici lavorando nei servizi territoriali di salute mentale della mia città. Condussi un esperimento pilota che ebbe un certo successo, ma che l’evoluzione delle temperie politiche di allora finì poi con lo stroncare (o, se vuoi, fui io a rifiutare curvature e forzature che non mi parvero accettabili), portandomi, alcuni anni dopo, alla sofferta decisione di lasciare il lavoro pubblico.
Da allora mi sono essenzialmente dedicato al lavoro di psicoanalista e psicoterapeuta nel mio studio a Torino. Al Centro Torinese di Psicoanalisi ebbi la fortuna di incontrare Parthenope Bion e di studiare, sotto la sua guida, il pensiero bioniano. Se vuoi, Taming Wild Thoughts (Addomesticare i pensieri selvatici), che tradussi in italiano sotto la curatela di Francesca Bion e con una prefazione della stessa Parthenope, in occasione della International Centennial Conference on the Work of Wilfred R. Bion che organizzammo a Torino nel 1997, rappresentava simbolicamente la cifra del mio obiettivo di rimanere libero e mentalmente vivo.
(F) Credo che tu sia stato tra i primi analisti ad interfacciare la psicoanalisi italiana con il web. Come sei arrivato a quella pionieristica iniziativa di webmaster per la SPI?
(M) Iniziando la mia attività nei servizi territoriali di salute mentale avevo partecipato ad un progetto di mappatura della realtà socio-demografica della popolazione, che aveva potuto avvalersi dell’uso del mini-computer dell’Università: ore passate a preparare schede perforate (erano gli anni ’70!) per ricavarne poi significativi dati statistici. Rimasi, ricordo, affascinato da quello strumento e, appena mi fu possibile, cominciai a fare esperienza della nascente disciplina dell’informatica compilando i miei primi programmi, certo molto semplici, sul mio Commodore 64.
L’avvento dei personal computer mi trovò naturalmente molto interessato e motivato ad apprendere le potenzialità dello strumento, che un modem mi consentiva di utilizzare in rete con altri (erano i BBS: non esisteva ancora Internet!). Un master in Intelligenza artificiale e sistemi esperti, conseguito nel 1988, mi aiutò a sistematizzare le mie conoscenze in termini di linguaggi di programmazione e di comprensione dei possibili sviluppi della disciplina. La svolta avvenne nell’incontro con un amico ricercatore — Gian Paolo Zara — che utilizzava la meravigliosa novità costituita da Internet (con una complicata interazione a caratteri, non certo con le icone delle moderne applicazioni). Egli riuscì a farmi mettere a disposizione una delle prime connessioni disponibili in Italia e cominciai un fantastico viaggio di esplorazioni, nuove conoscenze e incontri che non si è mai fermato; il quotidiano cittadino, La Stampa, mi offrì la possibilità di farne divulgazione con una rubrica bisettimanale (1995-1996).
Grazie alla disponibilità dell’Esecutivo SPI del tempo, ed in particolare della segretaria Andreina Robutti, lanciammo e realizzammo il piano di informatizzazione della SPI (avevo scritto le specifiche sotto le quali la struttura centrale avrebbe finanziato per ogni centro l’acquisto di un personal computer, di una connessione a Internet e di un indirizzo di posta elettronica). Il passo successivo, seguendo l’esempio della American Psychoanalytic Assaciation (APsA), fu di proporre che la SPI avesse un suo sito (fummo la prima società IPA in Europa!) e una sua mailing list dedicata (1996).
L’anno successivo (1997), organizzando sotto la guida di Parthenope Bion la Centennial Conference, chiedemmo agli autori, i cui contributi erano stati accettati dal nostro comitato editoriale per essere presentati al convegno, di rendere disponibili le bozze preliminari dei loro testi onde pubblicarli sulla rete (li trovi ancora a questo collegamento) e sottoporli ad una possibile discussione tramite una mailing list dedicata.
(F) Ricordo anche la tua iniziativa — credo prima esperienza nell’ambito della psicoanalisi italiana — di pubblicare online, nel 2000, l’esperienza dei tuoi anni di insegnamento del corso di Psicosomatica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. Si potrebbe dire che sia iniziata lì quella tua felice avventura culturale di spingersi oltre i confini della psicoanalisi per tentare di coniugare lo sviluppo della disciplina con l’immensa mole di apporti che provengono dalle scienze neurobiologiche?
(M) Sì, mi parve naturale e profittevole replicare lo schema della Centennial Conference (sito e mailing list) a Torino con il corso di Psicosomatica, e poi in tutte le mie successive esperienze di insegnamento universitario; ebbi l’impressione che gli studenti lo apprezzassero. Cercando di prepararmi a tenere il corso (la psicosomatica mi era stata assegnata, non era una mia scelta specifica), ebbi la fortuna di imbattermi nel testo da poco pubblicato di Antonio Damasio, The Feeling of What Happens (2000). Fu, ricordo, un momento emozionante, perché da una parte mi parve di poter dare spazio alle intuizioni di Bion che aveva di sovente sottolineato quanto il nostro apparato mentale fosse inadeguato ai suoi compiti e dall’altra parte di riconnettermi a quella parte di me che, durante il corso di medicina, si era interessata ed aveva studiato di neurobiologia (per anni avevo lavorato nel laboratorio di neurochimica e mi ero poi laureato con una tesi sperimentale sui mediatori colinergici dei farmaci ansiolitici).
Come puoi immaginare, mi misi a studiare, con rinnovato entusiasmo, utilizzando in modo intensivo la sterminata biblioteca che Internet mi rendeva disponibile.
(F) Il libro La psicoanalisi nelle terre di confine (Cortina, 2009) di cui tu sei stato autore insieme a Beatrice Cannella, è un libro innovativo, di amplissimo respiro, che spazia dal cognitivismo, all’evoluzionismo, alle ricerche sulle emozioni ed i sentimenti, alla neurobiologia del relazionale, ed anche alle ricadute delle neuroscienze sulla psicopatologia e sulle psicoterapie. Ecco, pensi che sia un libro che abbia aperto nuovi orizzonti di approfondimento ed interesse nella comunità psicoanalitica italiana, oppure ritieni che sia stato un libro recepito ed apprezzato principalmente da alcuni settori di psicoanalisti interessati alla ricerca ed agli aggiornamenti scientifici?
(M) L’incontro con Beatrice, compagna di studi e di vita, è stato certamente un altro degli avvenimenti fortunati della mia storia; al mio entusiasmo, talvolta ingenuo, lei opponeva la critica di una solida preparazione ed esperienza in psicologia clinica e sociale; abbiamo così potuto strutturare una valida cooperazione (vivificata da parecchie discussioni!) che si è poi ripetuta in numerose successive pubblicazioni scritte a quattro mani.
La psicoanalisi nelle terre di confine trasponeva sulla carta stampata l’esperimento in atto da qualche anno di un testo (gratuito) solo virtuale, in possibile continuo aggiornamento: Pionieri o emigranti (lo avevamo intitolato così prendendo in prestito una felice formulazione di Diego Napolitani). Si trattava di una pubblicazione essenzialmente rivolta ai nostri studenti, come tentativo di mettere un punto ad anni di ricerca, per poi da lì ripartire. Un testo che non aveva grandi ambizioni, ma era uno dei primi (pochi) che sarebbero poi comparsi sul tema del dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze, sulla scia del lavoro pionieristico che avevano svolto in Italia in quegli anni un gruppo di colleghi napoletani (ricordo qui i miei contatti con Franco Scalzone) e Mauro Mancia a Milano.
A posteriori direi che sia stato proprio il libro curato da Mancia (Psychoanalysis and Neuroscience, 2006) a tentare di aprire nuovi orizzonti nella comunità psicoanalitica italiana, Difficile dire se vi sia riuscito, poiché quello che Mancia andava proponendo era un approccio certo molto destabilizzante, con molti ostacoli e parecchie incomprensioni, di cui lui fu molto rattristato…
Il nostro libro del 2009 era solo il tentativo di tener vivo l’interesse, e insieme di indicare una possibile linea metodologica da perseguire. Non, cioè, partire dalla teoria psicoanalitica per assimilare corrispondenze o eventuali conferme dalle acquisizioni delle neuroscienze (che è, per esempio, la linea di tendenza della neuropsicoanalisi classica), ma invece leggere e spaziare nel mondo delle neuroscienze cercando di renderle meno mindless, secondo la recente fortunata espressione di Filippo Cieri, tenendo, per così dire, le nostre conoscenze psicoanalitiche nel backstage della mente alla ricerca di possibili suggestioni o della possibile creazione di nuovi pensieri selvatici (che è, per esempio, la direzione che mi pare abbiano cercato più recentemente di assumere i lavori di Rosa Spagnolo e del suo gruppo romano IPD/NPSA).
(F) In connessione con la questione precedente, credi che la psicoanalisi, dopo un secolo e passa di grande “splendido isolamento” (Freud, 1914) scientifico rispetto al vertiginoso sviluppo delle neuroscienze, sia in grado di mettere dialetticamente a confronto i suoi paradigmi, modelli e quadri teorici con gli apporti di campi disciplinari esterni ad essa? Non mi riferisco solamente al campo delle neuroscienze, ma anche al campo della biologia, delle scienze cognitive, delle filosofie della mente, delle scienze informatiche, della ricerca evolutiva, ed altre ancora.
(M) Non so dirti se la psicoanalisi sia in grado, ma certo in tutti questi anni di studio mi sono convinto che avesse ragione Eric Kandel (1999) quando diceva, già venticinque anni fa, che questa apertura al dialogo è indispensabile se vogliamo che la psicoanalisi mantenga la sua vitalità. Più che la filosofia e le discipline umanistiche, da sempre più consentanee alla formazione psicologica, occorre, a mio avviso, che la psicoanalisi si avventuri – più di quanto abbia fin qui fatto – per i sentieri affascinanti delle neuroscienze, da un lato, e dell’informatica, dall’altro, lasciandosene contaminare senza troppa paura di perdersi.
Le suggestioni di questi anni di frequentazione dei testi di neurobiologia sono state molteplici e per me appassionanti. Penso alle teorie computazionali del codice predittivo ed all’elaborazione assai complessa che ne ha fatto Karl Friston, ma soprattutto alle prospettive aperte delle cosiddette neuroscienze cognitive:mi riferirei all’affective neuroscience – lo studio sperimentale degli affetti e delle emozioni, della motivazione e del piacere – ed alla social neuroscience – i meccanismi del nostro essere basilarmente relazionali, dal ben noto fenomeno del mirroring alle teorie sulla sincronizzazione proposte dalle neuroscienze dell’affiliazione di Ruth Feldman. Ma penso anche alle conquiste della biologia della mente, tra cui certamente sta assumendo un ruolo importante l’epigenetica (i lavori sulla trasmissione intergenerazionale del trauma, come quelli di Galit Atlas, e più in generale tutta la letteratura sul trauma, a partire dalle suggestioni del lavoro di Bessel Van der Kolk). Ma anche le conoscenze in ambito di microbioma stanno aprendo importanti prospettive nel campo della fisiopatologia e della possibile terapia di alcune forme di depressione. Penso, infine, anche alla recente frontiera degli studi sulla possibile integrazione nel lavoro psicoterapico delle sostanze psichedeliche.
Poi c’è tutto il dominio della rivoluzione informatica, che spesso pare lontana o astrusa, ma tale, a mio parere, non è. Penso, per esempio, al tema della psicoterapia online che non nasce con le emergenze della recente pandemia (i primi studi negli Stati Uniti erano degli anni ’50 del secolo scorso; in Italia Paolo Migone, Roberto Goisis ed io stesso ne scrivemmo già alla fine degli anni ‘90), anche se essa è rimasta per decenni nell’ambito del non-detto e del non-scritto (la terribile paura dell’anatema del questa non è psicoanalisi!) e in tale ambito, temo, sembra ora destinata a rientrare, scampato il pericolo. Eppure da tempo autori come Todd Essig avevano cercato di introdurre nel mondo psicoanalitico i temi della rivoluzione informatica e delle possibilità aperte dallo sviluppo delle telecomunicazioni (fui attivo fruitore della sua The Psychoanalytic Connection che restò attiva e fiorente dal 1993 al 2009). Ora The American Psychoanalyst (TAP), magazine dell’American Psychoanalytic Association (APsA), ci sprona ad essere parte attiva (engaged participation, Psychoanalytic AI Activism) di un’adozione critica degli strumenti dell’intelligenza artificiale per evitare alcune disastrose ricadute della sua applicazione sulla nostra cultura. Tra di esse ricorderei: il progressivo sostituirsi del texting all’incontro diretto o allo scambio vocale, il nostro progredire da sonnambuli verso la dimensione dell’intimità artificiale in un mondo in cui la finta empatia (pretend empathy nella fortunata espressione coniata da Sherry Turkle) e la perdita di fiducia e privatezza stanno re-ingegnerizzando le relazioni interpersonali e l’esperienza del sé. La psicoanalisi deve dunque impegnarsi (Essig dirige il Council on Artificial Intelligence, che opera all’interno dell’APsA) per riaffermare i suoi valori e i suoi principi nel lavoro clinico costruendo nuovi strumenti teorici per leggere e comprendere la multiforme realtà delle possibili relazioni interpersonali che viviamo oggi (da persona a persona; tramite uno schermo con un’altra persona; con l’intelligenza artificiale di un chatbot o di un robot: che siamo portati ad antropomorfizzare tutte, come ben sappiamo fin dai tempi di Eliza) e per contrapporci, quanto meno, alla migrazione della psicoterapia verso il mondo delle app (sedicenti psicoterapeuti, coaches come Wysa e consulenti, semplici compagni virtuali come Replika) gestite da algoritmi opachi e non controllabili (che, peraltro, sembrano funzionare…, guarda per esempio, tra le più recenti, l’RCT (Randomized Controlled Trial, uno studio scientifico che valuta l’efficacia di un trattamento confrontandolo con un placebo o un altro trattamento standard) su Therabot [Heinz et al., 2025] per i disturbi d’ansia e la depressione).
Tra parentesi, queste risposte le ho scritte personalmente: ho provato a consultare Perplexity e Copilot, ma non ne ho ricavato suggerimenti apprezzabili – il che vuol dire, probabilmente, che devo imparare ad usare meglio questi strumenti!
Ecco, questo mi sembra oggi il punto nodale, quello dell’inserimento di questi contenuti nei nostri itinerari formativi, dalle aule universitarie ai percorsi nell’ambito della SPI: siamo sempre molto concentrati sulla dimensione storica del sapere, le nostre origini (importanti, certamente), ma poco su quella pragmatica rivolta al futuro. Abbiamo tutti una spolveratina di neuroni specchio o di trattamenti psicoterapeutici a distanza, o di prompting degli LLMs (Large Language Models), e talvolta ne scriviamo; ma poi in pratica, mi sembra, ne facciamo scarsa integrazione o dialettica con i nostri tradizionali costrutti mentali, che ne dovrebbero almeno in parte essere rimessi in questione.
(F) Scendendo nel campo delle ricerche sui mirror neurons, sappiamo bene quanto Vittorio Gallese sia, da anni, un’importante ed autorevole presenza presso vari convegni e seminari della SPI, al punto tale da essere insignito del Premio Musatti. Pur riconoscendo questo grande spazio dato agli aggiornamenti neuroscientifici, tu ritieni che la tematica dei mirror neurons e delle sue ricadute sui correlati neurali dei funzionamenti inconsci, sulla spiegazione di fenomeni di rispecchiamento emotivo, sul ruolo centrale della motricità e del corpo nelle regolazioni intersoggettive, ed altro ancora, siano stati argomenti pienamente accolti ed elaborati dagli psicoanalisti italiani, al punto tale da aver sollecitato ripensamenti paradigmatici in alcune teorizzazioni psicoanalitiche?
(M) Il premio Musatti ha riconosciuto, a mio avviso, il lavoro prezioso che Vittorio ha svolto e continua a svolgere nel tentativo di offrire alla comunità psicoanalitica le importanti suggestioni aperte sia dalla ricerca neuroscientifica in generale, sia dal suo personale contributo a partire dal fenomeno del mirroring; sforzo che ha finito con il trasformarlo, nel nostro mondo della psicoanalisi italiana, nel rappresentante, in verità ascoltato solo superficialmente, del mondo delle neuroscienze (un torto sia per Vittorio che per le neuroscienze).
Già nel 2006, nel suo articolo La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi, scritto con Morris Eagle e Paolo Migone e pubblicato in italiano su Psicoterapia e Scienze Umane, Gallese aveva avanzato l’idea che la scoperta dei neuroni-specchio avrebbe potuto essere rilevante per la comprensione teorica di fenomeni come la proiezione, l’identificazione proiettiva e la dinamica transfert-controtransfert. Se ne parlò per un po’ (più all’estero che da noi), se ne trasse motivo per rispolverare la questione dell’uso del lettino, ma poi, a mio avviso, la cosa ebbe a svanire; non mi sembra si sia mai realmente utilizzato a fondo lo spunto del mirroring per rielaborare le nostre teorie.
Qualche anno dopo (2013), in un libro scritto in collaborazione con Massimo Ammanniti, Gallese ha ulteriormente tentato di coinvolgere e sollecitare il mondo psicoanalitico, e in particolare le sue correnti relazionali, delineando un’articolata teoria dell’intersoggettività basata sull’intercorporeità; ma anche in questo caso, mi verrebbe da dire, con un seguito non proporzionato alla rilevanza delle suggestioni proposte.
Di recente ho trovato interessante anche Cosa significa essere umani? scritto da Gallese con Ugo Morelli, che però è stato verosimilmente considerato come un testo essenzialmente divulgativo e quindi poco apprezzato nel nostro mondo specialistico; ora Vittorio parla di un suo prossimo lavoro sul narcisismo, che sarà pubblicato sull’International Journal of Psychoanalysis, e forse l’autorevolezza della testata lo renderà a noi più visibile…
Per rispondere alla tua domanda, quindi, no: non credo che il lavoro di Vittorio sia stato realmente accolto e fruttuosamente elaborato nel nostro mondo: e credo proprio sia un peccato.
(F) Un dialogo con gli apporti ed i principali quadri teorici delle neuroscienze, non si può certamente limitare ad aggiornamenti su dati di ricerca, ma, credo, debba anche coinvolgere un dialogo sulle diverse metodologie conoscitive. Indubbiamente il campo delle neuroscienze, tra tante altre sue peculiarità, è un campo scientifico basato sulle evidenze sperimentali, differentemente dall’epistemologia congetturale delle teorie basilari della psicoanalisi freudiana, una per tutta la congettura energetica. Ecco, come pensi possa articolarsi questo difficile ma stimolante dialogo tra due campi di sapere così metodologicamente differenti?
(M) Non credo di avere una risposta definitiva e soddisfacente a questa tua domanda, è un argomento che temo di aver approfondito troppo poco. Ma devo dire che un po’ mi lascia perplesso il tuo riferimento al fatto che la psicoanalisi si fondi sul congetturale; può essere io non abbia ben capito quello che tu intendi, ma a me pare che esista anche una modalità di essere del modello psicoanalitico che può sottoporsi a verifica, che è il tema della ricerca in psicoanalisi. Sarà forse per l’impronta medicale della mia formazione personale, ma, come frequentemente asserito in letteratura, non penso che possiamo tranquillamente dispensarci dal conforto della ricerca sull’efficacia del nostro lavoro nel momento che chiamiamo pazienti i nostri utenti. Non mi riferisco tanto al lavoro sulle forme di psicoanalisi applicata che sono state manualizzate (con risultati molto discussi), ma invece agli studi che sono stati condotti cercando di seguire longitudinalmente il percorso psicoanalitico (penso al lavoro di Horst Kächele e alla scuola di Marianne Leuzinger-Bohleber, per esempio, o ai tanti autori che hanno cercato di documentare l’evoluzione dell’alleanza di lavoro durante il percorso psicoanalitico o psicoterapico).
Tenendo ben fermo il principio dell’indipendenza dei registri semantici della psicoanalisi e delle neuroscienze, come ci ammoniva Mancia, non dovrebbe essere impossibile, a mio avviso, trovare dei punti di contatto seguendo il filo dell’epistemologia della consilience, proposta nel 1998 da Edward O. Wilson.
(F) Si è sentito obiettare che anche un dialogo più assiduo e profondo tra psicoanalisi e neuroscienze, riguarderebbe il confronto tra teorie e metodi conoscitivi, mentre non potrebbe incidere sulla pratica psicoanalitica della cura. Un dialogo con le neuroscienze può avere ricadute anche sul piano delle concezioni psicopatologiche e della metodologia clinica? Vorrei sapere qual è il tuo pensiero in proposito?
(M) Si tratta di un’affermazione che è stata ripetuta molte volte, a partire dalla formulazione, molto azzeccata dal punto di vista comunicativo, di Sidney Pulver (On the Astonishing Clinical Irrelevance of Neuroscience, 2003), ma che ritengo sostanzialmente erronea: presuppone infatti che esista una tecnica svincolata o indipendente dalla teoria, il che mi pare non aver senso. Basterebbe per esempio dare uno sguardo al modello avanzato da Mark Solms, a partire dal lavoro The scientific standing of psychoanalysis (2018), una riproposizione della teoria psicoanalitica della mente che aggiorna l’originale formulazione di Freud con le teorie sull’energia libera di Karl Friston, con il costrutto della riconsolidazione di Cristina Alberini e con la proposta dei sistemi emozionali e motivazionali di Jaak Panksepp. Questa riformulazione teorica conduce, con stretta consequenzialità, ad una teoria della tecnica su come si svolge il processo psicoanalitico e su come porlo in atto. Teoria e tecnica sono anche strettamente correlate nel lavoro sulla neurobiologia interpersonale di Allan N. Schore o in quello a partire dalle teorie dell’attaccamento di Jeremy Holmes; e potrei aggiungere altri nomi…
Naturalmente le neuroscienze non ci diranno mai cosa dire al nostro paziente (non mi pare abbiano senso le cosiddette interpretazioni neurobiologiche), ma non è questo, a mio avviso, ciò che dovremmo richiedere al dialogo con le neuroscienze: avere in mente il cervello, secondo la bella espressione ripresa da Maria Ponsi, significa operare con un nostro mondo interno arricchito e contaminato dalle acquisizioni neuroscientifiche. Ti direi che credo sia questo quello che mi è accaduto in questi ormai trent’anni di letture neuroscientifiche; insieme con un accresciuto sentimento di umiltà nei confronti del nostro potere di intervento sulla patologia dei nostri pazienti (lo zoccolo duro di cui parlava Freud).
(F) La psicoanalisi freudiana si è sempre accreditata di una visione monista nel sostenere che i funzionamenti psichici, anche inconsci, siano sottesi da funzionamenti neuronali. La questione è, in vero, più frastagliata, perché vi sono molti ondeggiamenti nelle posizioni freudiane per riconoscibili impregnazioni cartesiane. Tu credi che un confronto della psicoanalisi con le neuroscienze e con le scienze della mente possa aiutare ad un maggiore approfondimento della questione corpo/mente?
(M) Non penso possano esserci ancora dubbi circa la necessità di adottare una posizione monistica nell’ambito del nostro lavoro; penso in particolare al dual aspect monism di cui parla Mark Solms.
La questione corpo/mente è invece ancora aperta e ben lungi da una soluzione: nonostante sia ormai da anni la frontiera della ricerca neuroscientifica, ancora non sappiamo come interpretare o spiegare la dimensione fondamentale della coscienza, della soggettività. A partire dalla classica formulazione iniziale di David Chalmers, quasi tutti i grandi ricercatori si sono via via cimentati con questo tema – Baars, Tononi, Koch, Dehaene, Damasio, Solms, per citarne solo alcuni – senza al momento pervenire a proposte realmente convincenti ed utilizzabili in particolare sul piano clinico. Neanche il pluriennale sforzo del Cogitate Consortium con il suo recentemente pubblicato (2025) Adversarial Testing delle due più importanti teorie attualmente esistenti (la Integrated Information Theory e la Global Neuronal Workspace Theory) sembra essere arrivato a conclusioni realmente dirimenti sul come l’esperienza soggettiva si costituisca a partire dall’attività cerebrale e dalla nostra realtà somatica. Questo costituisce un’aporia gravissima nelle nostre concezioni (ancor più nel momento attuale, in cui si sta affacciando la questione di una possibile acquisizione di funzioni di coscienza nei sistemi di intelligenza artificiale!).
Questo è al momento, a mio avviso, il problema più grave per il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi (forse alludevi a questo nella tua precedente domanda sulle differenti metodologie conoscitive tra neuroscienze e psicoanalisi). Mi duole ammetterlo – ma onestà intellettuale me lo impone – mi pare resti ancora valida la posizione assunta da Rachel B. Blass e Zvi Carmeli (2007) per la quale, in difetto di una valida teoria della soggettività, il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi si arresta sulla soglia di uno iato incolmabile tra la prospettiva in terza persona delle neuroscienze e quella in prima persona della psicoanalisi. Ci metto una nota di ottimismo, ricordando quando Kandel scriveva che la strada del dialogo è quella giusta ma che siamo solo all’inizio del percorso (peccato essere ormai così anziano…!).
(F) Una feconda triangolazione, ed integrazione, potrebbe essere quella tra neuroscienze, infant research e psicoanalisi. Ormai la microanalitica delle relazioni precoci tra neonati e caregivers si è oltremodo arricchita di metodologie e dati che provengono dalla biochimica, dalla neurobiologia, dalla ricerca evolutiva, dalla psicologia sperimentale. Ad esempio, il recente libro di Sara Blaffer Hrdy, Il tempo dei padri (2024), riporta dati su come le strutture familiari ed i contesti sociali di cure modellino le cure paterne, attraverso una riduzione dei livelli testosteronici maschili – minore innesco di attività aggressivo-difensive e maggiore apertura empatica – ed un graduale aumento dell’ossitocina, non appena essi si impegnano più intensamente nella cura dei figli. Trovo questi dati di straordinario interesse, non solo per la dimostrazione dell’importanza dell’ambiente nella ‘costruzione’ del bambino e dei suoi genitori responsivi, ma per l’arricchimento delle competenze psicoanalitiche sull’infanzia. e per una revisione, ormai necessaria, delle cosiddette pulsioni aggressive. Che ne pensi di questo promettente ‘incontro a tre’?
(M) Intanto ti ringrazio per avermi ricordato il libro della Hrdy (un moto di sana invidia, è nata come me nel 1946, ma è in grado di pubblicare un libro così ricco e combattivo!), il libro giaceva da un po’ nella lista d’attesa delle letture, sempre troppo più lunga rispetto alla mia reale disponibilità di tempo. Ne ho scorso alcuni capitoli, spinto dalla tua menzione, abbastanza da capire perché il libro sia stato accolto anche con molte critiche (da destra e da sinistra, come si direbbe oggi) nel clima culturale dell’America ormai trumpiana. Mi hanno colpito in particolare (oltre ovviamente alla tesi centrale sulla rilevanza dei padri nella crescita ed accudimento dei bambini) il tributo dedicato al lavoro di Ruth Feldman, che ho già ricordato in precedenza, e la ripresa in generale degli studi centrati sul ruolo dell’ossitocina – la grande, indecifrabile protagonista della neuroendocrinologia moderna – e la dimensione evoluzionistica, che ormai caratterizza molti approcci nel mondo delle neuroscienze (penso a LeDoux o a Damasio, per esempio). En passant, sarebbe importante che la psicoanalisi si lasciasse contaminare anche dai temi e dalle prospettive dell’antropologia: quanti di noi, per esempio, hanno conosciuto ed elaborato gli studi sull’amore di Helen Fischer?
Sono quindi assolutamente d’accordo con te sulla rilevanza di questo incontro a tre, come tu dici, e d’altra parte sono molti anni che tutto questo sta piano piano permeando la nostra riflessione e comprensione dello strutturarsi dell’attività mentale: dalle confutate tesi della Mahler, alle prospettive aperte dal lavoro di Stern. Si tratta, a mio avviso, dell’evoluzione importante delle intuizioni di Bowlby e dell’approfondimento continuo della tematica dell’attaccamento, oggi centrato in particolare sulle sue componenti neuroscientifiche e ormonali, come appunto il lavoro della Feldman e della Hrdy dimostrano. Jeremy Holmes ha scritto che l’attaccamento è la base psicologica di ogni forma di psicoterapia e che la psicoterapia è una relazione di attaccamento: ecco, mi pare che questa cornice concettuale offra una corretta prospettiva al campo della ricerca psicoanalitica e sia il migliore esempio che possiamo citare della vitalità della nostra disciplina quando si apre al dialogo con quelle contermini, obiettivo che anche tu, in questi anni, hai molto lavorato a realizzare…
Bene, adesso l’intervista si è conclusa. Grazie a SPIWEB e ad Amedeo Falci per avermi proposto questa intervista, e per le domande che mi sono pervenute (giustamente!) non concordate né addomesticabili, e per la consulenza editoriale sul mio elaborato prima della sua pubblicazione.
Grazie al lettore che con numerosi scroll ha avuto la pazienza di arrivare alla fine di questa lunga pagina; spero di essere riuscito a trasmettergli almeno un poco della mia passione per l’apertura della psicoanalisi al dialogo.
Il mio sito è a www.sicap.it/merciai e l’indirizzo email è silvio.merciai@gmail.com.
Mi piacerebbe il dialogo continuasse e fosse questo solo un arrivederci…
Bibliografia
Ammanniti M., Gallese V. (2013). The Birth of Intersubjectivity: Psychodynamics, Neurobiology, and the Self. Norton Professional Books. It.: La nascita dell’intersoggettività. Lo sviluppo del sé tra psicodinamica e neurobiologia. Cortina, Milano, 2014.
Bion W. R. (1998). Addomesticare i pensieri selvatici. FrancoAngeli, Milano, 2012.
Blass R. B., Carmeli Z. (2007). The case against neuropsychoanalysis: On fallacies underlying psychoanalysis’ latest scientific trend and its negative impact on psychoanalytic discourse. Int J Psychoanal, 88/1, 19-40.
Cannella B., Merciai S.A. (2009). La psicoanalisi nelle terre di confine. Tra psiche e cervello. Cortina, Milano.
Chalmers D. (1996). La mente cosciente. Mc-Graw Hill, Milano, 1999.
Cieri F. (a cura di) (2024). Neuroscienze psicodinamiche. Verso il superamento di una mindless neuroscience e di una brainless psychoanalysis. FrancoAngeli, Milano.
Cogitate Consortium et al. (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. Nature, 642, 133-142.
Damasio A. (2000). The Feeling of What Happens. Vintage. It.: Emozione e coscienza. Adelphi, Milano, 2000.
Freud S. (1914). Per la storia del movimento psicoanalitico. OSF, VII.
Gallese V., Migone P., Eagle M.N. (2013). La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi. Psicoterapia e Scienze Umane, 2006/3, 543-580.
Gallese V., Morelli U. (2024). Cosa significa essere umani? Cortina, Milano.
Hrdy S.B. (2024). Il tempo dei padri. Bollati Boringheri, Torino, 2025.
Heinz M. V. et al. (2025). Randomized Trial of a Generative AI Chatbot for Mental Health Treatment. NEJM AI. 2/4, doi: 10.1056/AIoa2400802.
Holmes J. (2020). The Brain has a Mind of its Own. Attachment, Neurobiology and the New Science of Psychotherapy. Confer Books.
Kandel E. M. (1999). Biology and the Future of Psychoanalysis: A New Intellectual Framework for Psychiatry Revisited. Am J Psychiatry, 156/4, 505-524.
Mancia M. (Ed.) (2006). Psychoanalysis and Neuroscience. Springer, Berlin.
Pulver S. E. (2003). On the Astonishing Clinical Irrelevance of Neuroscience. JAPA, 51/3, 775-772.
Shore A.N. (2003). La regolazione degli affetti e la riparazione del sé. Astrolabio, Roma, 2008.
Solms M. (2018). The Scientific Standing of Psychoanalysis. B J Psych International, 15/1, 5-8.
Turkle S. (2022). The Empathy Diaries. Penguin Books.
Weizenbaum J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine. Communications of the ACM, 9/1, 36-45.
Wilson E. O. (1998). Consilience: The Unity of Knowledge. Knopf, New York.
Vedi anche: