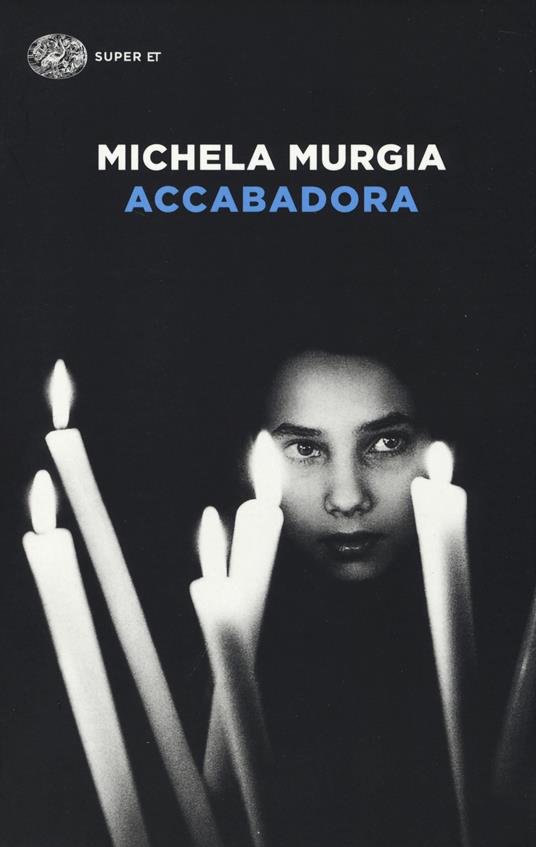
Accabadora
di Michela Murgia (Einaudi, 2009)
Recensione di Daniela Federici
Parole chiave: #eutanasia, #figli d’anima, #etica, #riconoscimento
Noi non abbiamo mai,
nemmeno per un giorno,
lo spazio puro innanzi a noi,
in cui si aprono i fiori senza fine.
È sempre mondo e mai un nessun luogo senza no:
il puro, insorvegliato, che si respira
e si sa all’infinito, e non si desidera.
Rilke, Elegie duinesi
Fillus de anima. È così che li chiamano i bambini generati due volte, dalla povertà di una donna e dalla sterilità di un’altra.
Maria è l’ultima nata, la quarta, l’errore dopo tre cose giuste, l’ultimo pensiero di una famiglia che ne aveva già troppi. Ha 6 anni quando Tzia Bonaria Urrai va a parlare alla madre perché gliel’affidi per farne il frutto tardivo della sua anima, per offrirle un riscatto, insegnarle un mestiere, garantirle lo studio. Una chiacchiera gustosa per le fameliche malelingue del paese, quella figlità elettiva in età avanzata.
Maria intuiva che da qualche parte avrebbe dovuto esserci un motivo per piangere ma non riuscì a farselo venire in mente. Si perse anche i ricordi della faccia di sua madre mentre lei si allontanava, quasi se la fosse scordata già da tempo.
Bonaria Urrai l’aveva guardata bene quella bambina dimenticata, quando in una bottega si era infilata un pugno di ciliegie nella taschina del vestito, senza vergogna né consapevolezza, come se l’assenza di giudizio fosse il giusto contrappasso della sua dichiarata invisibilità. E poi, incantata dai riflessi della pelliccia della moglie del farmacista, vi aveva affondato il viso per sentirne l’odore. La madre, imbarazzata a spiegare quel suo fare selvatico, quell’ansia di sensi che diventava furto molto più spesso di quanto la fame potesse giustificare, aveva soffiato fuori un: Non l’avessi avuta mai. Quell’aborto retroattivo non aveva suscitato reazioni nella bambina, immobile con l’incoscienza indolore di chi non è mai nato veramente, e quando le era arrivato lo schiaffo, gli occhi si erano chiusi solo l’attimo del colpo, poi lo sguardo era rimasto fermo, la mano ficcata nella tasca a esasperare la macchia rossa sul vestito.
Sembra di vederla quella scena, di sentire quelle urgenze e quell’opposizione, le loro radici profonde.
Ferenczi scrisse dei bambini male accolti che percepiscono i segni consci e inconsci del loro non essere voluti, l’intensità del conflitto fra un forte senso di indegnità e una ferma volontà di riconoscimento, fra nostalgie di tenerezza e la sfiducia, la diffidenza, il pessimismo morale.
I peccati senza complici dei bambini soli, scrive l’Autrice, perché le colpe, come le persone, iniziano a esistere se qualcuno se ne accorge.
Perché l’essere e il senso si danno solo nel riflettersi.
Bonaria Urrairiteneva di sapere bene a che famiglia la toglieva e che non avrebbe trovato resistenze. Con Maria non fece mai l’errore di invitarla a sentirsi a casa propria … si limitò ad aspettare che gli spazi rimasti vuoti per anni prendessero gradualmente la forma della bambina, lasciandola diventare quel che prometteva di potere essere. E quando si trattò di punirla lo fece spiegandole il grave del mentire e quella piccola creatura, che era cresciuta pensando di poter avere solo per rapina, imparò quel che era suo e che non le si sarebbe sottratto.
Questo romanzo ha in filigrana una ricerca e una tessitura etica profondamente lavorata. Nello scambio fra le sorelle e tra i paesani, la Murgia evidenza molto bene come i vissuti di un ‘dovuto’ non ricevuto, o di parti alienate di sé che si sentono impedite a crescere e a realizzarsi, alimentino una persecutorietà e un bisogno di riconoscimento che, quando venga a mancare, può accendere ostilità e bisogni risarcitori o di rivalsa, e come questa dialettica possa facilmente esacerbare le contrapposizioni fra chi si sente emarginato e chi esaspera le esclusioni.
Nel ritorno a casa per i preparativi di nozze della sorella, Maria si porta fiera della sua intelligenza, una qualità che le sorelle disprezzano per non sentirsene sminuite. A un tratto pare stia di nuovo tutto dalla loro parte ciò che vale: essere spose, oggetto di sguardi ammirati e cure festose, come quando era piccola e pativa l’insignificanza a fianco delle figlie desiderate. Nell’insicurezza di un proprio posto nel mondo, fra il sentirsi un povero tentativo di donna e il desiderio di essere la più bella, prova a impossessarsi di ciò che non confida di poter diventare in prima persona, e ne sfocia il danno insieme alla vergogna di chi si riesce a vedere solo mancante.
Ma è ancora una pallida eco della potenza distruttiva di ciò che manca una possibilità trasformativa.
In quella terra aspra, dove ogni alba nuova è un agguato da cui difendersi come si può, gli appezzamenti piccoli e irregolari raccontavano di famiglie con troppi figli e nessuna intesa, frantumate in una miriade di confini fatti a muretto a secco in basalto nero, ciascuno con il suo astio a tenerlo su. È proprio per una questione di confini e di un tentativo di rivalsa che un giovane paesano finisce con una gamba amputata, precipitando nell’irreparabile.
Queste impasse relazionali sottendono una simmetria inconscia, perché l’impossibilità a riconoscere la realtà dell’altro senza rinunciare alla propria, rende inevitabile che l’unico modo per far valere l’una implichi il prevalere sull’altra. Per uscire da questa logica mors tua-vita mea occorrerebbe guadagnare una posizione di terzietà che richiede un riconoscimento reciproco, fra soggetti consapevoli della partecipazione di ognuno e dell’impatto reciproco delle proprie azioni. Ma la capacità di distinguere senza scindere richiede una lenta elaborazione fuori dalle difese scissionali, che arrivi a poter contenere il conflitto, a riconoscere la discrepanza fra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, a sanare il sanabile dei fallimenti empatici e delle violazioni all’ordine naturale delle cose, ripristinando il senso di un mondo giusto.
La ferita di Nicola Bastiù precipita gli eventi. In tutti gli anni in cui era rimasta con lei, la piccola Maria non si era avveduta che Tzia Bonaria era l’accabadora, colei che finisce, che in situazioni di malattia senza speranza portava una morte pietosa a chi lo chiedeva, a chi aveva negli occhi l’immobilità senza ritorno delle cose rotte. Aveva creduto che quella seconda madre fosse solo una sarta, che in ginocchio con il metro di pelle si muoveva rapida come un ragno femmina, tessendo intorno a quelle prede immobili una misteriosa ragnatela di misure, senza voler comprendere meglio lo strano sguardo dei paesani, certe allusioni o le misteriose uscite serali all’indomani delle quali si andava alle case di chi era mancato nella notte. Si sentiva già da lontano il canto cupo dell’attittadora: ogni volta che si levava quel lamento dalla musicalità sguaiata, era come se ai sorenesi venissero cantati i dolori di ogni casa, quelli presenti e quelli andati, perché il lutto di una famiglia risvegliava la memoria mai sopita di tutti i singoli pianti passati. Allora le ante delle finestre del vicinato venivano accostate, rendendo ciechi al sole gli occhi delle case, e ciascuno accorreva a piangere i propri morti nel morto presente, per interposta assenza.
Quando Nicola Bastiù, giovane irruento che non accetta la sua menomazione, esprime la sua volontà di farla finita, si scontra con la vecchia accabadora: Credi davvero che il mio compito sia ammazzare chi non ha il coraggio di affrontare le difficoltà?
Bonaria è un femminile che affonda nel sempre della storia quella capacità-necessità di prendersi cura e farsi carico, una donna che padroneggia i riti e sa leggere sotto la cenere le braci sorde e tenaci dell’odio, che ha fatto i conti con le sofferenze e il conflitto, che conosce i labirinti carsici della colpa e della responsabilità, che ne porta le cicatrici. La lunga lotta silenziosa con la fermezza di Nicola, è un ricamo narrativo di tensione riflessiva. Il peso di un respiro tolto è come un manto bagnato, che la riporta alla sé ragazzina che aveva appreso la legge non scritta per cui sono maledette solo la morte e la nascita consumate in solitudine, e non aveva nessuna importanza che il suo compito fosse stato solo quello di guardare. A quindici anni Bonaria era già in grado di capire che certe cose, farle o vederle fare è la stessa colpa, e mai da allora le era venuto il dubbio di non essere capace di distinguere tra la pietà e il delitto. Mai prima di quella sera, quando negli occhi di Nicola Bastiù aveva letto la determinazione di chi cerca disperatamente non la pace, ma un complice.
Quando Nicola muore, il fratello riferisce a Maria quel che non ha voluto riconoscere e che ancora stenta a credere possibile in un confronto con Bonaria che ha il suono di qualcosa che va in frantumi.
– Non metterti a dare nomi a cose che non conosci. Farai tante scelte nella vita che non ti piacerà fare, e le farai anche tu perché vanno fatte, come tutti. … Vuoi giudicare del come senza capire il perché? Tu hai sempre fretta di emettere sentenze, Maria. … Sei nata tu forse da sola, Maria? Sei uscita con le tue forze dal ventre di tua madre? O non sei nata con l’aiuto di qualcuno come tutti i vivi?… Altri hanno deciso per te allora, e altri decideranno quando servirà di farlo. Non c’è nessun vivo che arrivi al suo giorno senza aver avuto padri e madri a ogni angolo di strada, Maria, e tu dovresti saperlo meglio di tutti.
Perché arrivati a un certo punto non c’è più la possibilità di trovare una via più lieve di arrivare fino in fondo. L’anziana parlava con la sincerità con cui si fanno la confidenze agli sconosciuti sul treno, sapendo che non si dovrà sopportare mai più il peso dei loro occhi.
– Non mi si è mai aperto il ventre, e Dio sa se lo avrei voluto, ma ho imparato da sola che ai figli bisogna dare lo schiaffo e la carezza, e il seno, e il vino della festa, e tutto quello che serve, quando gli serve. Anche io avevo la mia parte da fare, e l’ho fatta.
– E quale parte era?
– L’ultima. Io sono stata l’ultima madre che alcuni hanno visto.
Maria rimase in silenzio per qualche minuto, mentre la rabbia moriva nel senso per lei inaccettabile di quelle parole. Quando parlò, Bonaria seppe che non c’erano più spazi per capire.
– Per me siete stata la prima, e se mi chiedeste di morire, io non sarei capace di uccidervi solo perché è quello che volete.
Bonaria la fissò, e Maria vide che la vecchia era stanca.
– Non dire mai: di quest’acqua io non ne bevo. Potresti trovarti nella tinozza senza manco sapere come ci sei entrata. – Bonaria raccolse lo scialle che aveva lasciato cadere sulla sedia e cominciò a piegarlo con gesti lenti, consapevole che quella era l’unica cosa che poteva mettere in ordine. – Quando verrà il momento, Maria, scoprirai cose di te che non conosci ancora..
– Non verrà quel momento… – Maria non si rese conto di averlo deciso se non nell’istante in cui le sfuggiva dalle labbra. – … io voglio andare via da voi.
Se ne va, Maria, cercando invano di dominare il vuoto del tradimento subito, che le sembrava sì affine alla morte, ma senza la consolazione di poter vegliare una spoglia cara, e nessuna sepoltura per dare confini di terra al pianto che la soffocava.
Il tempo lontano dalla sua terra è un sospeso, in cui sembra cambiare perfino lo stile della scrittura, un ambiente in cui la protagonista incontra, da adulta e responsabile di altri piccoli, le spinte della sua parte selvatica, l’indulgere morbido della tentazione, la scelta che non è più protervia di una superiorità morale ma più chiara consapevolezza di ciò che la riguarda da vicino, degli errori di cui potersi riconoscere responsabile. Un’etica ‘depressivamente’ più integrata.
Quando viene chiamata perché Bonaria sta molto male, è una donna quella che ritorna a occuparsi dell’anziana madre d’anima, che accudisce per mesi sull’orlo della morte, rabbie premurose intorno al suo corpo, sentimenti e conflitti di cui a quel punto può farsi carico con tutto quel che di sé può scoprire e avere da offrire.
Accabadora è una gemma di scrittura, un romanzo di formazione amaro e intenso come la terra aspra che racconta con uno sguardo sapiente, che prende in mano la vita e la morte, le radici e la sete degli orizzonti con solida delicatezza, che sono valse alla Murgia il Dessì, il Campiello e il Supermondello.
L’eutanasia in questi anni ha fatto molta strada nella pensabilità collettiva, accrescendo la consapevolezza di ciò che di imperfetto abitiamo e della difficile conciliazione fra i valori.
Avvicinarsi a ciò che non conosciamo o ci spaventa, all’altro e ancor più all’altro dentro di noi, muove sempre le angosce dell’ignoto e del contagio. La maturazione emotiva necessita di tempo, di presenza e sostegno al pensiero per non mantenersi troppo riparati dalle paure e dalla sofferenza, per riuscire a coltivare uno spazio di elaborabilità per ciò che può trasformarsi.
A questo, la letteratura capace di scavo e conscia della propria funzione educativa, porta da sempre un contributo prezioso attraverso le sue conoscenze e le potenzialità dei meccanismi identificatori.
Le polarizzazioni costano meno fatica psichica della possibilità di sostenere il conflitto, ne sappiamo qualcosa anche noi analisti, che nella nostra funzione di mediare le angosce e sostenere il divenire, ci destreggiamo fra il rispetto dell’autodeterminazione e una funzione disalienante che ci chiamano a una posizione etica tutt’altro che priva di complessità.
Benjamin, J. Il riconoscimento reciproco, Cortina 2019
Ferenczi, S. (1929) “Il bambino mal accolto e la sua pulsione di morte”, in Opere v.IV, Cortina 2002
