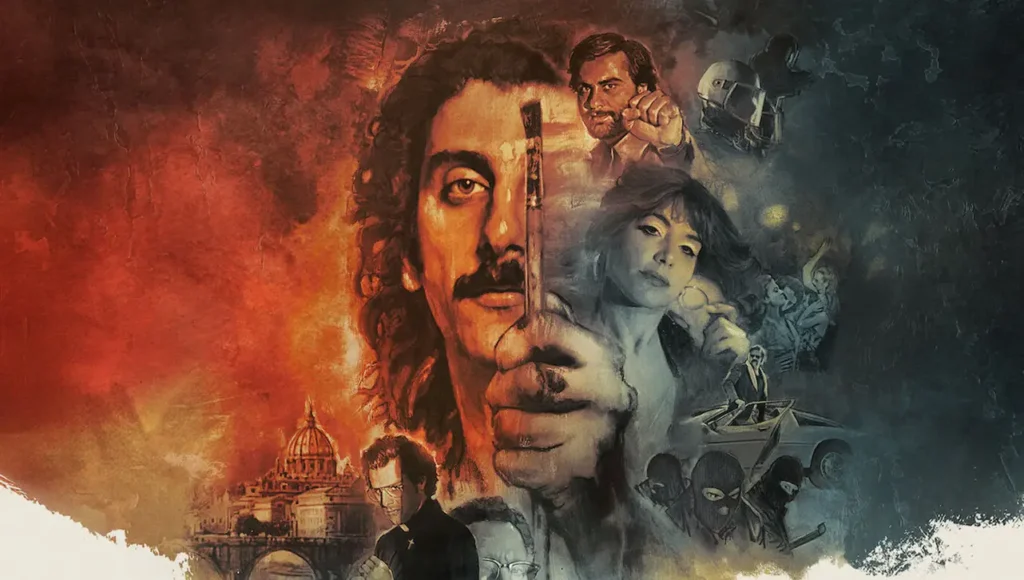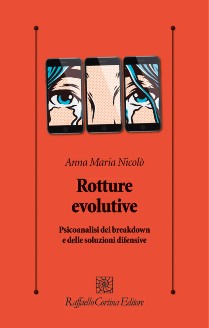Parole chiave: adolescenza, rotture evolutive, cinema e psicoanalisi
Autore: Anna Maria Olivieri
Titolo: “Enzo”
Dati sul film: regia di Robin Campillo, Francia, 2025, 103’
Genere: drammatico
Il racconto di questo film richiede una premessa importante sulla successione alla regia: Robin Campillo subentra alla direzione a seguito della morte di Laurent Cantet, che aveva pensato e scritto questo lavoro. Un passaggio di testimone, dalla morte alla vita, per realizzare un progetto, un film, che è insieme un messaggio e un dono.
Il titolo del film introduce il tema su cui si svilupperà tutta la storia: narra le vicende di Enzo, un ragazzo di 16 anni, che nell’arco di un’estate dovrà affrontare le diverse sfide dell’età: le scelte rispetto al futuro formativo/professionale, il rapporto con la famiglia e le relazioni affettive. Il protagonista appartiene a una famiglia agiata, che vive in una bella villa con piscina sulla costa nel sud della Francia. In autonomia Enzo decide di abbandonare gli studi e di lavorare come apprendista muratore, in disaccordo con i genitori (soprattutto con il padre, interpretato da Pierfrancesco Favino) e in contrasto con il fratello maggiore, che sta per concludere il liceo e che andrà a studiare a Parigi, in una prestigiosa università. Nel cantiere il protagonista si confronterà con adulti provenienti da diversi paesi, tra cui un ragazzo ucraino di 25 anni, di cui si innamorerà.
In più passaggi del film lo spettatore si trova a vivere momenti “sospesi”, oscillando tra dialoghi lenti e fermo immagine (“sei troppo lento, devi accelerare” dice il capocantiere a Enzo) e azioni rapide e gesti dirompenti. Sono questi, in filigrana, i paesaggi dentro cui si muove il ragazzo, alternando incertezze e silenzi a impulsività. Gli stessi luoghi assumono caratteristiche contrastanti a seconda della condizione emotiva attraversata da Enzo: la piscina, da spazio di isolamento e riflessione, si trasforma in luogo dell’approccio sessuale, per divenire infine ring di scontro con il fratello, così diverso, così distante; nel cantiere si mettono in scena, attraverso la creazione di un muretto (“non sembra dritto, non sai tenerlo a piombo! Non ascolti mai, non sai mettere tre mattoni insieme” urla ancora il capocantiere), le funzioni costruttive, distruttive e ricostruttive che permeano in maniera potente la mente adolescente, vicarianti di un Sé in trasformazione, che cerca di smarcarsi dalla “linearità” proposta dagli adulti.
Lo sfondo bianco dei titoli di testa e di coda, che richiamano i muri che Enzo deve saper “rasare”e i fogli da disegno su cui ama cimentarsi, possono rimandare alla possibilità, per il ragazzo, di essere artefice della propria soggettività. Il processo di “separazione-individuazione”, ci ricorda Margaret Mahler (1978), è centrale e complesso nello sviluppo del bambino; potremmo dire che nell’adolescente questi movimenti psichici si ripropongono con maggiore enfasi ed esiti incerti. Ciò può avvenire anche attraverso nuovi stili di vita, mai sperimentati prima, spesso in contrasto con quelli finora conosciuti, con un’importante quota di curiosità e attrazione: è così che, per il protagonista, i pranzi in cantiere, con i colleghi muratori, appaiono più interessanti rispetto a quelli in famiglia, come anche l’abitazione degli amici ucraini, luogo ove rifugiarsi, in raffronto alla propria casa, “utilizzata ma non vissuta”.
Enzo attraversa in pochi mesi ciò che Anna Maria Nicolò, sulla scorta della teorizzazione dei Laufer (1984) chiama “rottura evolutiva”: “possiamo ipotizzare che sul piano intrapsichico il break down esplode quando l’adolescente non è in grado di accettare il lutto del passato infantile, di integrare l’aggressività e la tempesta di nuove sensazioni generate dal corpo, soggetto e oggetto di nuove spinte sessuali e sensoriali. Queste nuove sensazioni minacciano infatti una personalità che porta con sé un’integrazione di quelle primitive esperienze del sé mai compiutamente sperimentata prima” (2021, p.57).
La corporeità, nel film, è introdotta dalle immagini delle mani di Enzo, lacerate dall’uso degli attrezzi del cantiere, senza la protezione dei guanti. È una forma di autolesionismo, di annullamento della sensibilità, ma anche di esibizionismo. Il corpo sessuato emerge gradualmente, transita dal visivo (il selfie con la ragazza in piscina, gli sguardi con il ragazzo ucraino) al contatto vero e proprio. La fisicità irrompe, il corpo viene esposto ed Enzo accetta le osservazioni dell’innamorato (“le mani sono importanti, bisogna proteggerle”) e si incuriosisce della sua vita, così lontana dalla sua, riconoscendone la vitalità: “ero in un posto dove c’era vita, gente…è stata la serata più bella della mia vita…non sei felice per me?”, confessa Enzo al padre che l’ha aspettato sul divano, tutta la notte, senza sapere dove fosse.
I genitori, attenti e preoccupati, paiono tuttavia concentrati più sulle proprie aspettative che su una vicinanza autentica al figlio e ai cambiamenti in atto. Alternano anch’essi sentimenti discrepanti, cercano il dialogo con il figlio (“cos’è che ti va?”, “di cosa hai paura?” chiedono a Enzo), di accogliere le sue intenzioni, vogliono dargli fiducia, accettano i silenzi (tra le scene più evocative vi è quella del padre che puntualmente, senza proferire parola, raccoglie da terra i panni sporchi lasciati dal figlio), si arrabbiano. Gli stessi propongono soluzioni di incoraggiamento “Tu non sei stupido”, “puoi andare in una scuola che raccoglie ragazzi dispersi”, a cui fanno seguito le risposte perentorie di Enzo “io a scuola facevo schifo”, “a me interessano lavori umili”, “io non sono come voi, questo non è il mio posto”. Il ruolo genitoriale di guida viene prepotentemente scavalcato (riferendosi a Enzo il padre afferma: “è un bambino che si sta facendo del male e noi stiamo a guardare”), anche con gesti estremi: non c’è tempo per pensare, per capire, per ascoltare, il fascio di pulsionalità prevale.
Infine un tema assolutamente attuale proposto dal film riguarda la guerra in Ucraina. Vlad, il ragazzo di cui Enzo si innamora, è costretto a fare rientro nel suo paese per andare al fronte. Enzo si fa prendere dal “diverso”, si coinvolge, si documenta, guarda video di ragazzi in guerra. E la scena finale mostra il dramma delle città ucraine distrutte dalla guerra accanto alle rovine degli scavi di Ercolano, dove Enzo si trova in vacanza con la famiglia. Oltre a un significato etico e morale, di ingiustizia verso una popolazione in costante pericolo da più di tre anni, vi è la dimensione delle rovine psichiche, che possono, come nel caso della guerra, annientare l’individuo e il suo futuro in un’incessante condizione mortifera o trasformarsi, attraverso la visita a luoghi antichi, in un’occasione di viaggio interiore, potendone apprezzare la bellezza e la profondità.
BIBLIOGRAFIA
Laufer M., Laufer M.E. (1984). Adolescenza e breakdown evolutivo, Boringhieri, Torino, 1986
Mahler M. et al., (1975). La nascita psicologica del bambino, Boringhieri, Torino, 1978
Nicolò A.M. Rotture evolutive, Raffaello Cortina, Milano, 2021