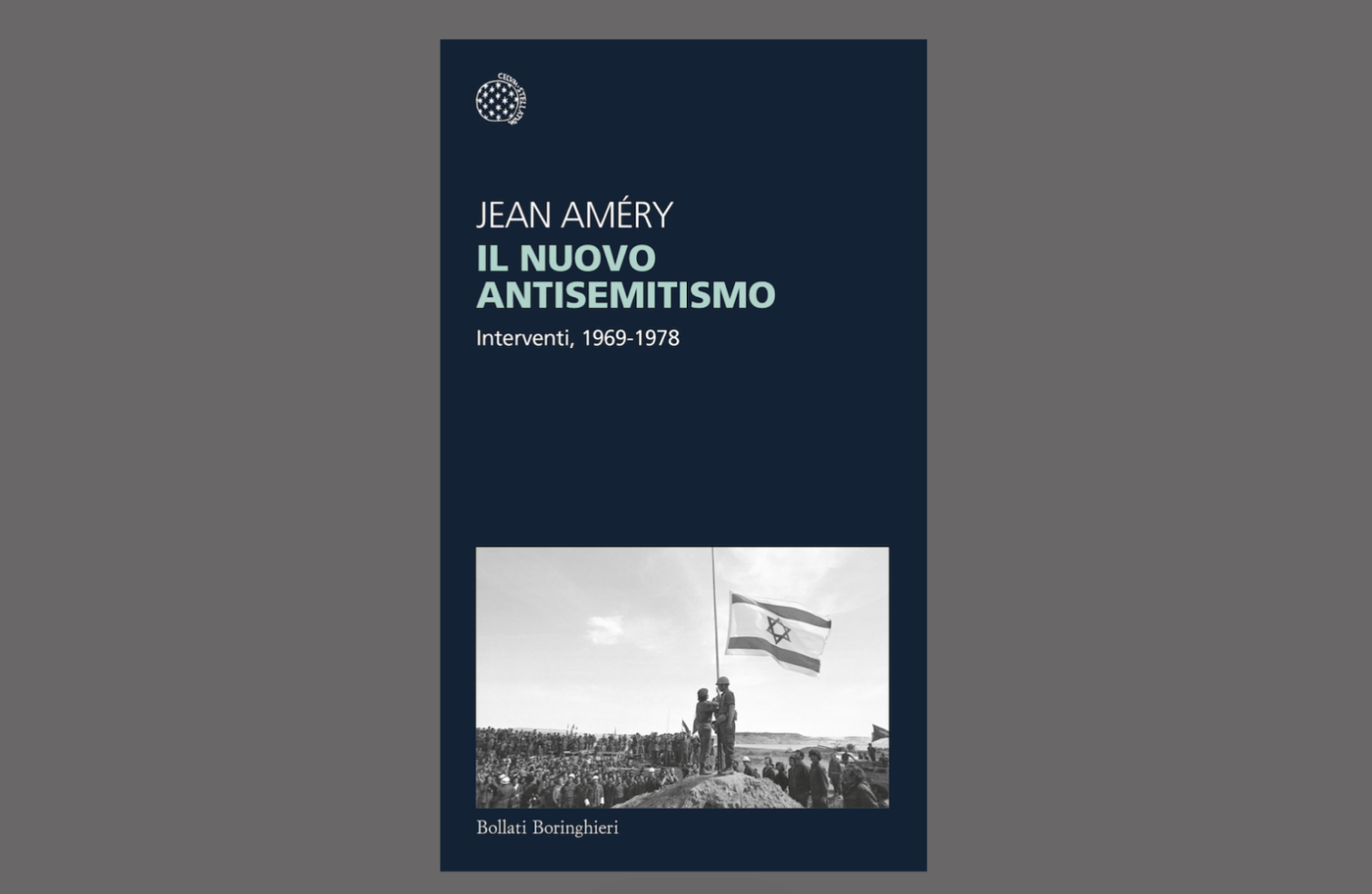Parole chiave: istituzione psicoanalitica, psicoanalisi contemporanea, disputa giornalistica
Tentativo di qualche pensiero psicoanalitico su un temporale estivo
(sulla vicenda della dott.ssa Risoldi)
Francesco Barale
“Mai toccare gli idoli, La doratura rischia di rimanere sulle dita…” (G. Flaubert, Madame Bovary)
Provo a cavare qualche abbozzo di riflessione psicoanalitica da questa piccola tromba d’aria estiva, che ha suscitato tanta animazione.
Innanzitutto, propongo di non soffermarci più di tanto sui contenuti delle accuse che Risoldi rivolge alla Psicoanalisi. Esse, infatti, purtroppo, non possono insegnarci molto. Almeno formulate in quel modo. Ben vengano le critiche, ovviamente. Ma questo j’accuse di Risoldi è così “globale”, così intenzionalmente “diffamatorio” (come è stato qualificato), rivolto a un oggetto così deformato in modo caricaturale, da rendere subito evidente come il cuore della invettiva stia altrove. Ė invece su quell’altrove e le sue dinamiche che vale semmai la pena di riflettere. Quell’altrove, forse, in qualche modo ci riguarda tutti. Riguarda le nostre identità psicoanalitiche e come si sono costruite, i modi della nostra appartenenza all’istituzione psicoanalitica, nei loro aspetti più profondi. Potremmo dire la gruppalità interna che li sostanzia. In quei modi possono annidarsi aspetti che questa vicenda dolorosa magari utilmente evidenzia.
Dirò quindi poche cose sui “contenuti” della critica di Risoldi alla psicoanalisi.
Cominciamo dall’ analista mummia impenetrabile e silenziosa, empaticamente non implicata, che ogni tanto fa filtrare alcune “interpretazioni” dall’alto e dall’esterno.
Davvero Risoldi crede che la psicoanalisi italiana sia questa? Io ho qualche dubbio…Certo, come è stato osservato, questo stereotipo è per lo meno d’altri tempi (ma il titolo di un celebre lavoro di Luciana Nissim era appunto “Ma Freud era veramente ‘freudiano’”?). Sicuramente ignora in modo deliberato l’enorme lavoro di riflessione sulla relazione analitica che la psicoanalisi italiana ha fatto nell’ ultimo mezzo secolo. Tanti gli esempi possibili. Ricordo ora, per tutti, l’impegno che appunto Luciana Nissim profuse per tutti gli anni ’80 sugli effetti deleteri di quella “monumentalità” e ieraticità, che qualcuno allora ancora sosteneva. Quell’impegno non era un impegno solitario o estemporaneo; si muoveva all’interno di un generale rinnovamento di concezione sui modi di concepire la relazione analitica e la presenza in essa dell’analista. Proprio nel novembre scorso, a Milano si è tenuto il convegno interdisciplinare “Esperienze condivise, intersoggettività e dialogo psicoanalitico nella psicoanalisi contemporanea”, per fare il punto, a 42 anni da L’esperienza condivisa, sulla eredità del crogiuolo di idee che si era espresso in quel testo, sulle sue molteplici evoluzioni, ma anche sui molti problemi aperti, sulla la ricerca attuale su quei temi…. Ma io credo peraltro che Risoldi sia al corrente di tutte queste cose e che sia in definitiva poco utile ricordargliele; questo argomento (la psicoanalisi italiana non è, nel suo complesso, quella che dipinge) avrebbe assai debole forza, come probabilmente qualunque altro, rispetto alla potente corrente affettiva che anima la sua rivolta dissacrante; mi sento autorizzato a questo termine (“dissacrante”) da Risoldi stessa, che ha definito la (sua) appartenenza psicoanalitica come quella a una setta, una religione, un partito che chiede il sacrificio di ogni spirito critico e le sue posizioni attuali come una rivolta liberatoria rispetto quei vincoli..
Voglio subito chiarire un altro punto: Risoldi non è l’ interlocutrice di questo mio scritto (che non so peraltro se mai le arriverà). Non ci conosciamo, ma, nel caso, sono volentieri disposto a conoscerla; mi interesserebbe davvero molto capire meglio il suo percorso.
Tuttavia ora la “userò” come pretesto (e di ciò mi scuso con lei) per sviluppare una riflessione di carattere generale; riflessione suscitata da quanto ha raccontato, ma che va al di là del suo caso (anzi: che non posso neppure affermare che la riguardi, poiché appunto non la conosco) e che ruota attorno al tema del dolore estremo e di come esso impatti nel sistema delle idealizzazioni, che stanno nel cuore di ogni “appartenenza”. Grumberger, che nessuno più legge, direbbe che ne costituiscono il fondamento narcisistico; sistema complesso, che variamente si intreccia con quello delle relazioni oggettuali interiorizzate e che non necessariamente funziona secondo una alternativa secca “illusione/delusione”; si spera anzi che possa funzionare diversamente, ma che talvolta, purtroppo, funziona proprio così.
Non credo neppure che qualcuno di noi in cuor suo tema davvero che il libro di Risoldi (o il battage giornalistico agostano per cercare di far di esso un “caso” ….i giornalisti fanno il loro mestiere…) metta davvero in pericolo le sorti della psicoanalisi, ne possa danneggiare l’immagine se non a livelli superficialissimi e del tutto effimeri; o che addirittura possa arrecar danno nostri pazienti. A preservar loro ci sono, peraltro, cose più di sostanza, a partire dalla qualità dell’ascolto e della presenza che sperimentano nei nostri studi.
La prendo alla larga e vi racconto, a questo proposito, un aneddoto analitico. Verso la seconda metà degli anni ’80, a seguito del “lancio” della traduzione italiana del ponderoso I fondamenti della psicoanalisi. Una critica filosofica, del filosofo della scienza Adolf Grümbaum, riesplose e per un bel po’ di tempo ebbe grande spazio, sui giornali ma anche in dibattiti pubblici, la polemica sulla “scientificità” della psicoanalisi. L’esplosione è peraltro ciclica (con o senza Corbellini….), come i ripetuti annunci (“almeno prematuri”, direbbe Mark Twain) della sua morte; ma quella bufera fu assai più potente delle piccolezze attuali, se non altro per il livello ben differente degli interlocutori (Grümbaum era un importante e riconosciuto studioso) , anche se anch’essa testimoniava, come scrisse Ricoeur proprio a proposito di quel libro, il “sostanziale, pervicace, fraintendimento”, da parte di quel tipo di epistemologia, dell’esperienza psicoanalitica. Bene: io proprio in quel periodo avevo in analisi un’ epistemologa; proprio un epistemologa vera, con fiocchi e controfiocchi, non certo un Grümbaum, ma nemmeno un Corbellini qualsiasi…. Già in precedenza e a lungo la mia epistemologa, col suo pensiero fortemente improntato in senso ossessivo, mi aveva fatto vedere i sorci verdi; ma in filigrana a quel suo spaccare il capello in quattro, a quel suo riuscire a smontare e intorcinare anche le cose più semplici, a quel suo disputare sul nomos di ogni cosa, erano a poco a poco comparsi un antico dolore, una rabbia, una difficoltà a fidarsi, a affidarsi e a orientarsi spontaneamente -preriflessivamente- nel mondo ( lei, citando Aristotele, l’ avrebbe chiamata phronésis…) che a poco a poco me l’aveva resa molto simpatica….avevamo finito persino con lo scherzarci, su quei suoi tratti… Però potete immaginare, nel mezzo della bufera, cosa successe. Ex post, dovrei comunque accendere un cero a Adolf Grümbaum, armato del quale la mia epistemologa veniva in seduta a battagliare, attraverso di me, con i suoi fantasmi….a cercare di fare meglio i conti con loro, a riaprire le sue antiche ferite…..senza Adolf (come alla fine lo chiamavamo tra noi) forse quell’analisi, che si concluse peraltro piuttosto bene, sarebbe stata meno ricca (tuttora il mio ex paziente mi manda ogni tanto gli auguri, in modo molto spiritoso: mi ringrazia per quanto abbiamo fatto, “malgrado la psicoanalisi”).
Ancora: la psicoanalisi come situazione intrinsecamente autoritaria, che alimenta sudditanze fideistiche consolidate poi dall’intero funzionamento dell’istituzione-setta….?
Hanno avuto gioco facile Stefano Bolognini, Vittorio Lingiardi e Davide D’Alessandro, nelle loro repliche giornalistiche (belle e equilibrate), a mostrare come quel ritratto sia lontano sia dalla ricchezza sfaccettata della psicoanalisi contemporanea, sia dalla natura intrinseca dell’esperienza psicoanalitica. Sappiamo tutti che, se ben condotta, la psicoanalisi è una esperienza fondamentale di libertà, che anzi consente, in una atmosfera complessiva di condivisione e accoglienza, di non rimanere del tutto schiacciati dalle proprie storie, di riattualizzare gli schemi e i legami in cui esse sono rimaste imprigionate, per provare a sgrovigliarle, a riaprirle, a rintracciarne le potenzialità non espresse, gli aspetti non detti, le microstorie in attesa di pensabilità rimaste latenti in quei grovigli, il futuro dimenticato in esse….O almeno di provare a farlo.
Oddio, ovviamente non è che siano tutte rose e fiori dentro l’istituzione psicoanalitica (che, come del resto tutte le istituzioni, è il contenitore che organizza anche dinamiche molto magmatiche e primitive). Ma che differenza rispetto alla impronta familistica che ho conosciuto io, nei miei anni di apprendistato, in cui tutto veniva deciso in segrete stanze dove genitori, zii e nonni (analitici) si intrattenevano tra loro, in oscuri rapporti (la cui misteriosa conflittualità spesso esplodeva apertamente anche davanti a noi piccoli )… Almeno a partire dall’esecutivo Di Chiara è stato fatto un grande lavoro di trasparenza e democrazia, che dovrebbe almeno un poco mitigare le fantasie più persecutorie sulla scena primaria. Almeno un poco, via…sappiamo quanto siano tenaci…e anche utili (entro certi limiti…), come periodicamente anch’esse riesplodano. Il che non significa ovviamente che non si debba lavorare per rendere la nostra istituzione sempre più aperta, trasparente, democratica, partecipata…
Ma anche riguardo a tutto ciò, la caricatura grottesca, carica di astio, che Risoldi ci propone non ci aiuta un granché.
O ancora: Freud non ha scoperto l’inconscio e la psicoanalisi non serve a nulla, semmai fa solo danni?! Vale la pena di metterci a discutere di tutto questo ora con Risoldi? Dobbiamo argomentare sui giornali (o magari in tribunale) per difendere, da queste affermazioni, il ruolo di Freud nella scoperta dell’inconscio (quello psicoanalitico)? 55 anni dopo Ellemberger? O metterci a discutere con Corbellini sull’ epistemologia della psicoanalisi? O affannarci a portare (magari in tribunale?) i dati di una letteratura oramai ampiamente consolidata (importante e noiosissima, ma sulla cui “scientificità” neppure Corbellini avrebbe, se la conoscesse, da obiettare….) che dimostra (…gulp, sono io, ora, costretto a mettere da parte tutti gli infiniti problemi di metodo che rendono scivolosissimi questi termini…) che, malgrado il cuore dell’esperienza analitica non riguardi il piano dei sintomi, persino sul piano dei risultati terapeutici (…nuovo esercizio di epochè ….), inevitabilmente definiti e standardizzati come richiesto da questo tipo di valutazione (…altro esercizio di astinenza…) non abbiano comunque nulla da invidiare a nessun altro trattamento; anzi. Dobbiamo ora impigliarci in queste questioni?
Certo, i toni diffamatori infastidiscono e sacrosante sono state le repliche puntuali (io ho particolarmente apprezzato, tra esse, quella pacata ed empatica di Bolognini). Così come è importante, ovviamente che, in altre sedi, i colleghi che generosamente si impegnano sulla questione della “valutazione” continuino a farlo e si facciano anche sentire, come i molti altri che lavorano sulle questioni di “metodo”… Ma io di nuovo ipotizzo che Risoldi stessa, che è psicoanalista, non sia affatto così sprovveduta e conosca in realtà queste cose. E ripeto: la mia idea è che le sue semplificazioni “diffamatorie” abbiano ben poco a che vedere con considerazioni scientifiche…ma che anche la intensità della indignazione che, tra di noi, ne è seguita ha forse poco a che fare con i contenuti di quella denigrazione.
Ma prima di arrivare al punto centrale della mia riflessione, permettetemi un’ultima considerazione, che il coro di indignazione seguito al maldestro tentativo di scoop di Repubblica mi suggerisce. So che la sto tirando per le lunghe e me ne scuso. Evidentemente il punto centrale del mio discorso non è emotivamente semplice…
Da sempre la psicoanalisi è oggetto di denigrazione, talvolta aperta, molto più spesso nascosta e indiretta. Fa parte della sua storia. Dovremmo averci fatto il callo. Vi ricordate come furono trattati Freud e Abraham nelle rispettive società mediche di Vienna e di Berlino? Ma questo non è stato un fenomeno solo degli inizi.
L’ostilità verso la psicoanalisi ha continuato a serpeggiare in forme e in modi diversi anche dopo il suo successo, anche dopo l’apparente grande riconoscimento di cui ha goduto e la sua integrazione nel canone culturale mainstream. Ė un fenomeno su cui forse non abbiamo ancora pensato abbastanza, distratti e magari compiaciuti per la popolarità un po’ superficiale di cui la psicoanalisi gode (e noi con loro) nelle terze pagine dei giornali, magari un po’ abbagliati dalla ammirazione transferale di cui godiamo da parte dei nostri pazienti o del pubblico e di cui dovremmo, in entrambi i casi, percepire il versante problematico; nel caso dei nostri pazienti, poi, è nostro compito specifico, bel lungi che coltivarla, quello di riuscire a poco a poco a trasformarla rispetto alle idealizzazioni primitive…una volta Alberto Semi, non mi ricordo più in quale circostanza, segnalò quanto la sensazione di stare diventando “irrilevanti” per i nostri analizzandi (o supervisionati…) potesse essere un indicatore positivo….
Quell’ostilità e quella diffidenza invece sono rimaste diffusissime. E sono, per certi versi, un fenomeno da capire meglio, dato che la “peste” che la psicoanalisi porta con sé non è certo più quella cui alludeva Freud al tempo del viaggio in America….
Mi concedo, comunque, prima di finalmente arrivarci, a quel punto centrale, un altro aneddoto/ricordo. Verso la fine della mia carriera universitaria, circa 20 anni fa, l’incastro abbastanza casuale di complesse vicende accademiche portò alla mia nomina a direttore di un Dipartimento universitario che assunse poi il pomposo nome di Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento. Tenni quella carica alcuni anni, fino al pensionamento. Era un dipartimento molto grande, che comprendeva, oltre alla psichiatria (la mia disciplina), la neurologia (che a Pavia è molto potente e, sul piano assistenziale, ha addirittura un suo IRCCS, il “Mondino”), la psicologia (col suo corso di laurea), la neurochirurgia, la neurofisiologia, la statistica sanitaria, le scienze dell’alimentazione…. Vi potete immaginare la conflittualità…e anche gli storcimenti di naso (o i rivoltamenti di stomaco) all’idea di uno psichiatra (per giunta psicoanalista) a capo di quel popò di roba….Per quel che mi riguarda, avevo accettato quel compito, così estraneo al mio carattere, fondamentalmente proprio per cercare di proteggere e tramandare la tradizione psicodinamica e psicoanalitica della psichiatria pavese (quella di De Martis e Petrella, per intenderci). Come direttore di questo mega-dipartimento fui quindi implicato in una serie di commissioni nazionali. Durante una riunione di una di queste doveva essere eletto un ristretto nucleo di rappresentanti dei dipartimenti di Neuroscienze che avrebbe dovuto interfacciarsi col ministero su certe faccende (che avrebbero potuto riguardare anche la psichiatria). Fui eletto. Al termine della votazione si avvicinò un collega di una università del Sud, un neurologo, che, prendendomi sottobraccio, mi disse: “Barale, complimenti, io, sai, ho votato per te, ci tengo che tu lo sappia…perché ti stimo e hai questa fama di gentiluomo, di persona correttissima… ma dimmi però una cosa…in confidenza…tra amici…cos’è questa faccenda di cui malignano i neurologi di Pavia….una calunnia penso…che pratichi la psicoanalisi??”. Disse proprio così : “che pratichi la psicoanalisi”, come fosse una turpe pratica segreta….Scherzai sui vizi occulti di ognuno di noi…anche i correttissimi.
Dunque, dovremmo averci fatto il callo su questa ostilità (e, semmai, capirla meglio e approntare difese efficaci…). Credo che ognuno di noi potrebbe portare i suoi aneddoti….Ma allora, cosa ha acceso l’indignazione generale?
La visibilità mediatica? Fastidiosa, ma via, non esageriamone la portata ….nel bene e nel male! Sappiamo come funzionano i giornali….Certo, un buon ufficio stampa potrebbe in effetti farsi carico di tenere sistematici rapporti con le pagine culturali e i media, per facilitare una informazione più corretta. Ma fenomeni di questo genere rimangono pressoché inevitabili e possiamo consolarci considerando che non è il terreno della visibilità effimera quello in cui le tracce forti vengono lasciate; quelle che garantiscono credibilità e prestigio nel lungo termine …Certo, ci manca un personaggio come Musatti, che sapeva con grazia straordinaria frequentare il difficile crinale della divulgazione e anche della presenza mediatica (quella di allora), senza mai scemare in autorevolezza o in qualità. Crinale per la verità scivolosissimo….se non altro perché psicoanalisi vuol dire anche riservatezza, sguardo rivolto all’interno, misura, ironia, che stridono con eccessi di visibilità, atteggiamenti da guru, discorsi altisonanti, toni da comizio o banalità rivestite di sapienza e oscurità… e che ha i suoi rischi anche nei casi di grande “successo” (le parodie di Crozza e della “psico-b-analisi” insegnano).
Io credo che un elemento importante, per spiegare l’intensità delle emozioni che un episodio in definitiva abbastanza banale ha sollevato, sia proprio che Risoldi “è una di noi”. Da questo punto di vista, l’accostamento al caso Masson coglie qualcosa di giusto (fatte le indispensabili proporzioni tra le grandezze).
“Una di noi” si è rivoltata con quell’acrimonia dissacrante contro la Psicoanalisi in cui noi tutti crediamo! C’è un vago sentore di accusa di “blasfemia” (che paradossalmente darebbe ragione a Risoldi…) in alcune punte di quella indignazione…che travalica la “sacrosanta” esigenza di difendere (nelle sedi opportune e ragionevoli…non in tribunale…) la verità….Così come era proprio quel particolare sentore (non tanto l’aspetto “epistemologico” o la violenza con cui il disaccordo veniva sostenuto) ciò che colpiva nella celebre invettiva dalla quale taluni di noi sono stati in passato colpiti; a me capitò, in modo esplosivo durante un convegno italo-francese, un 20-25 anni fa (non ricordo esattamente, era comunque durante la presidenza Chianese) mentre facevo una relazione, dopo César Botella, sui fondamenti della vita psichica: fu un maestro da me venerato che, rosso in faccia e pieno di rabbia, alzandosi in piedi dalla seconda fila e puntandomi il dito contro, mi investì della sua versione parigina (“ça n’est plus de Psychanalyse, cher confrère!!! Ça n’est plus de Psychanalyse!!!!!!!)….Come al solito, in questione non è il “cosa”, ma il “come” della “credenza” che si osava mettere in discussione….
Avanzo una congettura, senza alcuna pretesa di verità. Quel che è successo può aver funzionato da specchio di qualcosa che potrebbe riguardarci tutti e che ovviamente ognuno di noi subito allontanerà con sdegno?
Ciò che è entrato drammaticamente in risonanza è il sistema di idealizzazioni (della psicoanalisi…ma anche del comunismo, nel caso di Risoldi…) che facevano da “fondamento narcisistico” al sentimento di una appartenenza investita di forte valore identitario.
Il dolore intollerabile gioca un ruolo centrale nella mia congettura. Esso, in generale, impatta in modi talvolta drammatici in quel sistema, sulla sua “qualità interna”, sul modo in cui le idealizzazioni primitive sono evolute, si sono trasformate, sul reticolo di interiorizzazioni buone con cui si sono intrecciate e che possono sostenerlo; intreccio da cui può dipendere anche la capacità di reggere l’urto con il dolore della vita.
Freud ci ha insegnato che la psicoanalisi non garantisce alcuno scudo al dolore della vita, così come non può ha nulla a che vedere con la “stella della redenzione” che indica la strada verso un mondo privo di conflitti. Ciò che da essa ci si può aspettare, ben che vada, è che consenta di alleggerire del surplus di privata miseria nevrotica il carico della infelicità comune. La psicoanalisi non illude e non delude, come è stato giustamente fatto notare; dovrebbe consentirci di entrare meglio in contatto con la verità psichica e di meglio tollerarla.
Ma è solo così? Tutti noi, quando abbiamo iniziato la nostra analisi personale, avevamo grandi attese e grandi speranze di palingenesi. La situazione psicoanalitica per sua natura rimobilita tutto il sistema delle idealizzazioni primitive. Ė anzi necessario che lo faccia. Essa stessa peraltro attiva nuove idealizzazioni, nuovi percorsi e oggetti idealizzati, che prendono il posto di quelli primitivi. Anche i benemeriti processi di sublimazione (che consentono la Kulturarbeit) ne sono intrisi. Pensate alla potenza dei fenomeni transferali… alla loro trama, al modo in cui da essa viene alimentato anche il transfert sulla Psicoanalisi stessa…Questa rimobilitazione dovrebbe essere al servizio di una trasformazione verso soluzioni più integrate, flessibili, bonarie, realistiche, ironiche, giocose. Non sempre è così. Spesso, negli esiti, c’è troppo poco gioco. E l’idealizzazione della psicoanalisi, delle cui vesti splendenti continuamente ci ammantiamo (basta ascoltare il tono iperbolico di molti nostri discorsi per percepirne la traccia…nella implicita o esplicita “grandiosità” che suggeriscono…) si presta in un angolino dei nostri animi a perpetuare la “stella della redenzione” e a funzionare da erede di quelle imago genitoriali cui attribuivamo straordinari poteri. Il sistema delle idealizzazioni peraltro è complesso, non è un monolite e la qualità della sua integrazione con il sistema degli investimenti oggettuali e degli oggetti interiorizzati non è mai definito una volta per tutte; è in perenne divenire e perennemente esposto alla disorganizzazione e a drammatiche cadute/delusioni.
In un piccolo scritto (“Una eudaimonia psicoanalitica?”) che uscirà sul prossimo (bellissimo) numero di Psiche, dedicato al tema della Felicità, mi sono permesso di autobiograficamente trattare la questione. Cosa succede del sistema di idealizzazioni di fronte al dolore personale estremo? Quello che ti fa gridare “perché a me!!??” Cosa succede ad esso quando impatta con un Male incomprensibile, impensabile, intollerabile?
Ma il dolore intollerabile può capitare a tutti. L’intero sistema delle idealizzazioni può cedere drammaticamente, trasformandosi in proiezione persecutoria: gli oggetti prima idealizzati diventano allora traditori inadempienti che svelano la loro miseria ammantata di gloria, la loro inconsistenza (dal punto di vista della protezione interna che avrebbero dovuto inconsciamente esercitare). Persecutori da disprezzare
Ripeto ancora una volta: anche se nel racconto di Risoldi l’ infrangersi delle “illusioni” (psicoanalisi, comunismo…) è direttamente collegato alla malattia del marito, alla sua straziante agonia non intendo e non mi senso di entrare più di tanto nelle vicende personali di una persona che non conosco. Questa non è certo, del resto, la finalità di queste mie note. Mi interessa portare avanti la mia congettura in quanto tale, per il valore generale che (forse) ha e per le implicazioni complessive verso il modo di intendere il nostro lavoro; per l’attenzione che suggerisce verso questi versanti delicati, sia nelle analisi personali che durante i percorsi di training.
Se la mia ipotesi ha qualche senso, diverse questioni ci investono come psicoanalisti e, in particolare come analisti che trasmettono la psicoanalisi…… Gli psicoanalisti non sono immuni da tutto questo, ma in cuor loro possono mantenerne l’illusione. E come tutti sono esposti a break down drammatici del sistema delle idealizzazioni, per le ragioni più varie e di ordine più disparato. I break down stessi possono assumere le forme più diverse. Riuscire ad essere più o meno elaborati. In alcuni casi, no. Portare a esiti anche drammatici. A proposito di scheletri nell’armadio: è mai stata fatta una riflessione sui colleghi che si sono suicidati? Io ne ho conosciuti personalmente almeno 4.
Il tema dell’idealizzazione è a mio parere un tema delicatissimo, rilevante su diversi piani. Innanzitutto su quello del tipo di esperienza che offriamo ai nostri analizzandi, che può essere decisiva sul destino del sistema delle idealizzazioni con cui arrivano sui nostri lettini. Ancor più rilevante nel percorso di training, per non alimentare ulteriormente percorsi di idealizzazione che sono tanto più fragili quanto più “grandiosi”.
Se c’è una lezione che possiamo trarre da questa vicenda è quella di facilitare in tutti i modi, nelle analisi che conduciamo, nei dispositivi del training, una psicoanalisi non monumentale, ma laica, aperta, bonaria, giocosa, ironica, non roboante, dove sempre meno si percepisca l’odore di incenso della “grandiosità…” Anche questa, negli anni ’90, era stata una battaglia di Luciana Nissim, di Stefania Manfredi e di molti altri…..