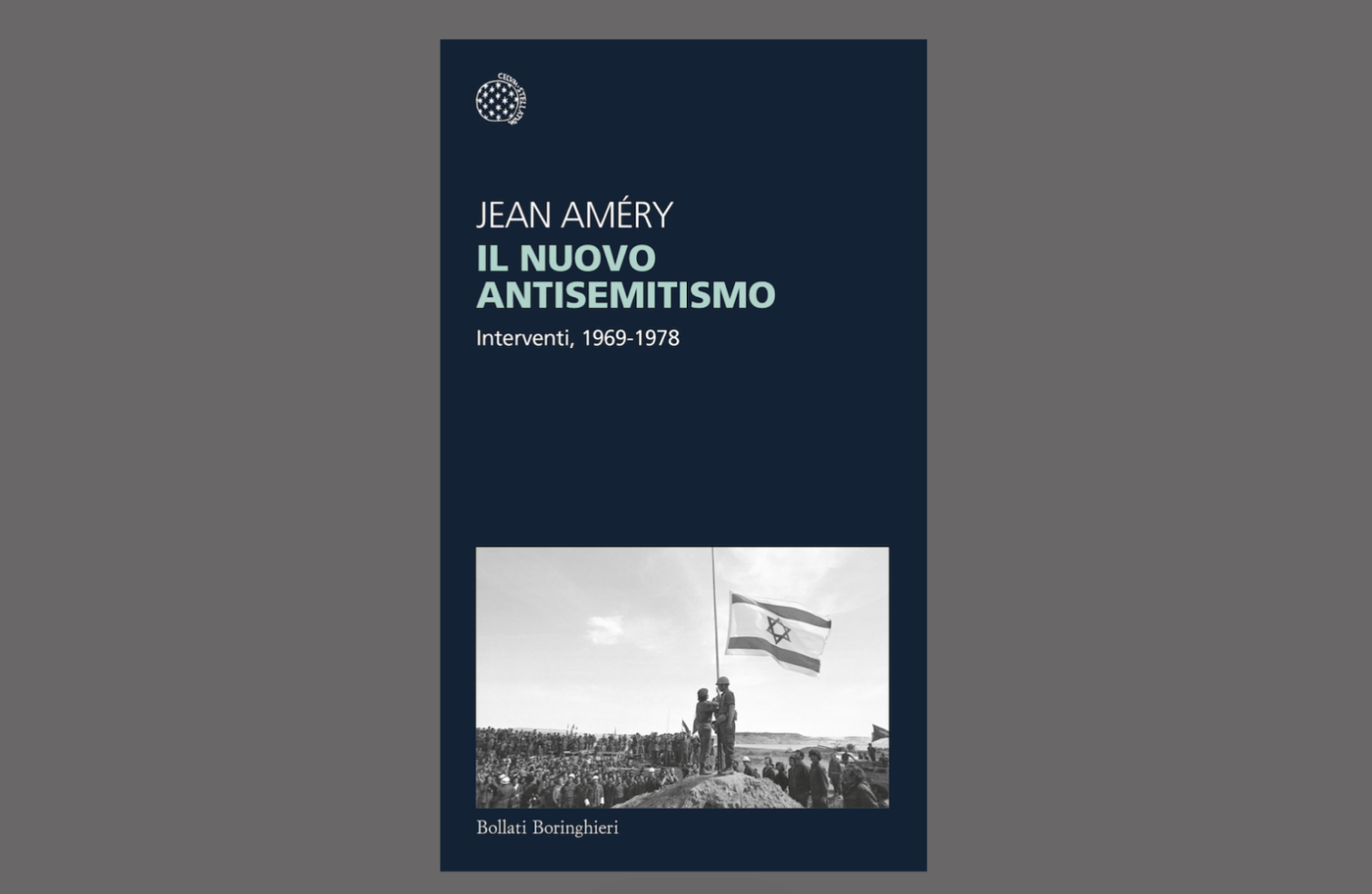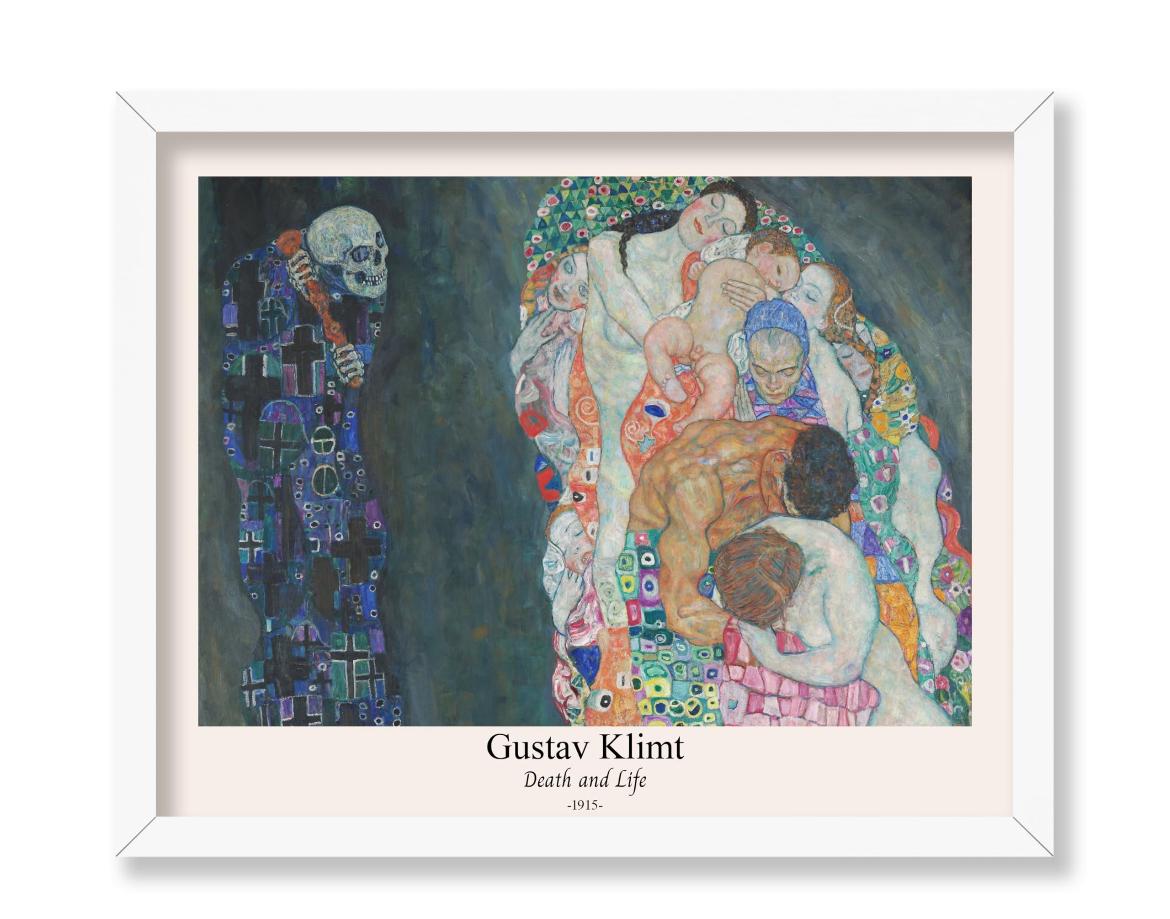
Gustav Klimt Death and Life – 1915
Parole chiave: Identità, identificazione, distruttività, traumi collettivi, eros
Negli ultimi mesi una parte degli psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana, si sono in vari modi confrontati su quanto sta avvenendo a Gaza per mano di Israele. Su sollecitazione di un significativo numero di Soci mossi da un’urgenza interiore[1] (ben un quarto del totale), l’Esecutivo della SPI ha emesso, unica società psicoanalitica al mondo, un comunicato pubblico che tutti possono leggere in Spiweb.
Ben 394 Soci hanno sottoscritto, fino a metà luglio, un documento di denuncia delle atrocità in corso partecipando ad un’iniziativa internazionale volta a chiedere un pronunciamento dell’IPA, la società internazionale che riunisce gli psicoanalisti a livello internazionale.
Queste iniziative, che per altro non tutti hanno condiviso ed apprezzato, meritano di essere accompagnate da una riflessione che possa anche rispondere agli interrogativi che alcuni tra noi hanno posto: è come psicoanalisti che in queste circostanze dobbiamo/possiamo esprimerci? Farlo, non comporta la fuoriuscita dallo spazio specifico che compete ad una società scientifica, laddove ognuno ovviamente può avere ed esprimere liberamente i suoi punti di vista come cittadino e quindi non specificamente in quanto psicoanalista? Perché pronunciarsi in questo caso? E farlo ora come è avvenuto solo in rari casi e frangenti[2]? Ci sono riflessioni prettamente psicoanalitiche che gli psicoanalisti possono proporre al dibattito che ormai ovunque è all’ordine del giorno? Pensieri che possano servire a riflettere sui processi in atto in un momento in cui sembra sempre più difficile usare il pensiero e coniugarlo con un’azione capace di creare condizioni di sopravvivenza, sicurezza e giustizia per tutti?
Ebbene, alcune osservazioni avanzate nel dibattito che si è sviluppato tra i Soci della SPI per sostenere le iniziative proposte sono anche, in certa misura, risposte a queste domande: la tragicità degli eventi; l’essere ciò che viene perpetrato un superamento del limite che noi esseri umani dovremmo essere impegnati a rispettare; l’essere Israele un paese che si dichiara democratico ed il cui governo (col sostegno e il mandato dei suoi elettori) sta portando a queste conseguenze la ritorsione per i terribili e colpevoli crimini contro l’umanità compiuti da Hamas il 7 ottobre del ’23[3]; Sicuramente queste e molte altre sono le ragioni che ci hanno spinto a prendere posizione, ma, come si vede, sono le stesse che potrebbero muovere, e così per fortuna sempre di più sta avvenendo, lo sdegno e la riprovazione di singoli cittadini, associazioni e stati.
Credo però che per gli psicoanalisti, a motivare la nostra attivazione, ci siano anche elementi emotivi oltre che razionali. Quanto essi siano espressione essenziale della vita ma contemporaneamente fonti di insidie e pericoli per le radici profonde che hanno e per la loro storia complessa e oscura ci è ben noto e dobbiamo sempre tenerne conto. Nel nostro e attuale caso vanno comunque al di là dell’essere sconvolti e trovano fondamento proprio nella consapevolezza delle persecuzioni che hanno sempre subito gli ebrei e che in questo momento stanno subendo ancora una volta in modo estremo gli ostaggi non solo tolti alla vita, ma resi oggetto di spettacoli macabri ad opera dei loro aguzzini. Elementi che con quelli razionali si intrecciano e che ci inducono a pronunciarci anche se, apparentemente, proprio di quella consapevolezza dimentichi. Poca cosa, si potrà dire, queste eventuali nostre emozioni[4] a fronte delle ‘vere’ tragedie, ma comunque per chi ne è sensibile non insignificanti. Voglio quindi accennare anche ad esse, prima di provare a ‘dire qualcosa di psicoanalitico’, anche perché questi cosiddetti elementi emotivi che ci fanno sentire una sorta di familiarità fanno parte del nostro essere psicoanalisti, cioè della nostra stessa interiore identità[5].
Alcuni psicoanalisti sono ebrei, molti non praticanti, qualcuno credo di sì. Essi sono certamente coinvolti in modo speciale dalle vicissitudini di Israele e, se credenti, dei loro correligionari.
Credo però che per molti di noi non ebrei abbia un peso che il nostro capostipite, ideatore della psicoanalisi e fondatore della società che riunisce tutti gli psicoanalisti (l’IPA), Sigmund Freud, fosse ebreo. Ebreo, anche se laico. Ebreo che ha dovuto lasciare la sua terra, e sappiamo quanto riluttante fosse e quanto gli sia costato, per mettersi in salvo[6]. Dovendo anche abbandonare parte dei suoi stretti familiari alla sorte dell’assassinio per mano dei nazisti. Lasciandosi alle spalle parte della sua ‘creatura’, la società psicoanalitica tedesca in particolare, a subire le vessazioni dei tiranni, le ambiguità di alcuni[7]e le ritorsioni anche di vecchi colleghi[8].
“Ho sempre cercato – aveva scritto Freud nel 1926 all’associazione ebraica di Vienna[9] di cui faceva parte – di reprimere l’orgoglio nazionale, quando ne sentivo l’inclinazione, come qualcosa di calamitoso e di ingiusto, spaventato dagli esempi ammonitori dei popoli in mezzo ai quali, noi ebrei, viviamo. Ma tante altre cose rimanevano che rendevano irresistibile l’attrazione per l’ebraismo e gli ebrei, molte oscure potenze del sentimento [quelle che evocavo poco sopra], tanto più possenti quanto meno era possibile tradurle in parole, così come la chiara consapevolezza dell’interiore identità, la familiarità che nasce dalla medesima costruzione psichica” (1926, 342). Altrove però aggiunge: ‘Se qualcuno mi chiedesse cosa c’è di ebreo in me, risponderei una grande parte e probabilmente l’essenza di ciò che è l’ebraismo. È qualcosa che non posso esprimere in termini chiari, ma certamente verrà un giorno in cui lo spirito scientifico potrà metterlo in evidenza’” [10]. Di più non ci dice e c’è spazio per metterci del nostro. Anche in questo caso ciò significa che siamo inevitabilmente esposti alle radici complesse ed oscure di noi stessi. Fonti di ricchezza ed eventualmente anche di inganni.
“Medesima costruzione psichica”: è un’affermazione, è anche però un’aspettativa, di non piccola portata.
Lo è anche, forse soprattutto, perché implica per noi il misurarsi con l’essere la psicoanalisi una scienza che non richiede di essere ebrei per poterla apprezzare, ma che implica il riconoscersi, pur con i limiti ora dichiarati, in quella ‘costruzione psichica’ per poter far proprio, fino a renderlo un elemento identitario (e riecco l’identificazione!), un modo di funzionare a livello intellettuale. Così lo definisce Freud in una lettera ad Abraham (lettera del 3/5/1908): un modo di funzionare a livello intellettuale. Quello che fu di Freud, che evidentemente non nasceva con lui, sulla cui origine egli si interrogava e che, in ogni caso, si è mostrato adatto ad avvicinare l’inconscio.
Un modo di funzionare a livello intellettuale, quindi un qualcosa almeno in parte fondato a livello preconscio e conscio e ciò ci autorizza a far uso di quello che sappiamo grazie alla teoria psicoanalitica. Se così non fosse la consapevolezza delle oscurità che si celano in noi e delle complessità sempre in gioco ci condurrebbero ad un’immobilità e ad una inerzia impotenti.
Credo che, consapevoli o no, e certamente per molti altri motivi nonché per la consapevolezza delle nostre colpe storiche che vanno purtroppo al di là di quelle dell’Italia fascista e che le precedono di secoli, le vicende degli ebrei ci siano care anche se qualche volta le posizioni che esprimiamo ad alcuni possono apparire espressione di rigurgiti antisemiti. E di questo si può oggi facilmente essere accusati.
C’è quindi, almeno per alcuni di noi, una questione affettiva specifica che va al di là delle ragioni etiche, politiche e delle relative appartenenze[11].
Questi nessi affettivi ci danno dei diritti? Certamente di no. Ci danno piuttosto dei doveri, proprio per la nostra ‘discendenza’.
Vengo allora a proporre qualche pensiero che nasce dalla mia pratica e dai miei studi come psicoanalista.
Parto dalla domanda che ho messo nel titolo ‘semplice’ eccidio o genocidio?
che è diventata progressivamente non solo oggetto di dibattito, legittimo ed opportuno, ma luogo di tensioni che meritano di essere indagate.
Dico subito che non credo di aver titolo in quanto psicoanalista per dirimere la questione. Ci sono decine di ‘cultori della materia’ che stanno affrontando dal punto di vista giuridico e storico la questione, collocandola molti di loro sullo sfondo delle riflessioni che, come studiosi, hanno portato avanti avendo come oggetto specifico delle loro ricerche il genocidio organizzato e perpetrato dai nazifascisti allo scopo di eliminare dalla faccia della terra il popolo ebraico. Per non dire dei rappresentanti e leader politici e di associazioni umanitarie, nonché di tutti quelli che in questo momento dicono la loro su questo argomento.
Penso però che un interrogativo, che ha a che fare con i pensieri che intendo condividere e quindi pertinente all’angolatura di questo scritto (e che non riguarda la conclusione cui arriverà la Corte Penale Internazionale né il dibattito in corso di cui ho appena detto), possa essere introdotto: riguarda le reazioni degli uni e quella che appare come un’insistenza accanita degli altri?
Mi chiedo: cosa potrebbe mettere in luce il modo di reagire, allarmato e scandalizzato, che hanno molti israeliani, ma anche moltissimi ebrei non israeliani e non solo, che istantaneamente si attiva al solo nominare il termine genocidio in relazione alla distruzione che sta perpetrando Israele a Gaza? Ad essi prontamente si accodano altri che con loro si identificano. E non mi riferisco a chi porta argomenti per dissentire, e tantomeno a chi affronta o evita di affrontare la questione per vili e indegni calcoli politici.
Non può certo lasciare indifferenti l’essere accusati di perpetrare crimini di cui si è sempre e si continua ad essere vittime e che sull’esserne storicamente le vittime potrebbe essersi costruita una parte importante dell’identità. Sicuramente ha un ruolo rilevante la consapevolezza che un eventuale uso improprio della specifica ‘categoria giuridica’ (perché a questo rimanda il termine genocidio) possa snaturarne il significato ed automaticamente servire a circoscrivere, mitigare o addirittura denegare le colpe specifiche della Shoah, di chi l’ha compiuta e di chi ne porta (come noi tutti) la responsabilità storica. Al solo nominare l’ipotesi che Israele possa essere accusata di genocidio si scatenano però, e comprensibilmente, anche le potenze del sentimento: la reazione sembra di difesa di fronte ad una minaccia esistenziale. Una reazione che sembra avere l’intensità del vissuto che ha messo in moto Israele dopo il 7 ottobre. Anzi, dice Tom Segev,[12] “per un attimo ho avuto l’impressione che la narrativa del 7 ottobre come trauma collettivo fondativo[13] potesse sostituire quella dell’Olocausto. La gente e i media per qualche mese parlarono della ‘Shoah del 7 ottobre’, ma adesso non più. Gli stessi esperti del Museo dell’Olocausto a Gerusalemme hanno puntato il dito contro la travisazione della memoria. Ora quel fenomeno è rientrato”.[14]
Mi chiedo però se una istantanea e specifica sensazione di pericolo non possa dipendere – al solo veder associato il termine genocidio a qualcosa d’altro rispetto alla propria storia ed alla propria esperienza – dal ritenere e, soprattutto, sentire messo in discussione un elemento di identificazione fondante dell’identità[15]. Prendendo allora, conseguentemente e automaticamente, il sopravvento le potenze del sentimento.
Che nesso c’è tra identificazione, un processo psichico essenzialmente inconscio, e scatenarsi delle potenze del sentimento che possono arrivare al punto di travolgere l’Io e quindi ostacolare tanto il pensiero quanto il rapporto con la realtà? Anche questo dovrà essere oggetto di studio, ma in prima approssimazione direi che proprio il fatto che l’identificazione sia un processo inconscio che esprime un legame emotivo che di norma è ambivalente può portare, in assenza di una sua adeguata elaborazione, ad esiti imprevisti proprio grazie a quella quota di affetto che (ambivalente) può catalizzare ostilità e insoddisfazione latenti di cui si è restati inconsapevoli.
Cosa comporta riconoscersi reciprocamente in un modo di funzionare a livello intellettuale (come è stato il caso di Freud) frutto di una storia plurimillenaria o valorizzare un’etica condivisa (che è quanto richiama Grossman nell’intervista che ho citato più sopra: “la nostra presunta sensibilità alle sofferenze dell’umanità”), quella che, credo, stia muovendo gli israeliani che con coraggio manifestano solidarietà con i Gazawi, mentre reclamano la liberazione degli ostaggi? Cosa comporta riconoscersi invece nella comune credenza in un Dio[16], nella ripetizione di pratiche rituali unificanti e di reciproco riconoscimento[17], nel recupero e nel possesso di uno spazio mitico più ancora che di un territorio geografico[18], uno spazio per di più che sarebbe stato (come pensano alcuni) assegnato da un Dio? E ancora, essere uniti da una catastrofe come è stata la Shoah o come è stato il 7 ottobre? Cosa comportano per i singoli e per i gruppi e cosa possono produrre o scatenare tali diverse identificazioni?
Credo ci siano delle differenze sia nel modo di vivere l’appartenenza che nel difenderla.
E’ evidente che ogni singolo individuo elabora, a livello inconscio, preconscio e conscio, una sintesi personale e unica di queste componenti, ma a livello sociale credo che singoli sottogruppi si ritrovino a rappresentarne una o alcune, piuttosto che altre o, più o meno consapevolmente, s’incarichino di farlo. Ne risultano azioni sul piano concreto e politico assai diverse.
Nello scrivere queste frasi mi viene naturale pensare alle molteplici tribù che costituiscono l’unità mitica del Popolo di Israele e che, in qualche modo in questa mia immagine, possono alludere anche a vari gradi del percorso dalla sensibilità alla spiritualità di cui ci ha parlato Freud nel Mosè[19].
Dalla sensibilità alla spiritualità, o viceversa giacché questo percorso può realizzarsi, specie in particolari circostanze (tra queste certamente le situazioni di pericolo), anche a ritroso con quanto ciò può comportare: dalla spiritualità alla sensibilità, cioè dal simbolico al concreto.
Non possiamo sottovalutare gli effetti di incitamento all’odio, con conseguente perdita del controllo sulle azioni che si compiono,[20] dei continui proclami di ministri del governo di Israele che, nemmeno sempre mimetizzati da argomenti riguardanti la difesa necessaria di fronte ai pericoli che corre il loro Paese, mirano a scatenare la distruttività o quantomeno hanno questo effetto. I loro proclami enunciano propositi concreti a partire da un’interpretazione concreta del mito fondativo e scatenano azioni di odio.
Certo non sono gli unici a servirsi di queste armi e questo ci porta ad interrogarci sull’accanimento e quindi sull’uso che del termine genocidio può essere fatto.
Condivido al riguardo l’osservazione fatta da L. Segre[21]: l’uso accanito del termine genocidio può essere non un monito coerente con il dettato della “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio” che prevede appunto azioni di prevenzione e tra queste evidentemente anche le segnalazioni di pericolo e gli ammonimenti (nominati anche da Segre), ma un’arma di attacco per colpire proprio quel nucleo identitario cui ho accennato. Un’arma di guerra che mira a colpire tutti gli ebrei e per questo, in questo caso, indubbiamente antisemita.
Anche nel caso dei palestinesi è fonte di riconoscimento reciproco la catastrofe, la Nakba, con possibili esiti mortiferi, distruttivi e, alla fine, autodistruttivi. È evidente che Hamas come Movimento di Resistenza Islamica non ha come primo obiettivo, soprattutto in questo momento, il ‘bene’ del suo popolo ma, mosso da odio distruttivo, lo sterminio dei suoi avversari. Ciò lo priva di quanto siamo abituati a considerare umanità[22]: non solo perdura la tragica sorte degli ostaggi rapiti il 7 ottobre, ma totale indifferenza dev’esserci, da parte dei suoi aderenti o almeno di chi li guida, anche per le sorti dei palestinesi.
La crudeltà[23] può esserne o diventare una ‘soluzione’. Per tutti.
Ricordo le considerazioni di Fethi Benslama[24] a proposito dei processi di radicalizzazione che distruggono la politica e che si verificano nelle comunità islamiche[25] come reazione al sentir in pericolo gli ideali[26], cioè i capisaldi del sentimento di sé in relazione ad una comunità che li riconosce e li condivide. E’ questa, però, una triste realtà che, per l’aver convissuto a lungo col terrorismo islamico, è stata oggetto di studio e riflessione da parte di alcuni di noi[27].
Giusto o sbagliato, comprensibile o no, condivisibile o meno, quanto avviene, se le cose dovessero stare come suppongo, il pericolo di arrivare all’autodistruzione sarebbe grande[28] per i motivi che ora cercherò di mostrare mettendo all’opera alcuni ‘strumenti di lettura’ che mi sono abituali. Il mio punto di vista è questo, ma l’auspicio è che possa esserci un dibattito e soprattutto uno studio collettivo e polifonico. Credo, ad esempio, che sarebbe molto utile affiancare ai miei strumenti concettuali altri come quelli proposti da Kaës a proposito delle alleanze inconsce basate sul diniego di parti di realtà che mettono in crisi il patto sociale[29].
L’identificazione, unitamente agli ideali, con la complicità, le opportunità, ma anche i rischi che comporta la sublimazione[30] col suo portato di desessualizzazione sono fondamentali per la costituzione dell’Io e per le sue sorti. Per il bene e per il male. Come suggerisce Green, infatti, l’Io è intrappolato in una “rete [che] comprende il narcisismo, l’identificazione, la desessualizzazione [e] tutt’e tre hanno in comune, in ultima istanza, una funzione antagonista ad Eros”[31].
Poco oltre aggiunge, ed è rilevante per quanto voglio mettere in evidenza: “Ne L’Io e l’Es – nel capitolo sul Super-io, vale la pena di rilevarlo – la desessualizzazione è legata a quella che si potrebbe chiamare la narcisizzazione della libido, dal momento che la libido legata all’oggetto si trasforma in libido dell’Io. […] Ma qui Freud s’interroga: una trasformazione del genere non potrebbe avere come conseguenza un disimpasto delle pulsioni? Per Freud, ogni diminuzione dell’impasto delle pulsioni ha l’effetto di liberare le pulsioni distruttive. Il paradosso è quindi che l’apparente ‘arricchimento’ dell’Io che beneficia di questo apporto in più legato all’aumento della libido narcisistica a spese della libido oggettuale, come contropartita, lascia maggior campo alla pulsione di morte” (ibid., 304).
Richiamo tutto questo perché, dal mio punto di vista, nelle vicende che osserviamo in ballo ci sono gli elementi fondanti il sistema ideale/super-egoico, ma anche l’equilibrio, mai da poter dare per scontato e favorevole, tra tendenze verso la vita e tendenze verso la morte.
Equilibrio o disequilibrio che, con l’eventuale prevalere delle componenti distruttive può mettere in scacco proprio quell’autoconservazione[32] che si è avvertita minacciata dai pericoli esistenziali incombenti[33] e che si intendeva preservare. La distruttività e la sua escalation col superamento di ogni limite – nella misura in cui, non risolvendosi l’angoscia che anzi viene alimentata dai sensi di colpa oltre che dallo smarrimento crescente, essendo sempre più difficile arrestare la spirale pericolo-angoscia-aggressività per difesa-distruttività-persecuzione – porta alla fine, all’autodistruzione.
Come ho detto, usando le parole di Green, viene messo in scacco Eros: la forza che ci tiene in vita e che riesce nel suo intento solo se l’equilibrio tra gli investimenti oggettuali e quelli narcisistici (quelli che si giocano nei processi psichici edificanti ma potenzialmente destruenti dell’Io che ho nominato) non frana nella direzione di questi ultimi. Conseguenze ne sono in tal caso la progressiva perdita (a) di contatto con la realtà (e quindi anche del poter calcolare le conseguenze nel tempo delle proprie azioni) e (b) della capacità di riconoscere gli oggetti nella loro molteplicità e varietà (esseri umani compresi, in quanto oggetti psichici distinti da sé ma da riconoscere e rispettare nella loro singolarità per non smarrire la capacità d’identificazione con l’altro – non solo il proprio familiare/amico/simile – vedendo, inevitabilmente, crescere nella solitudine i vissuti persecutori); alla fine (c) non può che prevalere il potere di oggetti idealizzati cui viene naturale affidarsi e che, prendendo il sopravvento sugli oggetti ideali, portano ad un’inevitabile escalation persecutoria[34].
Temo siano determinati anche da processi psichici collettivi di questo tipo la frenesia e la brama di conquista dei coloni e le affermazioni scandalose delle componenti messianiche e fanatiche pronte a tutto e tutti sacrificare ed il peso che esse hanno nell’influenzare, senza che sia posto loro alcun limite, la politica di Israele anzi trovando in essa tragicamente sponda e rappresentanza. Non sto suggerendo letture semplicistiche di quanto sta accadendo e tantomeno perdo di vista la complessità dei fattori (religiosi, ideologici, storici, sociali, politici, geopolitici, economici[35] …) che lo influenzano, ma, se consideriamo il corpo sociale come un tutt’uno, non possiamo non tener conto del peso che possono avere processi psichici che si sviluppano e prendono il sopravvento nelle masse nel determinare gli eventi, il loro sfuggire di mano e le loro inevitabili conseguenze; processi che, in modo silente come è proprio della pulsione di morte, possono far scivolare tutti verso l’autodistruzione. Come succede negli individui, anche nelle società, se non riconosciuti i pericoli, se non si è messi in guardia da presenze amiche può ad un certo punto diventare troppo tardi.
Ecco perché gli amici degli ebrei non devono e non possono tacere in questi momenti, anche a costo di subire l’accusa di antisemitismo.
Eccepire che molte se non tutte queste osservazioni potrebbero essere riferibili e più opportunamente ad Hamas, alle molteplici famiglie di terroristi e fanatici di varia natura e religione in giro per il mondo, ai kamikaze suicidi, agli assassini per vocazione giustizialista, ai vendicatori di chissà che non ne annulla il significato. Semmai rende più urgente e necessaria la riflessione.
Due considerazioni finali.
La prima: Auspico un tempo ed un luogo perché gli psicoanalisti si ritrovino a riflettere sul dibattito che si è svolto, sulle posizioni prese, sulle vicende a tutto ciò connesse, su come intendere il ‘nostro’ dover rispettare una posizione ‘astinente’ per salvaguardare il pensiero ed infine chiarirci che intreccio pensiamo debbano/possano avere pensiero ed azione.
La seconda: Dovranno esserci un tempo e, spero molte, occasioni in cui ci si possa interrogare come psicoanalisti sull’incapacità che abbiamo avuto di utilizzare i nostri strumenti per prevedere e segnalare i pericoli e dare il nostro piccolo contributo per evitare di arrivare al punto in cui siamo. È stata un’incapacità, ma anche una colpa essendoci da sempre e sempre più negli anni occupati di traumi, di traumi collettivi, delle conseguenze distruttive dei traumi e, tra queste, la spirale distruttiva e autodistruttiva che innescano.
Un po’ di diniego serve per vivere; oltre un certo limite, come sappiamo, distrugge la capacità di pensare.
Patrizio Campanile
Venezia
patrizio.campanile@libero.it
[1] Uso gli stessi termini usati da D. Grossman nell’intervista rilasciata a F. Caferri per La Repubblica (1/8/25).
[2] Cfr. Riolo, F. (2005) Lettera al Presidente della Repubblica. Rivista di Psicoanalisi 51:1025-1025.
[3] Eccidio che, per la brutalità degli assassinii, gli stupri commessi, le orribili nefandezze che sono state compiute e l’ostentazione del piacere della crudeltà, ha esposto i Gazawi alle conseguenze di un’impresa terroristica ed assassina che perdura con il sequestro di ostaggi la cui vita innocente è ridotta a merce di scambio, ricatto e sbeffeggio e di cui tutti che abbiano o meno condiviso progetto, sua realizzazione e relativi festeggiamenti ora pagano le conseguenze.
[4] Chissà, forse solo mie.
[5] Uso la locuzione ed il termine che poco sopra ho messo in corsivo traendoli dal brano di Freud che tra breve citerò perché introducono un medesimo stato d’animo (per lo stesso motivo li metterò in corsivo anche nella citazione): Freud (1926), Discorso ai membri dell’Associazione B’nai B’rith, O.S.F. 10. 342.
[6] Vedi https://www.centrovenetodipsicoanalisi.it/13-marzo-1938-viene-sciolta-la-societa-psicoanalitica-di-vienna/
[7] Quanto ciò abbia avuto esiti tragici anche a distanza di molti anni è ampiamente documentato. Si pensi al lavoro di Besserman Vianna H. (1989). Politique de la Psychanalyse face à la dictature et à la torture. N’en parlez à personne… Paris, L’Harmattan.
[8] “La Deutsche Allgemeine Ärztliche Gesellshaft für Psychotherapie cadde sotto il controllo nazista nel 1933 […]. Il presidente supplente, il famoso professor Kretschmer, diede immediatamente le dimissioni e fu sostituito da Carl Gustav Jung. A questi fu assegnato il compito di tracciare una linea scientifica di demarcazione tra “psicologia ariana” e “psicologia ebraica”, cioè tra la propria teoria dell’“inconscio collettivo” e la psicoanalisi di Freud, contro la quale Jung poteva ora facilmente trarre vendetta […]. Nel 1936 il dottor Goering, cugino dell’omonimo maresciallo dell’aviazione nazista, fu nominato direttore della società di psicologia di Berlino. L’anno seguente anche la Società viennese cadde in mano dei nazisti. In seguito il Verlag, che aveva pubblicato l’opera completa di Freud, fu posto sotto sequestro, i suoi libri furono distrutti e la Società psicoanalitica di Vienna venne sciolta” (Zimmermann D., Mostardeiro A.L. (1991, 77). L’insegnamento di ‘Analisi terminabile e interminabile’. In Sandler J. (a cura di) (1991), Studi critici su Analisi terminabile e interminabile, Milano, Cortina, 1992).
[9] Discorso ai membri dell’Associazione B’nai B’rith. Freud (1926), O.S.F., 10.
[10] Il brano è tratto dalla prefazione all’edizione in ebraico di Totem e Tabù ed è citato in Baconcini, C. and Speziale-Bagliacca, R. (1983), Un’occasione mancata da Marianne Krüll?. Rivista di Psicoanal. 29: 576-581).
[11] Tutti elementi questi che non derivano direttamente dal nostro essere psicoanalisti, anche se, tra le fonti interne che comunque determinano le nostre scelte, l’esperienza psicoanalitica di incontro con l’umano ha su di esse un riverbero esattamente come ogni esperienza che ciascun essere umano fa determina la sua etica, le sue scelte politiche e le relative appartenenze.
[12] T. Segev è uno storico israeliano, autore tra gli altri del volume Il settimo milione. Come l’olocausto ha segnato la storia di Israele (1993, Mondadori 2001 – ne ha preannunciato una nuova edizione aggiornata per integrarla con la storia recente).
[13] Il corsivo è mio per richiamare la funzione aggregante e fondante il reciproco riconoscimento che hanno questi eventi. E qui si apre la necessità di riflettere sulle possibili conseguenze dell’eventuale affidare il nucleo della propria identità ad un trauma. Un lavoro che dovrà impegnarci come psicoanalisti.
[14] Nell’intervista rilasciata a Lorenzo Cremonesi per il Corriere della sera e pubblicata il 14/7/25.
[15] Come sottolinea anche S. Levi Della Torre, Israele è “un Paese che ha al centro della sua identità la memoria di un genocidio subito” (intervista rilasciata a F. Amabile, La Stampa, 6/8/25).
[16] Non va dimenticato il pronunciamento del 18/7/2018 della Knesset su Israele Stato-Nazione del popolo ebraico, legge che per altro legittima le colonie stabilendo che “lo Stato vede lo sviluppo degli insediamenti ebraici come un interesse nazionale”. All’indomani U. Tramballi su Il sole 24 ore si chiedeva se “Israele sia anche la stessa democrazia di ieri”.
[17] Condivise nella loro funzione unificante ed edificante anche dai non credenti.
[18] La Bibbia viene infatti (credo soprattutto dalle minoranze messianiche ma non solo da esse) considerato un testo storico e non una costruzione mitica fondativa ed elaborata assai successivamente rispetto ai fatti narrati o inventati. Vedi S. Sand (2008), L’invenzione del popolo ebraico, Milano-Udine, Mimesis, 2024: “Bisogna tuttavia attendere l’avvento della storiografia protonazionalista ebraica nella seconda metà del diciannovesimo secolo […] perché alla Bibbia sia esplicitamente attribuito un ruolo da protagonista nel dramma del consolidamento della moderna nazione ebraica. Dallo scaffale dei libri di teologia fu spostata in quello dei libri di storia e i propugnatori del nazionalismo ebraico cominciarono a leggerla come se fosse un testimone attendibile di processi ed eventi. […] Fu così che la Bibbia divenne il libro laico letto dai bambini per sapere chi fossero i loro avi e con cui ben presto gli adulti sarebbero orgogliosamente partiti per combattere le guerre di colonizzazione e indipendenza” (p. 206). Sempre Sand: “Possiamo continuare ad affermare che il popolo ebraico esiste da quattromila anni e che “Eretz Israel” gli è sempre appartenuta. Tuttavia, mentre i miti storici possono, con molta immaginazione, aver contribuito in passato a creare la società israeliana, rischiano, in futuro, di contribuire alla sua distruzione” (Le Debat, n° 158, Dossier : Autour de Comment le peuple juif fut inventé de Shlomo Sand, 2010/1, p. 192).
[19] Freud S. (1934-38). L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi. O.S.F., 11, pp. 430-4.
[20] Penso ai soldati dell’IDF che di questi fenomeni possono essere, anche inconsapevolmente, ostaggi e vittime.
[21] V. l’intervista da lei rilasciata a Z. Dazzi, La Repubblica, 2/8/25.
[22] Mi esprimo così, perché purtroppo è di questa pasta che, come genere umano, siamo anche fatti.
[23] Vedi Campanile, La crudeltà, il paradosso della sublimazione e la paura, Rivista di Psicoanalisi, 2017, 63(1):37-54.
[24] F. Benslama, L’idéal et la cruauté. Subjectivité et politique de la radicalisation, Parigi, Lignes, 2015.
[25] “Il fenomeno dell’impegno di migliaia di giovani nello jihadismo non è pensabile senza incrociare soggettivo e politico” (Benslama, 2015, 12).
[26] “La ferita dell’ideale si riapre ad ogni prova ed ogni prova richiamerà un ideale-di-noi-stessi divenuto emorragico” (ibid., 15).
[27] Si veda ad esempio, curato da D. Petrelli, il numero della Rivista di Psicoanalisi 2008, 54:629-638. Ma anche il mio articolo sopra citato (2017).
[28] V. il breve, ma rilevante saggio di A. Foa (2024), Il suicidio di Israele, Bari, Laterza.
[29] V. R. Kaës (2009), Les alliances incoscientes, Parigi, Dunod. Vedi anche la conferenza da lui tenuta alla Casa della Cultura di Milano organizzata dal Centro Milanese di Psicoanalisi nel 2016 in occasione del Giorno della Memoria dal titolo Il lavoro psichico della memoria nei traumi collettivi, reperibile a: ttps://www.youtube.com/watch?v=VzsGYTTgsRs
[30] Rispetto a identificazione, ideali e sublimazione ho indagato i possibili risvolti distruttivi in Campanile (2021), Freud dopo l’ultimo Freud, per una psicoanalisi sempre nuova, Milano, Franco Angeli.
[31] A. Green, Il lavoro del negativo, 1993, 303.
[32] Nell’autunno del 1924 al Centro Veneto di Psicoanalisi si è tenuto un convegno su Autoconservazione tra istinto e pulsione. Uscirà alla fine di quest’anno un KnotGarden sul tema (4/2025).
[33] Il 7 ottobre è stato universalmente sentito in Israele come la riprova di una grave minaccia esistenziale incombente.
[34] Su questo aspetto vedi: Campanile, Oggetto ideale e oggetto idealizzato, Rivista KnotGarden, 1/2023.
[35] Di questi ultimi ha ampiamente parlato F. Albanese nella sua recente (6/7/25) audizione alla nostra Camera dei Deputati. Per una sintesi, vedi https://www.youtube.com/watch?v=xzrlxuv_BrI