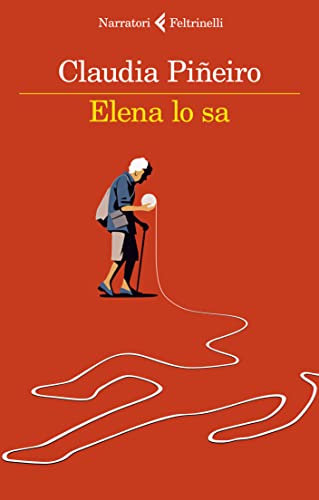
ELENA LO SA
di Claudia Piñeiro (Feltrinelli, 2023)
recensione di Daniela Federici
parole chiave: #corpo, #malattia, #istinto materno
La malattia, accesso involontario a noi stessi,
ci assoggetta alla ‘profondità’,
ci condanna ad essa.
Cioran
Elena lo sa che la figlia, Rita, trovata impiccata al campanile della chiesa, non si è uccisa; lo spiega per giorni all’ispettore, ma i suoi appelli risultano inutili. Davanti a quel lutto che le orba il futuro, a quella spiegazione che rifiuta, è decisa a scoprire da sola il vero responsabile. Così si prefigge di attraversare Buenos Aires contando di riscuotere un debito di gratitudine dalla donna che la figlia aveva aiutato vent’anni prima. È della sua forza giovanile che ha bisogno, perché il corpo di Elena è afflitto da uno stadio avanzato e invalidante di Parkinson, che ormai le concede movimenti minimi in una vita scandita dai tempi d’effetto delle pastiglie giornaliere.
Presentato come un giallo, un genere di cui la Piñeiro è navigata e pluripremiata Autrice, questo romanzo mostra bene come le più misteriose verità da scoprire siano le proprie.
Una storia lucida e struggente, a tratti feroce, che non indulge mai in sentimentalismi, che non ha timori di far venire a essere i pensieri più difficili e dissacranti, le scabrose intimità e la denuncia sociale, in un intreccio di temi duri e scomodi: il corpo che invecchia e si ammala, le logiche del sacrificio che gravano sul femminile, l’istinto materno che non è dato per natura.
Un libro dal notevole peso specifico, che fa uscire dal silenzio uno dei tabù della narrazione, e lo fa senza sconti di pena, perché non culla il lettore in una visione romantica della sofferenza. Il suo dar voce a una materia così delicata come la malattia, passa piuttosto attraverso una narrazione che trascina dentro l’inferno personale di un corpo che deraglia, sequestrato dall’arbitrio di Lei, la Maledetta, la malattia che pietrifica, che torce la protagonista piegandole lo sguardo a terra, il cervello come un re detronizzato che non si rende conto di non governare più.
Anche Nietzsche aveva battezzato il suo male cronico: il cane che nel profondo silenzio della notte ulula e trema. E Marie Cardinal scriveva della “lotta con la Cosa annidata nella mia testa, quella lurida matrona le cui gigantesche natiche erano i lombi del mio cervello” (Le parole per dirlo, Bompiani 1976).
Quello di Elena è un corpo alienato dal controllo, imprigionato e riottoso, reso estraneo da una malattia con cui deve convivere senza nessuna prospettiva di risoluzione, cui lei si oppone tenacemente facendone la misura della sua capacità di adattarsi, di trasformare il fato in esperienza, di esprimere fino all’ultimo la sua voglia di vivere.
Perché noi umani non lottiamo solo per la sopravvivenza ma anche per trasformare gli accadimenti e la pura esistenza in qualcosa di cui poterci appropriare invece di subirlo soltanto.
Il soliloquio di Elena parla dal suo corpo e convoca a sentirlo, nella lotta straziante per strapparsi al disanimato, nell’impotenza rabbiosa che si fessura di disperazione. Perché a differenza di quando aveva perso il marito, la morte della figlia è la vera morte, odore di condanna, perché ora c’è la malattia in quel precipizio di solitudine.
La perdita dell’oggetto è spesso anche perdita di sé, a maggior ragione quando la possibilità di un progetto vitale o di autonomia è appoggiato all’altro.
Quel che Elena va a cercare da Isabel è un corpo capace di sostenerla per vedersi riconosciuto ciò che le è stato tolto, come poter riavere indietro un ‘dovuto’ anche da lei, che pensa la aiuterà per onorare un vecchio debito. Lo sforzo sovrumano del viaggio per trovarla è un travaglio, l’affanno di ritrovare un ordine delle cose prima che sia tardi. Viene in mente la mise en scène della ripresa incessante che i resti impongono alla vita psichica, perché ciò che non ha trovato ancora il suo luogo, insiste a cercarlo. Ma l’incedere sincopato e la postura rigida della protagonista, che le impedisce di sollevare la testa e cogliere intera la visuale di ciò che la circonda, sembra una perfetta rappresentazione di quel che Elena sa perché di più è insostenibile. Un sacrificio della percezione di fronte all’inaudibile che non può vedere.
Forse non a caso pensare, che viene da un verbo del latino tardo – pendere, pesare -, richiama il farsi carico.
Quando ascoltiamo le storie nella stanza d’analisi c’è sempre sullo sfondo la questione di quanta realtà ci si può fare carico senza incorrere nella catastrofe, per non rinnovare la traumaticità, perché un aumento di consapevolezza, la ritrascrizione di una verità più profonda della propria esperienza, porta inevitabilmente con sé la qualità di un colpo. Perché tocca frangere l’esistente per oltrepassarlo, e ogni conquista porta con sé una perdita.
Come l’analisi, anche la scrittura, ha il compito di dare ospitalità a ciò che è erratico, selvaggio, penoso, terrifico, a realtà che spesso non dispongono di un linguaggio perché non legittimate dai costrutti sociali.
Un romanzo non è un caso clinico, lo ascoltiamo parlarci, non ci chiede di interpretarlo, e la dedica alla madre o la valenza delle citazioni di Bernhard che si trovano in esergo, sono faccenda privata dell’Autrice; ma è indubbio che in questo libro risuoni una necessità che lo rende incredibilmente intenso e ficcante.
È una storia che strappa ogni alone sacrale alla mitologia dell’istinto materno, calando il legame primario nel più complesso terreno delle relazioni affettive, con le sue naturali ambivalenze, potenzialità e limiti, mostrando la fatica di essere madri infelici di esserlo, incapaci di sentircisi in modo naturale e amorevole.
Un racconto toccante e spietato, che bracca il dentro e costringe alla fatica del pensiero, che scava le comode sicurezze sul bene e sul male nel rovesciarsi di innocenza e colpa, e fa risuonare un caleidoscopio di associazioni.
Su incontri infelici fra madri e figlie, arsure sorde di solitudini. Relazioni dove non ci si può riconoscere perché si vede attraverso quel che si vorrebbe invece che guardare quel che è; o perché si è ancora troppo indivise, e ogni afflato a un’autonomia di pensiero o volontà è annullato.
O su esistenze ritirate in funzionamenti minimali per sopprimere qualsiasi desiderio, animazioni sospese che mirano all’immutabilità e all’autarchia, dove l’incontro con l’altro è fonte di angosce inaudite di intrusione e rapina, lo spettro di una passivizzazione in assenza di oggetti affidabili, dove l’odio non cessa di essere l’unico modo di percepire l’alterità, e si reagisce al contatto con furia espulsiva perché è fondamentale preservarsi da ogni consapevolezza di bisogno o dipendenza. Storie di creature che a volte intuiscono penosamente la propria incapacità di amare, il deserto cui manca il limo che dia un senso vero e profondo al vivere.
Quando arriva da Isabel, Elena scopre una verità che non si aspettava e che non vorrebbe ascoltare, che ha da dirle anche di lei e di ciò che il suo sguardo teneva fuori portata. In un certo qual modo si trova di fronte alla confrontazione che la figlia le aveva risparmiato, forse per proteggerla, forse per proteggere l’immagine di sé e impedire che tutto potesse diventare ancora più detestabile.
Incalzata dalla furia e dal dolore di Isabel, ciò che aveva provato a escludere fa dolorosamente ritorno, come il ricordo delle parole di Rita al medico durante la loro ultima visita: non credo proprio che potrei essere la madre che lei pretende che io sia…
Il giorno in cui avviene la vera rivelazione, siamo soli, faccia a faccia con noi stessi, e in questo giorno non c’è menzogna che tenga.
La Piñeiro costruisce uno scenario etico e drammatico veramente egregio, dove il male fatto e subìto si rovesciano l’uno nell’altro per tutte le figure in scena.
C’è un’urgenza violenta nel corpo a corpo delle due protagoniste, sullo sfondo dei corpi assenti delle figlie, anche loro portatrici della medesima ferita, quella dei non visti.
La verità di cui Isabel si libera (e che Rita ha lasciato in silenziosa eredità nei sospesi) è una realtà brutale di disaiuto, questo il pharmakon – nel suo ambiguo significato di medicina e veleno – che Isabel vuole fare assumere a forza a Elena, abbattendo le sue difese. Viene in mente l’uso spietato dell’oggetto di winnicottiana memoria. C’è in quel dialogo un bisogno inevaso e irriducibile che l’oggetto abdichi a sé e riconosca soltanto il bisogno altrui, esca dalla cecità di ciò che pensa di sapere, per aprirsi a comprendere quel che fa mancare. E soprattutto ripari a quella mancanza.
A volte è più facile gridare che piangere…
L’Autrice mostra di sapere molto bene che per una vera integrazione, per colmare la distanza fra sapere e consapevolezza, si deve passare per una strada molto più lunga e articolata dell’attacco alle difese.
Nello scambio fra le due madri c’è un curioso darsi il turno fra affondi e attese trattenute, fra l’irruenza delle spinte e la cedevolezza dei rispettivi sconcerti. E c’è un gatto che viene a interporsi fra loro, una creatura che cerca carezze, carezze che né Elena né Isabel hanno mai saputo dare.
Sembra uno spazio nel mezzo, dove potersi incontrare.
Ogni rumore della vita proviene da Eros, diceva Freud.
Cosa farà adesso? le chiede la donna ed Elena vorrebbe rispondere, vorrebbe dire, aspetterò ancora un po’ per potermi rimettere in cammino, ma sono tante le parole che affiorano contemporaneamente, si mescolano, sbattono una contro l’altra, e finiscono per smarrirsi o muoiono prima che Elena possa pronunciarle, allora non dice, non risponde, accarezza soltanto il gatto. Questo è tutto per oggi, accarezzare un gatto. Forse domani, quando riaprirà gli occhi e prenderà la prima pastiglia della giornata. O quando prenderà la seconda. Forse.
Questo libro è sicuramente un esercizio d’ascolto ostico, struggente, importante come lo sono sempre le buone opportunità di pensiero. In storie come questa si fa luminoso il filo che unisce la narrazione con il mestiere dell’analisi, che fa di entrambe – come dice Pontalis – un diritto d’asilo per tutto ciò che migra.
