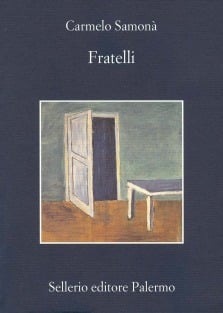
Parole chiave: Samonà, follia, famiglia, psicoanalisieletteratura
Fratelli
di Carmelo Samonà (Sellerio, 2008)
Recensione di Daniela Federici
Comprendere che sei qui. Comprendo.
Proprio come a tentoni un cieco comprende una cosa,
io sento la tua sorte e non so darle nome.
Rilke, Requiem per un’amica
Quando esce, nel 1978, questo romanzo breve diventa un caso editoriale. Carmelo Samonà, famoso ispanista e grande intellettuale, fa il suo esordio letterario a più di cinquant’anni e mette la sua vasta cultura umanistica a servizio di una storia intensa e toccante.
Sono gli anni della riforma Basaglia che chiude i manicomi, e pur dichiarando di non avere nessun intento ideologico, Samonà plasma una straordinaria rappresentazione del punto di vista della gestione familiare della malattia. Il tema del disagio psichico impregnerà la sua produzione letteraria e – che si tratti di finzione narrativa o auto fiction – l’urgenza della raffigurazione è percepibile nella ricerca che anima il protagonista di Fratelli. La sua precisa e sfaccettata esplorazione intima infonde spessore a scenari polisemici, che hanno dato vita, negli anni, a svariate letture interpretative, decretandola un’opera irrinunciabile nel panorama della letteratura sulla follia. Dopo più di quarant’anni, l’intento è di far conoscere anche alle nuove generazioni un folgorante racconto di un legame affettivo e del corpo a corpo con il disagio psichico, una scrittura che ha miniato con un’intelligenza letteraria rara l’esplorazione dell’incontro con la sofferenza fino alle dimensioni di ciò che siamo soliti definire controtransfert.
Vivo, ormai sono anni, in un vecchio appartamento nel cuore della città, con un fratello ammalato.
La malattia rappresenta, nel nostro peregrinare, l’incognita permanente: una specie di oggetto invisibile prima ancora che una forza ostile. … impalpabile e lenta, percorre di soppiatto ogni luogo senza lasciar prevedere dove, esattamente, né in quale momento, sorprenderà i nostri passi imbrogliandoli o modificandone il corso.
Due figure senza nome, recluse in un tempo sospeso. Il fratello ‘sano’, la voce narrante, è come un portolano che cerca di mappare un territorio sconosciuto, di comprendere i significanti di una lingua straniera. È l’ordine che ascolta su di sé l’impatto della follia e ne ricerca una trama che addomestichi il senso, mentre tratteggia una mirabile descrizione del linguaggio della sofferenza.
…in quello che dice non c’è, volta per volta, nulla di inconcludente: ogni frase è compiuta e carica di senso, ogni parola sospinta da un’incoercibile determinazione interiore. Si direbbero lucidi frammenti di un discorso che ha perduto la sua compattezza in seguito a una lontana, terrificante esplosione; nel moto centrifugo i nessi si sono spezzati, i sensi rovesciati e stravolti, ma schegge luminose di quell’antico tesoro linguistico emergono ancora alle labbra, volteggiando nell’aria, sfiorate quasi sempre da un’impalpabile grazia. Non so spiegarmi come possano accomunarsi con tanta disinvoltura difficoltà e grazia. L’uso della parola è, in mio fratello, simile al movimento del corpo: un insieme di ritmi affannosi e lievi. Il fraseggio è come il gesto delle mani o il modo di camminare: lento, tortuoso, qualche volta azzoppato o sbilenco, costretto a trascinarsi dietro zavorre umilianti di impacci e balbettamenti, ma anche alato, senza peso né tempo, capace di librarsi nell’aria in rapidi fiotti; sempre, nello stesso momento, sofferente (e di una sofferenza materiale, corporea) e astratto. Non ho mai conosciuto linguaggio in cui abbiano tanta parte i silenzi…
Con una prosa elegante, densa ed essenziale, Samonà ci regala un edificio narrativo capace di dar voce ai riverberi inquietanti e claustrofobici della coabitazione con la follia, all’assillo di un velo da squarciare, ai pensieri di diserzione e alle folate d’odio, alla visione limpida di un’umanità che si sporge all’incontro con il mistero.
La seguo da vicino come se avesse una forma, la spio, ne annoto con cura i sintomi e li metto in relazione fra loro. Ho un tale accanimento nel darle la caccia, perseguirla e snidarla, che a volte può sembrare anche che io la corteggi. Ma bisogna calcolare gli effetti di una convivenza coatta. Come in tutte le lunghe contese, non c’è da meravigliarsi se il mio modo di lottare si è fatto, col tempo, complicato e contradditorio, e se qualche volta rassomiglia a una trattativa molto più che a una guerra. Ho imparato che bisogna fingere di accettare la malattia come qualcosa che ci integra e ci appartiene, alla stregua di un prolungamento insano… questa familiarità, assicurandomi una conoscenza più intima e agguerrita del mio antagonista, mi mette in una situazione di vantaggio…
Nei labirinti di una casa sconfinata dove vivono soli, vanno in scena i ‘viaggi’, spazi percorribili di fantasie, un gioco-teatro con cui il narratore punta a distogliere il fratello dalle sue fughe, richiamandolo a una realtà condivisa, alla creazione di chimere comunicative.
Seguivo, arrancando, le infinite varianti di senso che mio fratello ricuciva e scuciva…
Fiabe, romanzi, pezzi di melodramma furono scomposti, rivoltati, ridotti a poltiglie narrative che serbavano, dei testi originali, solo impercettibili tracce. Pensai che fosse un modo della malattia per insorgere all’interno del gioco e rivalersi di quel tanto che l’avevamo imbrigliata; osai l’espediente della finta complicità; simulai di partecipare al massacro dei testi per dimostrargli che non aveva alcun senso. Ma intanto la dissoluzione di volta in volta cresceva e le varie storie, come giocattoli aggrediti e smembrati nei meccanismi più ovvi, a un certo punto non servivano più…
Quella di Samonà è una scrittura di rara profondità e finezza nel dare forma all’esperienza dell’estraneità, all’infinita lotta della volontà di conoscenza sulla soglia dell’irredimibile opacità dell’altro così come della propria interiorità più enigmatica.
Non dimenticherò mai quella premonizione di assenza che già sfiorava il suo essere là, né quell’avvisaglia di congedo dello sguardo che ancora mi stava fissando. E certo era così: in quel momento compresi che la brevità del successo conteneva il germe di un’elaborata disfatta. Strappargli una sola battuta intonata alle mie poteva essere più dannoso che rinunciare completamente a istruirlo: la sua incapacità di adeguarsi poteva apparire, subito dopo, tanto più forte e incolmabile, il suo impaccio rivelarsi tanto più crudamente quanto più mi ero illuso di averlo avuto in pugno per un istante. In nessun altro momento ho pensato con così intima convinzione, guardandolo allontanarsi: ‘Non sarai mai come me’.
Ma se da una parte si irrobustiscono i confini per difendersi dall’irruzione dell’alterità, dall’altra l’intensità tumultuosa della compartecipazione si gioca al limite della confusione delle identità.
La nostra storia è tutta in queste violazioni di territorio che si susseguono da una parte e dall’altra sino a confondere i nomi e i volti dei rispettivi invasori.
Il naufragio della possibilità di chiare traiettorie di significato di fronte alla domanda muta della malattia, la manipolazione del tempo negli universi aleatori di quelle dimore volanti, smarrisce la ragione anche in chi prova a prendersi cura.
Ho le idee sempre più confuse sul cielo e sul sottosuolo, perdo completamente il controllo dei miei atti e il timone dei miei desideri, e mi sembra di entrare in balìa di curiose assenze: deliqui limacciosi e perversi, che non hanno nulla di concretamente motorio e non rassomigliano né a un turbamento né a un incubo, ma piuttosto al sollievo temerario del galleggiare su acque calme e lente, in cui persino l’eventuale sprofondamento non sarebbe letale… Questi scambi veloci fra vero e falso, questo entrare e uscire dalle finzioni e dai viaggi senza un limite prevedibile, si son fatti così insistenti negli ultimi tempi che la mia salute ha cominciato a soffrirne.
Lo smarrimento di sé è in fondo una condizione inevitabile per avere accesso al nuovo, all’altro che ci abita e in cui ci riflettiamo.
Il deserto in cui si rischia di perdersi.
Chi dei due si è perduto?
Le atmosfere oniriche, la stagnante immobilità, la solitudine laboriosa in cui sono immersi i due fratelli è un commovente racconto intimo e relazionale, una partitura cristallina della sofferenza psichica.
“Cercami di nuovo, anche se mi hai trovato”. E mi fissa a lungo coi suoi occhi di cane perché pronunci la parola esatta che sembra aspettarsi da me. Io, che ignoro quella parola, lo guardo a mia volta con espressione interrogativa restando come lui, per qualche minuto, in attesa.
Quella dell’Autore è soprattutto la narrazione ispirata della sensorialità, dell’impronta del corpo come linguaggio di sguardi, silenzi, ritmi, suoni, gesti, contatti, in un’alternanza di furie e armonie, perdite e ritrovamenti.
È meravigliosa l’immagine della porta a vetri attraverso la quale il fratello si prefigura, sagoma immobile, il barlume anelante che batte tre leggeri colpi di nocche al vetro smerigliato. Una soglia, il profilarsi di una possibilità che può vanificarsi in un istante. Perché la percezione dell’identità del suo corpo coincide con un’assenza.
O la donna con il cane zoppo, figura dai contorni sognanti che rompe il loro isolamento, che ha il sapore della nostalgia di un materno che dona e contiene, prodigiosa raffigurazione del legamento necessario al venire a essere. Una presenza aleatoria che forse non a caso si sfoca da farne dubitare la realtà o l’essere solo un frammento delle visioni favoleggiate dal desiderio.
Ho motivo di credere che la donna non avesse, come le avevo io, due lingue diverse destinate alternativamente a mio fratello e a me, ma una sola; una sola, che era tuttavia ricca di equilibri cangianti, riposata e violenta, ariosa e silenziosa, intensamente gestuale, allusiva, esplicita, amabilmente ironica, raccolta, comprensiva, limpida, frammentaria, compatta, coinvolgente, materna; insomma, così mobile e onnivalente che fungeva da molte lingue, o almeno spiegava una potenza pari a quella delle nostre due lingue sommate; tanto che forse (se non mi ingannano brandelli di ricordi insistenti) riuscì a tessere strani fili, che mi erano ignoti prima, fra me e mio fratello: unendo lembi di frasi come pezzi combacianti di un vaso rotto; coprendo abissi di distanze con improvvise modulazioni di canto, spazi di silenzi con invenzioni mimiche al cui disegno ridevamo insieme; soffocando angosce in un vortice di grandi corse in avanti, dal cui scatto impetuoso io stesso, benché un poco ansimante, ero trascinato e ciecamente sedotto; e quando sembrava esaurita ogni scorta di segni figurati o vocali (inesauribili per lo più) ricorrendo infine all’abbraccio.
Quell’abbraccio, come desiderio di cosa remotamente posseduta, sembra la pelle psichica che può avvolgere la sofferenza febbrile e farne un guscio, ricomporre i fili, sciogliere la distanza e la solitudine.
Io e mio fratello riusciamo a vincere la paura che certe cose ci incutono e ad abitarle col pensiero, riconoscendo noi stessi fra cento altri, solo a patto che vi sia lei, dentro i ricordi, che ci aiuta a ricostruirle. Quando è lei che ci fa strada e ci da coraggio, può succedere anche che la presenza dei cento altri risulti attraente, e perfino rasserenante.
Fratelli è un testo che esprime egregiamente la natura conoscitiva della letteratura. La fine tessitura dell’Autore sulle profondità dell’anima evidenzia l’importanza dell’elaborazione per guadagnare la posizione riflessiva, il potersi contemplare da fuori che è garanzia di protezione della nostra mente.
Nella situazione in cui mi trovo, non conosco mezzo più idoneo a farmi prendere le distanze dagli avvenimenti che incalzano, dalla persona e dagli oggetti che mi circondano, e perciò a consentirmi di misurarli e di contemplarli da fuori. Non so immaginare territorio più mio, zona di cui vantare con più diritto il possesso esclusivo.
La scrittura edifica intorno a me universi possibili, proposte alternative alla realtà che temo e in cui sono costretto.
Scrittura che, come il comprendere, è strumento di esplorazione che getta ponti e rinsalda confini sulla materia incandescente e la sua dispersione, che prova a oltrepassare la stranierità perturbante della follia, per non restarvi di fronte muti o espellerla, lasciarsi invadere dai sensi di colpa o dal furor sanandi. Per non rassegnarsi all’impossibilità che quella soglia – fra ciò che accade realmente e la linea dell’eventuale, sui confini fra ragione e impotenza – guadagni una condizione di transizionalità, lo spazio psichico di un incontro e di nuove prospettive.
Vi sono momenti in cui mi sembra d’essere vicino a uno spiraglio di verità, di cogliere una trasparenza simile a un significato intero. Mi concentro, in questi casi, e arresto ogni movimento. Sono come sul punto di abbattere una cortina alla cui base mi sto scavando, a forza di unghie, un passaggio.
