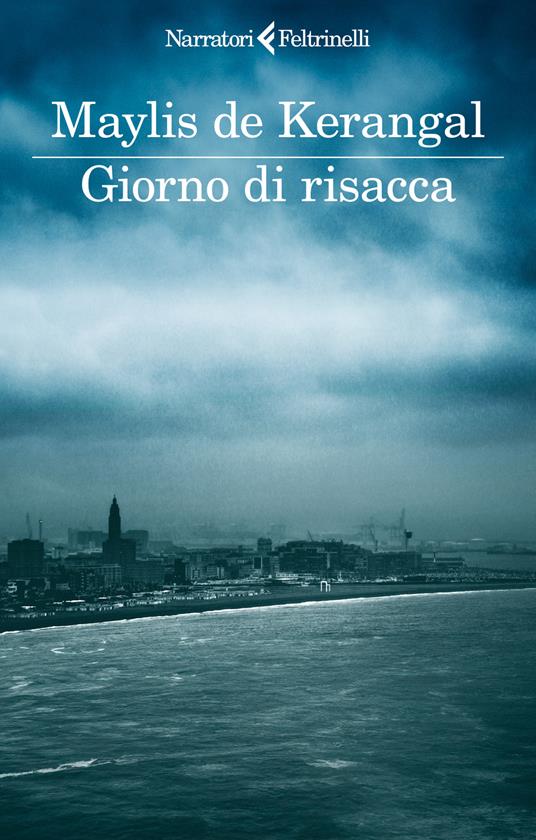
Parole chiave: trauma, guerra, memoria, tempo
Giorno di risacca
di Maylis De Kerangal (Feltrinelli, 2025)
Recensione di Daniela Federici
…il passato si è improvvisamente dilatato,
orco ghiotto di vita,
e il presente non è che una soglia ultrasottile,
una linea oltre la quale
non vi è più nulla di noto.
De Kerangal, Riparare i viventi
Una telefonata della polizia le intima di presentarsi al commissariato di Le Havre: a un corpo non identificato è stato trovato in tasca il suo numero di telefono.
Questa irruzione inaspettata disarticola il quotidiano della protagonista, una doppiatrice che fa da voce narrante del romanzo, che si sgomenta passando in rassegna chi, nel suo passato, possa essere morto a quel modo. È l’impatto brusco con la caducità e con l’onda dei ricordi di quella terra portuale che l’ha vista crescere e dove non torna ormai da molti anni.
Il passato non era una materia fossile, si evolveva nel tempo, morbido, plasmabile, si evolveva all’infinito, si ricaricava nel corso della vita, il passato rimaneva vivo…
La pluripremiata Autrice di Riparare i viventi mette di nuovo al centro un’effrazione traumatica, uno squillo di telefono che spezza la linea del tempo e trasfigura la realtà: un pezzo della sua vita, un pezzo bello grosso, ancora caldo, compatto, si stacca dal presente per colare a picco in un tempo passato, per crollarvi e scomparire (Riparare i viventi, Feltrinelli).
Anche in questo libro la sua inclinazione per le storie, quelle che mi racconto, quelle che racconto agli altri, quelle in cui mi moltiplico, dove posso nascondermi, ritornare una sconosciuta, smettere di essere io, risuonano di un impegno civile su questioni che ci riguardano tutti. La protagonista sembra infatti un alterego della scrittrice, personaggio senza un nome il cui ritorno a Le Havre si offre da sfondo gestazionale di un viaggio interiore. Le viene chiesto conto di uno sconosciuto ammazzato su una spiaggia, e lei viene investita da una risacca di risonanze che, ben al di là della trama, aprono riflessioni amare e profonde sul nostro tempo.
Pallide coincidenze, turbamenti dei sensi, associazioni fugaci e discutibili, quelle divagazioni si accostavano in me come catturate nelle maglie traslucide e strette di una rete di tulle… una rete di segni… forse un fantasma…
La città della sua infanzia, dov’è cresciuta come un’erba selvatica fino a raggiungere la sua forma adulta, dove l’apparizione del mare è un avvenimento scenografico, di un colore che meriterebbe che un nome fosse creato apposta come quel grigio del cemento armato in cui si rifrange, suona come un simbolo.
La protagonista ricorda l’intervista che, da liceale, fece a un’anziana sopravvissuta ai bombardamenti del settembre del ‘44, quando Le Havre, divenuta un’enclave strategica dove una guarnigione di undicimila tedeschi si erano asserragliati a controllo del porto, viene rasa al suolo dagli Alleati.
Gli attacchi aerei che durano per giorni finiranno per fare di Le Havre una cosa svuotata di ogni forma, una superficie la cui unica continuità è la distruzione, una crosta di macerie, e questo senza che si possa neanche decidere se si ha a che fare con delle vestigia, o se ci si trova di fronte a una materia nuova, una sostanza inedita creata dalla guerra, corpo più o meno compatto di tetti, di porte e di scale, di muri dalle finestre vuote, fusione di timpani e travi, di materassi e cavalli, di fotografie e macchine da cucire, magma di ceramiche, di carrozzine, di bici e pigiami, lava di transistor e di cani, poltiglia di autobus, di berretti e di striscioni, amalgama di cose umane con brandelli di carne umana, guazzabuglio di passati che, una volta compressi, alzerebbero il livello della città di quasi un metro – hanno detto che dopo un mese dai bombardamenti, i resti di Le Havre erano ancora caldi.
I civili che non erano evacuati si erano rintanati negli scantinati, angosciati di soffocare vivi, ore passate ad aspettare la deflagrazione successiva, un tempo aritmico, estraneo agli orologi umani…
… siamo risaliti in fila indiana, gli uni dietro gli altri, ci impedivamo di pensare a quello che ci attendeva là sopra, in superficie, eravamo coperti di calcinacci, i capelli, la pelle, i vestiti, pieni di cenere e polvere, eravamo dei fantasmi, abbiamo ignorato fino all’ultimo scalino che la scala della cantina era l’ultimo elemento di architettura ancora in piedi.. ci siamo trascinati fra le macerie, abbiamo girato intorno alle buche, ai crateri delle bombe dove l’acqua si era già infiltrata, scavalcato i pali crollati e le fogne scoppiate, le travi carbonizzate, facevamo attenzione a dove mettere i piedi perché il suolo stesso era scomparso, c’era fumo dappertutto e gli occhi pieni di polvere e le ciglia incollate, comunque non c’era più niente da vedere…
… la realtà fisica aveva un solo aspetto, sempre lo stesso, quello del caos, immaginavo quelli che avevano scalato le rovine per salire più su, stare qualche metro al di sopra delle macerie per orientarsi, per ritrovare l’impronta diafana degli antichi quartieri, per discernere il tracciato familiare in cui il giorno prima risuonavano ancora i rumori della strada, lo scalpiccio dei sandali, il rimbalzare dei palloni…
L’insituabile, una permanenza che continua a lavorare lo spazio incoraggiandoci a riconoscerlo quando tutto è andato in frantumi.
Le Havre è una città infestata dai fantasmi, dove il cementodi un paesaggio urbano ricostruito in tutta fretta dopo la guerra è la traccia materiale di ciò che è scomparso, dove gli strati storici sono invisibili, spianati sotto, in profondità. Ricostruzioni e rimozioni collettive.Le Havre diviene luogo simbolo della brutalità improvvisa di tutte le guerre, come una pellicola che salta nel proiettore cinematografico, una detonazione, tutto si ferma, taglio, tutto nero, black-out, e a partire da là la tua vita di prima ti sembra così lontana che ti chiedi se è davvero esistita, se l’hai vissuta o non era piuttosto un sogno, ma non hai il tempo di farti quelle domande, non hai il tempo di rimpiangerla, la tua vita, è un’accelerazione inaudita e sei presa in quel vortice, il tuo pensiero si paralizza, sei condizionata da riflessi meccanici, dalla paura che ti spinge a nasconderti, a fuggire o a lottare, un’emozione che pensavi di conoscere ma che non conosci.
L’incontro della protagonista con due giovani esuli ucraine dell’età della figlia, non è che una delle toccanti eco al nostro presente: è folle come ci si abitua, come si impara presto a vivere senza proiettarsi nel futuro, a respirare momento per momento. Un mondo precipitato, la propria terra che si spacca in fronti del conflitto che nel loro avanzare e ritrarsi scoprono i cadaveri come la bassa marea rivela i relitti dei naufragi.
Nessuna sofferenza è indescrivibile, cita da Dagerman, uomini e luoghi divenuti irriconoscibili, tutti cercano qualcuno, uno scomparso che forse è morto, o forse vaga da qualche parte in un campo, non si sa niente ed è questo che fa impazzire… quell’errare tra figure sfigurate e quei miserabili traffici, quella disperazione, quei frammenti di conversazione con esseri annichiliti in seminterrati mezzi demoliti, esseri che tuttavia chiedono allo straniero di confermare che la loro città è davvero la più distrutta…
Le guerre del nostro presente sono naufragi ripresi da droni capaci di filmare rasente i sassi, in fondo ai crateri, e le cui immagini scorrono in loop sui canali d’informazione.
… mi credevo capace di sopportare quello che mostravano, senza veramente temere il loro impatto, l’impronta visiva che quelle immagini rischiavano di sedimentare in me – le mie iridi sono da tempo abituate allo spettacolo della violenza che la rete mondiale delle immagini trasporta in tempo reale sui miei schermi, nella mia borsa, sotto il mio cuscino… aggiusto lo sguardo… lo so fare senza battere ciglio…
Immagini cui ormai siamo assuefatti.
La protagonista richiama la teoria dei sei gradi di separazione, a ribadire come siamo tutti inseriti in una rete di connettori che intrecciano tutti i paesaggi del globo, al di là dell’arbitrarietà della nascita e delle classi sociali, delle caste e dei ghetti, saremmo i punti di contatto di una disseminazione vertiginosa in cui ciascuno di noi è legato a tutti.
Un giorno di risacca è un periplo di richiami e risonanze in quel tornare sui propri passi per mettere a fuoco la realtà e cercarvi una formulazione più profonda, stratificare significati e creare nuove possibilità: una gravitazione interna, un punto di contatto tra la superficie del mondo reale e il suo sostrato romanzesco. Conosciamo la capacità del linguaggio di infondere vitalità alle configurazioni dell’immaginario, per favorire l’intimità con se stessi, rendere più familiare ciò che non lo è e soprattutto mantenere attiva la tensione del pensiero.
La protagonista è una doppiatrice, qualcuno che dà voce ad altri corpi, che fa posto all’altro in quel far coincidere le mie parole con le espressioni di un volto, ma anche con i gesti delle mani, gli impercettibili sollevamenti del busto, a volte fino a toccare il flusso interiore… identificandomi come con un’altra versione di me stessa.
La riflessione sulla crisi di questa professione per la facilità d’impiego delle voci prodotte dall’intelligenza artificiale, sembra configurare lo spettro di un umano afono delle sue sfumature e connessioni creative vive, perché solo i sentimenti sono affidabili per orientarsi.
È una storia che suona come un monito all’ignavia, al rischio di una nostra perdita di umanità e di vocazione all’incontro e al riconoscimento dell’alterità che ci interroga, che definisce chi siamo e ci apre alle possibilità trasformative.
