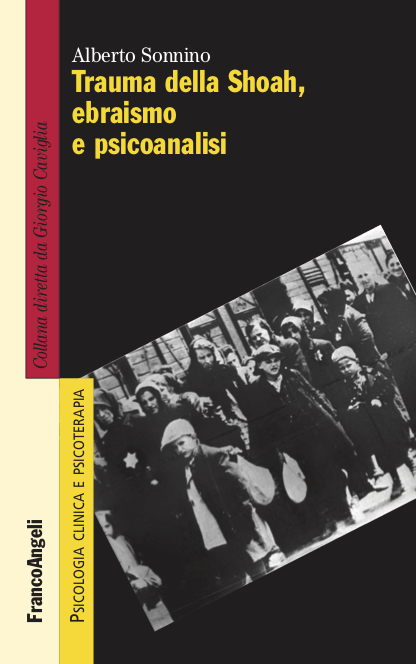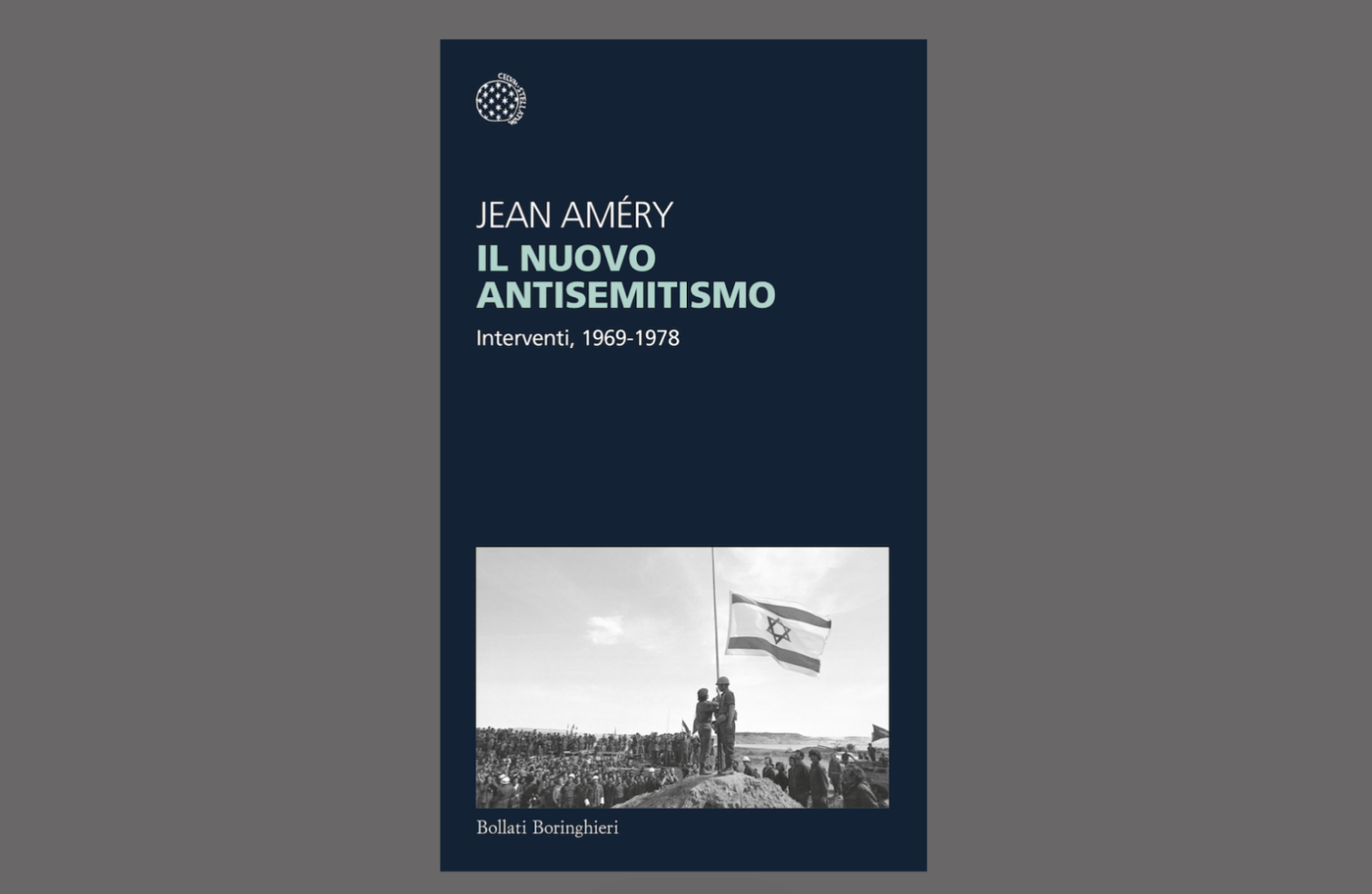
Parole chiave: esistenza, ebraicità, esperienza, democrazia
Il nuovo antisemitismo
Interventi 1969-1978
Jean Améry, Bollati Boringhieri 2025
Recensione di Roberta Guarnieri
Solitudine e coraggio di un ebreo.
Scrivere, anche solo una recensione, su un Autore di tale importanza e farlo in un momento così tragico credo che richieda una attitudine alla lettura, in questo caso degli interventi di Jean Améry sul ‘nuovo antisemitismo’, ancora più attenta e profonda di quella che avremmo potuto fare in altre condizioni. Nella sua densa prefazione, Irene Heidelbergerer-Leonard scrive: “L’attualità dei testi presentati in questo volume è davvero sorprendente: questi saggi elaborati da Améry tra il 1969 e il 1976 danno l’impressione di essere scritti per la realtà di oggi” (J. Améry, Il nuovo antisemitismo. Prefazione, p. 8)
Améry (anagramma di Hans Mayer) ha scritto libri che hanno segnato il dibattito e la cultura del dopoguerra e che sono diventati letture necessarie, direi obbligatorie; il suo nome resta indissolubilmente legato in particolare a Intellettuale ad Auschwitz (Bollati Boringhieri, 1987).
Il 1987 fu l’anno della morte di Primo Levi, mentre Améry si suicidò nel 1978, anno in cui uscì in Italia il suo libro appena citato. Date importanti di cui tener conto.
Le mie letture e riletture di questa serie di saggi di Améry mi avrebbero portato a scrivere una non-recensione: le frasi e i passaggi che via via selezionavo erano così tanti da sovrapporsi, quasi, al libro stesso.
Non posso perciò che sollecitare la lettura di tutti e sette i saggi presenti. Il libro, scritto in tedesco (Der neue Antisemitismus) è uscito nel 2024 per l’editore Klett Cotta di Stoccarda. È grazie alla densa Prefazione della Heidelberger-Leonard che il lettore italiano potrà trovare i nessi con i dibattiti e le forti tensioni di quegli anni e di quelli immediatamente seguenti (viene ricordata la disputa tra storici tedeschi del 1987).
Il susseguirsi dei saggi – l’ultimo è del 1977, e cioè poco prima del suicidio di Améry avvenuto a Salisburgo – può tracciare una sorta di lavoro autobiografico, nato dalla necessità di trovare la strada per uscire dalla condizione che il suo essere ebreo fosse determinata dallo sguardo degli altri. La figura di J.- P. Sartre compare come la sola che, in quegli anni e in quelle condizioni politico-culturali, gli fu accanto, all’interno di quel mondo intellettuale a cui Améry, comunque esule, apparteneva.
Mentre leggo e scrivo continuo a domandarmi in che modo possano essere intese e comprese le questioni che Améry solleva, in particolare nel primo saggio “La mia ebraicità” (1978): ebraicità, ebraismo, essere ebrei, destino ebraico…. Come vengono intese queste parole da chi, non essendo ebreo o non essendosi trovato a doversi porre la questione “chi è un ebreo”, o, avendola, per i più diversi motivi evitata, si trova ora, da lettore, faccia a faccia con la figura di questo scrittore, sopravvissuto alla Shoah, laico, appartenente politicamente e culturalmente alla sinistra?
Perché è proprio al mondo politico e culturale della sinistra, quello che per lui è sempre stato il suo mondo, che Améry si rivolge.
Vorrei in ogni caso aggiungere che, come psicoanalisti, le questioni relative all’“essere ebreo” ci riguardano in modo imprescindibile, perché la psicoanalisi ha collocato, storicamente ed anche concettualmente, all’interno della nostra cultura, di cui essa è parte essenziale, la questione dell’“essere ebreo”: l’essere ebreo di Freud naturalmente, il suo legame e la sua appartenenza con il popolo ebraico così come il suo interrogarsi su ciò, ma anche le condizioni iniziali in cui essa si è sviluppata, prima dell’ascesa del nazismo e della vittoria del Terzo Reich e della conseguente fuga degli analisti da Austria e Germania, che fossero ebrei o oppositori del regime.
Améry era “considerato ebreo”, secondo la formula della burocrazia del Terzo Reich: il padre e il nonno, che gli regalò un naso ebraico di cui andava molto fiero, erano ebrei assimilati e la madre era cattolica (si può supporre fosse lontanamente una marrana) e il Vorarlberg era un luogo profondamente cattolico; egli fu cresciuto nella cultura religiosa cattolica e scoprì la sua “ebraicità” solo in età adulta.
Proprio in ragione della sua non ebraicità, divenuto oggetto di studio di sé stesso, arrivò a utilizzare una formulazione Judensein, “essere un ebreo”: furono le leggi di Norimberga del 1935 a costringerlo, definitivamente, ad “essere un ebreo”. “Allora la mia ebraicità mi divenne chiara” (p. 30). E da allora egli comprese di far parte della Schicksalsgemeinschaft, la “comunità voluta dal destino”: gli ebrei, definiti dagli altri come ebrei, erano uniti nel loro destino.
Afferma Améry: “Non erano soltanto i nazisti a rendermi ebreo. Era il mondo a volermi tale, e io ero pronto a fare quello che Sartre, più tardi, avrebbe designato con il termine assumer, (…). Mi imposi di provare un senso di solidarietà con ogni ebreo. Eravamo già rinchiusi in un ghetto che era molto simile a quello in cui oggi il mondo ha confinato il piccolo Stato di Israele” (ibid. p. 33).
“Per me Israele non è una promessa, non è una rivendicazione territoriale legittimata dalla Bibbia, non è una Terra Santa. È soltanto il luogo in cui si sono radunati i sopravvissuti, uno Stato in cui ogni abitante dovrà ancora, e per molto tempo, temere per la propria esistenza fisica… Essere solidale con Israele significa per me restare fedele ai compagni che sono morti” (ibid. p.37).
Il legame con Israele, lo Stato nato giuridicamente nel 1948, è per Améry un legame “esistenziale”: egli non vi ha mai vissuto, non vi vivrebbe, come scrive, non ne consce la lingua, è molto critico con la politica del governo del tempo (Begin era capo del governo all’epoca), “… la sua cultura – lo dico con un vero imbarazzo – mi è estranea, la sua religione non è la mia. Eppure, per me l’esistenza di questo Stato è più importante di qualsiasi altro” (Ibid. p. 43).
Due parole ricorrono in questi suoi interventi: “esperienza” e “esistenza”: l’esperienza del suo “essere ebreo”, un ebreo sopravvissuto alla Shoah, rimasto un esule per tutta la vita (a differenza di Primo Levi, a lui non fu dato di tornare a casa, non ebbe mai più “casa”) che ha continuato a scrivere anche in tedesco, e la posta in gioco esistenziale di ciò, in relazione con lo Stato di Israele. All’interno dello spazio di senso determinato da queste due parole, emerge il suo essere un uomo di sinistra, particolarmente legato a quella che all’epoca veniva chiamata la “nuova sinistra” e all’esistenza dell’antisemitismo.
Améry fu dunque testimone del risorgere dall’antisemitismo all’interno del mondo politico e culturale della “nuova sinistra”. Nell’intervento dal titolo “L’antisemitismo rispettabile” (Der ehrbare Antisemitismus, “Die Zeit”, 25 luglio 1969) egli affronta con coraggio e sofferenza questo tema.
Il vecchio antisemitismo, mai scomparso nelle sue forme, è ora affiancato da un altro fenomeno: “Dopo la guerra dei Sei giorni (1967 ), però, si sono affacciate sulla scena nuove raffigurazioni dell’ebreo, ed esse stanno gradualmente guadagnando terreno: è l’immagine dell’oppressore israeliano che, con il passo ferreo e ineluttabile delle legioni romane, calpesta la pacifica terra palestinese; l’anti-israelismo e l’antisionismo di oggi si trovano in assoluto accordo con l’antisemitismo di un tempo” (ibid. p. 40). “Ciò che però è indubbiamente nuovo è che questa forma di antisemitismo, che si atteggia ad anti-israelismo, si colloca a sinistra,” (ibid. p.40).
Dunque, ciò che è nuovo per Améry, riferendosi all’antisemitismo all’interno del mondo politico e culturale della sinistra, non è l’antisemitismo dei partiti comunisti del blocco sovietico, che rapidamente avevano recuperato il virulento antisemitismo slavo, ma: “… il fatto che la sinistra intellettuale non affiliata ad alcun partito politico si sia appropriata di questo immaginario” (ibid. p. 41). E continua: “ Un fatto è certo: l’antisemitismo, insito nell’anti-israelismo o nell’antisionismo come il temporale è contenuto nella nuvola, torna ad essere rispettabile” ( ibid. p.41).
Nel 1976 Améry scrive di nuovo un articolo sull’antisionismo della sinistra, nelle sue diverse declinazioni, partitiche e no: si può leggere, seguendo l’articolarsi del suo pensiero, delle sue domande, la volontà di andare, come dire, al cuore del problema. Non posso che rimandare alla lettura, attenta e onesta, cioè capace di capire che cosa Améry scrive e a chi si rivolge.
Ogni ebreo, per Améry, ha un legame di tipo esistenziale con lo Stato di Israele. Lo Stato di Israele è una comunità che ha insegnato agli ebrei a non lasciare che siano gli antisemiti a modellarne l’immagine” (ibid. p.74). E ciò vale in modo del tutto specifico per gli ebrei della diaspora.
Ogni attacco all’esistenza dello stato di Israele è, di fatto, antisemita: questo ci dice Améry. Il fatto che esistano ebrei antisionisti non modifica per nulla le sue convinzioni. La sua esperienza gli fa dire che, se si creassero le condizioni per cui questi ebrei si sentissero minacciati nei loro paesi ‘ospitanti’ e di cui sono cittadini, non ci penserebbero due volte a chiedere di poter emigrare in Israele.
Vorrei chiudere la presentazione di queto libro che ritengo una lettura indispensabile, con questa frase: “Quel che conta per tutti loro (gli ebrei) è la potenzialità di trovare un asilo: potrà facilmente capirlo chiunque abbia vagato per il mondo come un senza patria… “(ibid. p. 73). Un asilo “virtuale” diceva poche righe prima. Eppure, si coglie che Améry aveva chiaro nella sua mente che nell’antisemitismo, nelle diverse forme in cui esso è comparso ed è presente nel mondo – vi fosse un elemento del tutto irrazionale. Améry riteneva che il nuovo antisemitismo fosse più pericoloso dei residui del vecchio antisemitismo, perché esso si presenta con “… il suo pathos storico-morale” (ibid. p. 76).
Noi analisti sappiamo che anche Freud si confrontò con tale questione e fu proprio per rispondere ad essa che scrisse il suo ultimo grande testo, il suo testamento: L’uomo Mosè e la religione monoteistica. (S. Freud, 1934-1938)
Nell’ultimo suo contributo, scritto poco prima della sua morte, Améry, che sempre aveva parlato, riguardo al conflitto israelo-palestinese, di un diritto che si contrappone ad un altro diritto, che aveva sempre preso posizione pubblicamente contro i governanti di Israele di cui non condivideva le idee politiche, scrive:” Nel mio sistema di valori, la categoria astratta di “essere umano” si colloca più in alto del termine “ebreo”, pur avendo sperimentato concretamente l’orrore. Ed esorto ogni ebreo, se vuole essere umano, a unirsi a me nel condannare radicalmente la tortura come sistema. Dove inizia la barbarie, lì devono terminare anche gli impegni esistenziali. I comandamenti astratti della morale hanno, dovrebbero, devono avere la priorità su ogni considerazione esistenziale” (ibid. p. 108).
Concordo con convinzione ciò che la Heidelberger-Leonard afferma nella sua Prefazione: se la guerra dei Sei giorni prima e la guerra di Kippur poi furono per lui dei momenti dolorosi e proprio considerando che Israele era per Améry un “rifugio virtuale” e perciò la minaccia contro lo Stato era sentita anche come una minaccia sul piano personale, “E’ facile immaginare che la guerra tra Israele e la Palestina iniziata nel 2023 lo avrebbe addolorato ancora più profondamente”(Heidelberger-Leonard, Prefazione, p. 12). Non gli avrebbe però fatto abbandonare la convinzione che l’esistenza di Israele era ciò che aveva “…semplicemente insegnato di nuovo a tutti gli ebrei del mondo l’andatura eretta” (ibid. p. 74).
Allora, in quello che era il suo “oggi”, nel suo mondo politico e culturale, la “nuova sinistra”, le sue parole, forti, anche commoventi perché facevano parlare un corpo torturato, un “misero fagotto di carne”, certamente lo portarono alla disperazione ma non gli fecero mai perdere l’“andatura eretta”, quella che gli permetteva di dire senza mezzi termini che l’antisionismo era la nuova forma dell’antisemitismo… e che l’antisemitismo non era un problema degli ebrei ma del mondo intero.
E noi adesso, qui, nel nostro oggi, dopo il 7 Ottobre e la guerra di Gaza, di fronte e in parte anche dentro una tragedia che ha creato le condizioni per alimentare la più grande ondata di antisemitismo dopo la fine della Seconda guerra mondiale, noi dunque, siamo in grado di ascoltare e lasciarci penetrare dalle parole di questo testimone, sopravvissuto ai campi di sterminio, uomo di sinistra, di una sinistra legata all’eredità dell’Illuminismo e fondata sui principi democratici che come europei, come italiani, ci fondano? Siamo in grado di affrontare il lavoro interno, soggettivo prima che politico, per guardare con onestà quello che sta accadendo dentro di noi, davanti a noi e tra di noi?
È con onestà intellettuale, ascoltando le parole di Améry, un “classico dell’avvenire” come fu chiamato, che si dovrebbe guardare a quanto sta accadendo nel nostro mondo, democratico, progressista – e la psicoanalisi ne fa culturalmente pienamente parte – a proposito del 7 Ottobre e della guerra di Gaza: in Israele e anche all’interno del popolo palestinese, ci sono gruppi e persone che lottano duramente per la difesa della democrazia da un lato e per la sua instaurazione dall’altro. È su questo terreno, con questo riferimento, che noi, cittadini di paesi democratici, dovremmo, se lo vogliamo, prendere posizione e agire in sostegno di essa: accanto ai cittadini di Israele e con i palestinesi che lottano per la democrazia.