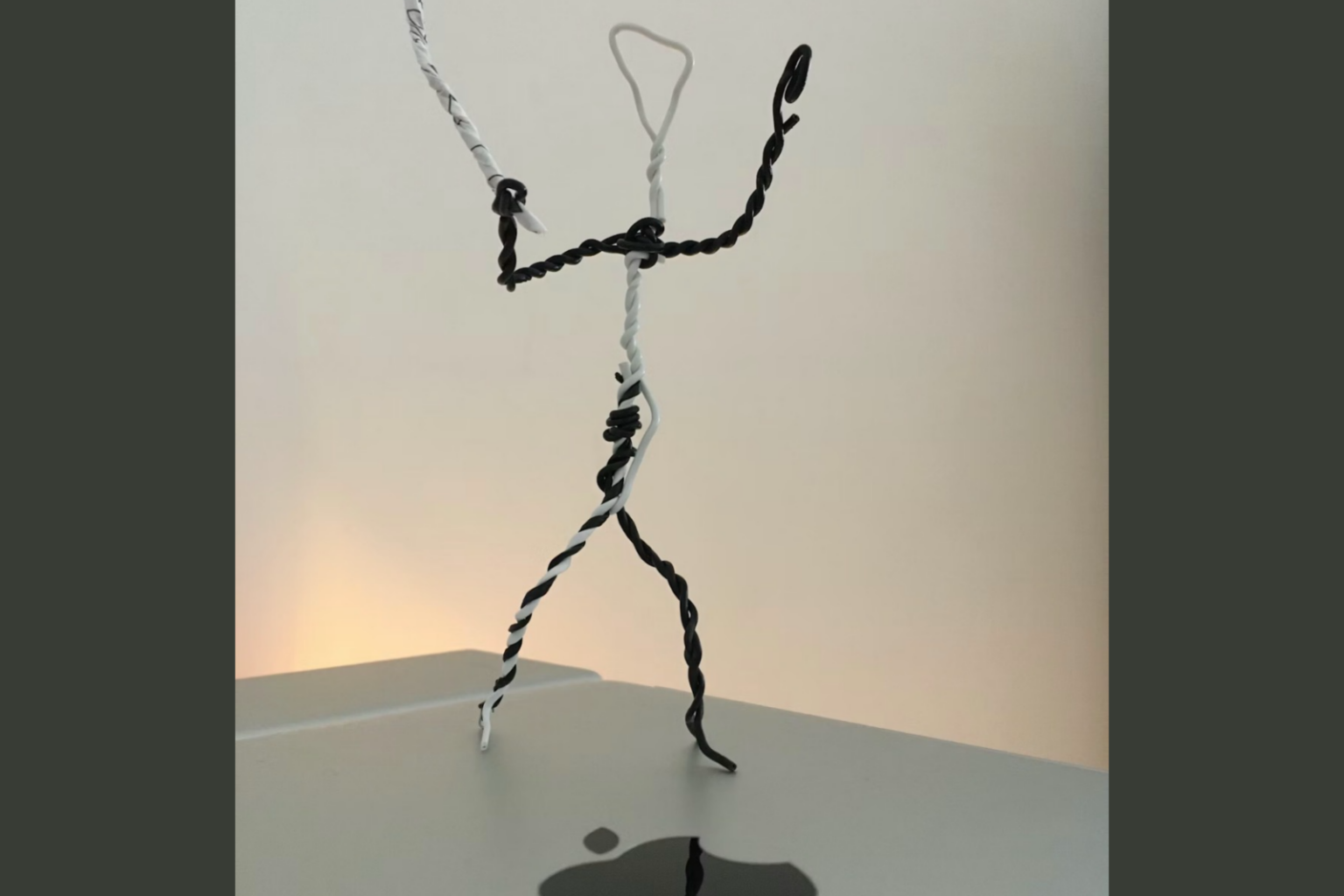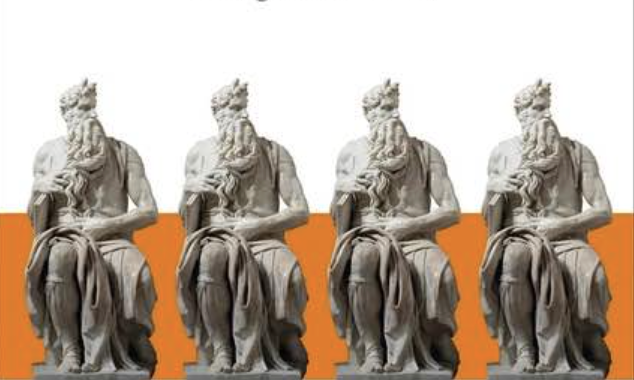
Parole chiave: Mosè, Michelangelo, Jung, Identificazioni
“Immagini che curano – La psicoanalisi visiva di Sigmund Freud” di Horst Bredekamp
Raffaello Cortina Editore 2025
Recensione di Pierluigi Moressa
Il testo, pubblicato nel 2023 a Basilea da Horst Bredekamp, storico dell’arte e docente a Berlino, esce in traduzione italiana e fa seguito ad altri studi nei quali l’autore lascia spazio agli interessi per la cosiddetta cultura visuale o scienza delle immagini, disciplina promossa da Aby Warburg; in essa, il valore delle iconografie appartenenti al passato si riattiva, divenendo fonte di interpretazioni e di intuizioni sul tempo trascorso e sulla creatività dell’artista.
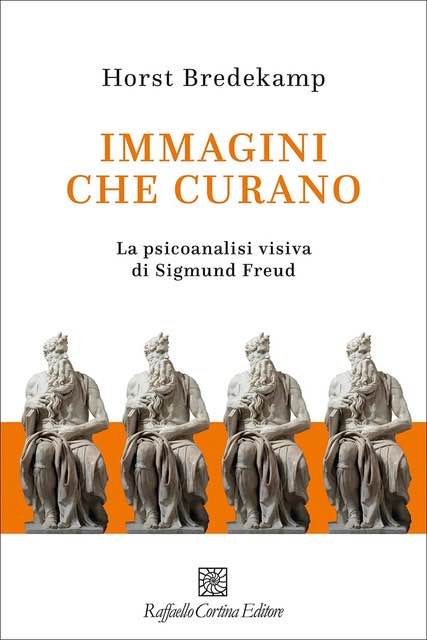
Sotto la lente dello studioso è posto il significato delle immagini entrate nella ricerca sviluppata da Sigmund Freud, che nutrì vera passione per il collezionismo di statuette e oggetti antichi e profuse indagini su opere d’arte di grande significato. Il saggio di Bredekamp, partendo dal testo freudiano dedicato al Mosé di Michelangelo, crea una connessione con la collezione di antichità che permise a Freud di ottenere “una mediazione mobile e varia” per giungere col paziente a “una ri-simbolizzazione continua di ciò che emergeva nel dialogo terapeutico e, al contempo, nell’inconscio dei due interlocutori che lo animavano” (Vercellone XIII). Attraverso questa mediazione (a lungo dissimulata dallo stesso Freud), venne a cadere l’idea del rigore “iconoclasta” espresso dalla psicoanalisi delle origini, intenta a dare valore esclusivo alla parola.
La storia del monumento sepolcrale di papa Giulio II (1443-1513), in realtà un cenotafio, fu lunga e controversa. Il progetto venne avviato da Michelangelo mentre il pontefice era ancora in vita poi fu abbandonato e ripreso sei volte fino alla versione finale eseguita nel 1545 non già per la basilica di San Pietro, come era negli intenti iniziali, ma per la chiesa romana di San Pietro in Vincoli. La tomba si presenta con la solennità prorompente tipica dell’opera michelangiolesca; le statue, collocate entro una scenografica architettura, hanno valore allegorico e paiono disposte a entrare in dialogo con lo spettatore. Il Mosè risulta il reale protagonista dell’intero apparato figurativo sia per la monumentalità sia per la posizione centrale che Antonio Canova (risistemando il monumento nel 1818) volle accentuare, elevandola e avanzandola rispetto al disegno originale. Più in alto è il papa, figura di dimensioni contenute rispetto alle altre, giacente sull’avello, a cui si finisce per riservare un’attenzione minore, come se il progetto iconografico di Michelangelo avesse inteso coagulare il senso di maestà e di gloria esclusivamente sulla figura del personaggio biblico, rappresentante ideale delle virtù del pontefice, noto per le imprese militari, che sul sepolcro perde l’aura temibile diffusa in vita.
Nel saggio “Il Mosè di Michelangelo” (1914), Freud scrisse: “nessun’altra scultura ha esercitato un effetto più forte su di me” (OSF 7, 301). Il confronto col capo del popolo di Israele risultò gravoso, in quanto lo stesso Freud annotava come fosse per lui difficile “tener testa allo sguardo corrucciato e sprezzante dell’eroe” (ibidem).
Il primo incontro di Freud col Mosè risale al 1901. L’interesse per il significato della scultura e per i dettagli scolpiti da Michelangelo si farà più definito nel corso degli anni fino a configurare una sempre più consapevole identificazione di Freud col ruolo del personaggio nella storia biblica. Determinante per la stesura del saggio fu l’attenzione rivolta alla mano destra di Mosè e alla posizione delle tavole della legge sotto il suo braccio. Freud, dopo una prolungata osservazione, sottolineò come dalla posizione del capo e dalle conseguenze del movimento connesso alle dita che stavano per sfilarsi dalla barba, si potessero cogliere i residui dei forti impulsi che animavano il personaggio, intento a trattenersi da una reazione istintiva e a proteggere le tavole di pietra. Coincideva lo studio del Mosè con le premesse della più dura fase di scissione entro il movimento psicoanalitico segnata dall’abbandono di Jung (1914). Il Mosè storico, travolto da passioni furenti di fronte al tradimento del popolo che aveva deciso di adorare il vitello d’oro, funse da stimolo identificativo per Freud, che in una lettera a Ferenczi (17 ottobre 1912) “suggerì che Jung sarebbe stato colpito dalla medesima furia con la quale Mosè aveva punito il proprio popolo” (Bredekamp, 28). Se Freud incarnava la figura di Mosè, a Jung doveva inizialmente spettare il ruolo di Giosuè, suo successore, ma la successione non si realizzò. La rabbia di Freud divenne l’ira controllata di Mosè; in questo, l’interlocutore marmoreo dello scienziato risultò una fonte ideale di confronto per il contenimento delle emozioni.
Vengono qui alla mente due stati in cui Freud fu, invece, travolto da un sovraccarico emozionale culminato nella perdita di coscienza (Rosenberg 1978). Entrambi gli svenimenti si verificarono alla presenza di Jung. Il primo avvenne a Brema il 29 agosto 1909, alla vigilia del viaggio negli Stati Uniti, e fece seguito alla descrizione molto accurata compiuta da Jung dei cadaveri rinvenuti nelle paludi e conservati entro le torbiere della Germania settentrionale. Pare che il riferimento insistito ai morti sollecitasse a Freud l’angoscia di essere sostituito dallo stesso Jung nella guida del movimento psicoanalitico. Il secondo svenimento accadde a Monaco di Baviera il 24 novembre 1912, tempo di contrasti particolarmente forti con Jung. Nell’occasione, il discorso cadde sul saggio appena pubblicato da Abraham su Amenhofi IV. L’eliminazione del culto di Amon, il dio della tradizione, e la sua sostituzione con Aton, annunciò la dichiarazione da parte del giovane faraone di non discendere dal proprio padre, ma direttamente dal dio. Furono la cancellazione di ogni segno del precedente culto dai monumenti e l’abolizione della memoria paterna a turbare Freud, che prese a lamentarsi con Jung per il fatto che nelle ultime pubblicazioni di argomento psicoanalitico edite in Svizzera fosse stato ignorato il suo nome. A quel punto Freud svenne e il suo mancamento fece pensare all’angoscia di morte e al timore di estinzione della sua opera.
Il collezionismo di Freud traeva fondamento da una radicata passione per gli oggetti originali e per la loro provenienza arcaica. L’intera collezione giunse ad annoverare due o tremila statuette. Bredekamp sviluppa l’ipotesi che la presenza degli oggetti di collezione entro lo studio, dove paziente e analista durante le sedute non incrociavano gli sguardi, fungesse da interregno: spazio per una osservazione comune che rinviava al “parallelismo … fra attività archeologica e indagine dell’inconscio” (102). Fondamentale per la serenità di Freud fu il trasferimento della sua intera collezione a Londra dopo la partenza da Vienna. Nella concentrazione sulle immagini, Freud superò anche il divieto iconico insito nella tradizione ebraica: “Tra i precetti della religione mosaica, se ne trova uno che è più importante di quanto non si riconosca a prima vista. È il divieto di fare immagini di Dio, l’imposizione di adorare un Dio che nessuno può vedere (OSF 11, 431). Per questo, l’ingresso nello studio di Freud, già fin dalla sala di consultazione, con la grande quantità di statuine, esprimeva il senso di un “luogo simbolico di libertà, la cui essenza consisteva nel dire no a tutte le paure, quella nei confronti dei metodi coercitivi del Super-io religioso così come qualsiasi norma che ostacolasse il comandamento dell’assoluta sincerità” (Bredekamp, 131). La connessione di Freud con la concretezza e col significato degli oggetti arcaici non si interruppe neppure con la morte: le sue ceneri furono accolte entro un vaso romano-apulo presente nello studio fin dai tempi di Vienna. Fu un ritorno alla collocazione funeraria di un manufatto dissepolto dal passato, estremo elemento tangibile dell’uomo e del suo pensiero.
Bibliografia
Abraham K. (1912). Amenhofi IV (Ekhnaton): contributi psicoanalitici alla comprensione della sua personalità e del culto monoteistico di Aton in Opere vol. 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1997.
Freud S. (1914), Il Mosè di Michelangelo. OSF 7.
Freud S. (1934-38). L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi. OSF 11.
Rosenberg S. (1978). Perché Freud è svenuto. Astrolabio, Roma, 1980.
Vercellone F. Introduzione a H. Bredekamp “Immagini che curano”. R. Cortina, 2025.