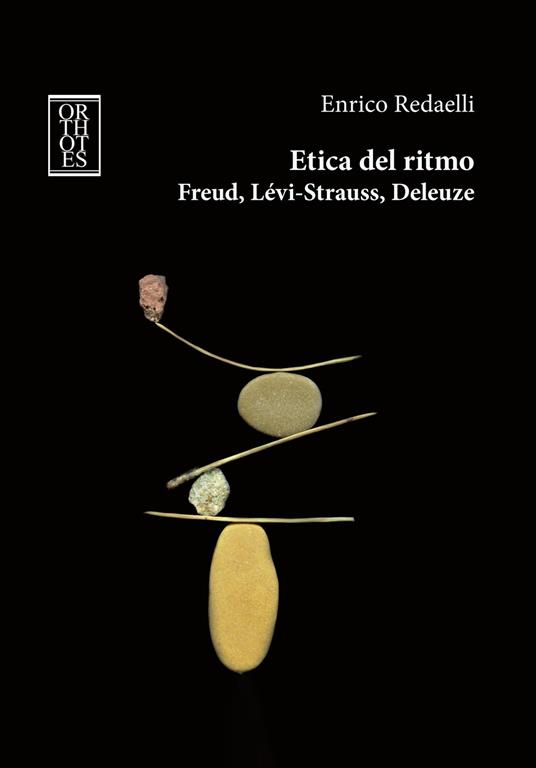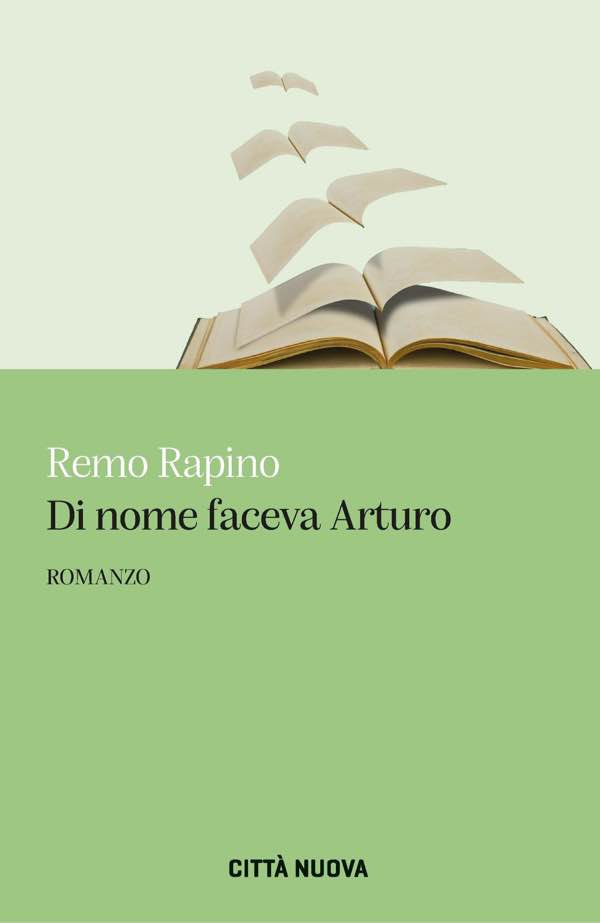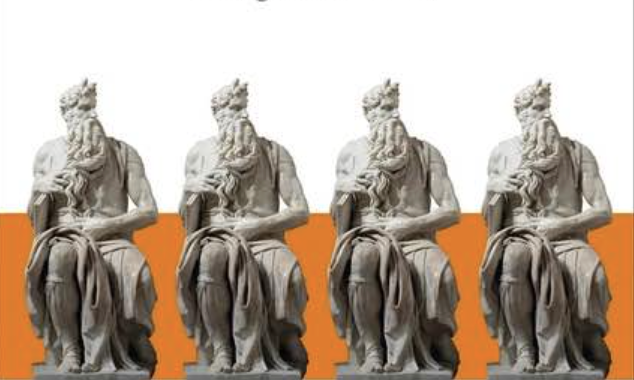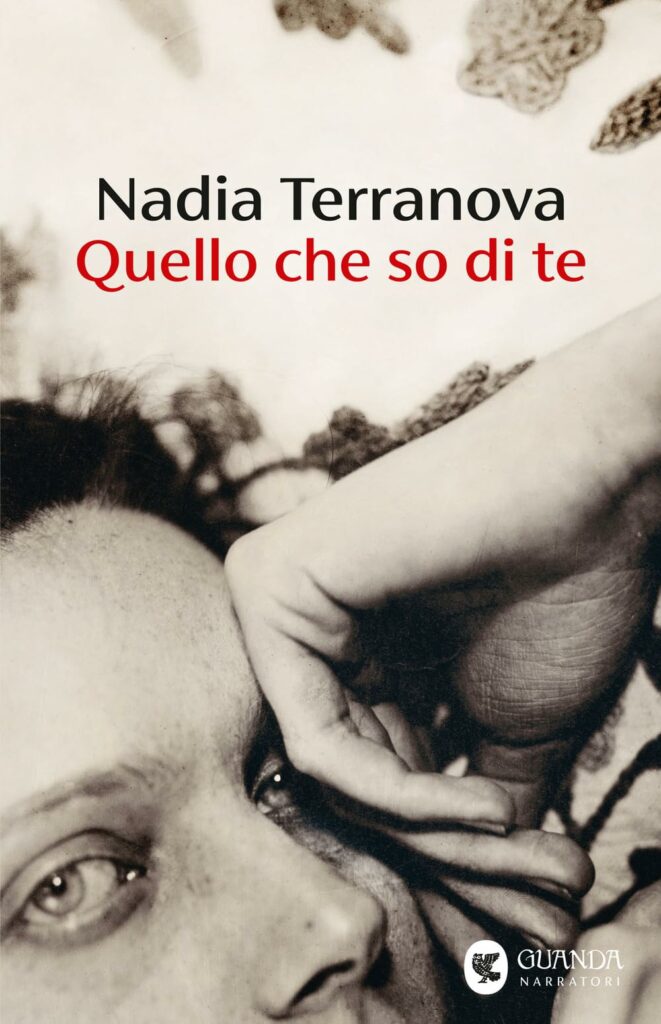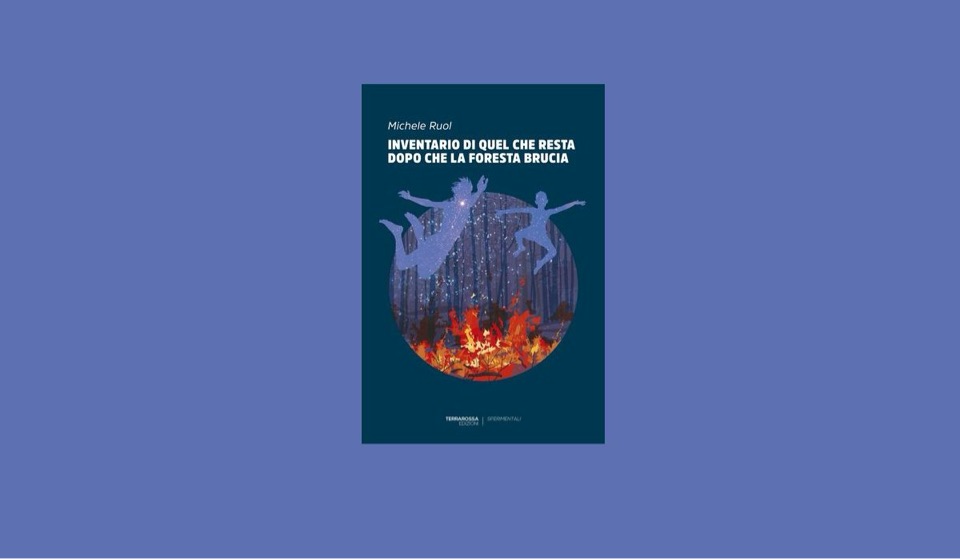
Parole chiave: Caso, Destino, Trauma, Lutto, Oggetti evocativi, Temporalità
Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia
Michele Ruol, 2025.
Edizioni Terrarossa, Sperimentali.
Autore Silvia Mondini
Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia è il primo romanzo di Michele Ruol, anestesista per professione e scrittore di teatro nelle ore notturne. Una doppia vocazione – cura e scrittura – che si avverte in ogni pagina di questo testo che non si legge: si attraversa.
Come si attraversa un trauma, senza sapere se si sopravvive davvero.
Un libro difficile, perché tocca quel che nessuno vuole guardare: l’improvvisa perdita di due figli. Un attimo che cancella il futuro di Maggiore e Minore, un avvenimento che determina un prima e un dopo nella vita di Madre e Padre. Apre il libro una nota che suona come un sogno al risveglio:
“Questa è un’opera di fantasia, ma è possibile che, nel corso della lettura, incontriate somiglianze o coincidenze con persone, luoghi, accadimenti reali. Per quanto ci sforziamo di inventare, tutto è già accaduto. E tutto accadrà ancora, in forme che non sappiamo prevedere. Possiamo solo immaginare nuovi modi per dire ciò che c’è. Considerate le risonanze come segni del caso o del destino, secondo la vostra teoria del tempo.”
Un avvertimento, forse una difesa. Ma chi legge, sa bene che ogni storia inventata è sempre, anche una storia vera. E poi, che differenza c’è tra caso e destino?
Il caso – scrive Freud (1901) – è ciò che accade nella realtà esterna al di fuori di ogni nostra intenzione. Il destino, invece, lo determiniamo attraverso ripetizioni, atti, scelte in apparenza libere da ogni nostra intenzione ma di fatto rispondono ad un copione interno, inconscio (Freud, 1920).
Dopo questo avvertimento, Ruol, non racconta una storia. Ne lascia affiorare i resti. Lo fa attraverso novantanove oggetti – quanti sono i capitoli del libro – che popolano la casa (parte prima) e l’auto (parte seconda).
Frammenti. Tracce. Impronte. Luoghi psichici da cui, lentamente, emergono oggetti a cui restituire parola e futuro. Ciascuno porta con sé ricordi, affetti, sensazioni, interrogativi strappati al silenzio che risuona tra le pagine bianche.
Capitoli brevi, a volte brevissimi, come certe sedute in cui basta una parola per far affiorare quel che lotta tra la spinta alla rimozione e il tornare ad essere. L’inventario si compone senza alcun ordine cronologico, fatta eccezione per i primi due oggetti, quelli che segnano il passaggio tra il prima e il dopo e il medium dell’ultimo litigio.
1.Cornice in argento, 15×22: “La foto dei ragazzi sul tavolino nell’ingresso è la stessa che avevano usato per la lapide […]” (p.12).
2.Telefono fisso, marca Sirio, color avorio: “Minore aveva telefonato per avvertire che non sarebbe tornato a pranzo. Lei (Madre, nota di chi scrive) gli aveva detto che non poteva chiamare all’ultimo quando ormai era tutto pronto, che faceva così ogni volta, che non gliene fregava niente di nessuno se non di sé stesso. […] Era stato il loro ultimo litigio” (p.13).
Seguono “resti” della vita di Madre, Padre, Maggiore e Minore: tutti insieme, separatamente, dopo la loro morte, prima della loro nascita, durante gli anni trascorsi insieme, nelle incursioni del Processo che scandisce i diciotto anni a venire.
È questo, forse, il punto più interessante se vogliamo sondare il tempo psichico di chi sopravvive al trauma: un tempo che non scorre, ma si addensa, si contorce, si frammenta. Un tempo dove il vissuto, il ricordato e il fantasticato si infrangono sull’impensabile, su quello che mai si sarebbe voluto accadesse.
Il tempo si rompe, l’Io si spezza, la scena si ripete, rimangono solo oggetti e soggetti slegati. Ma è proprio in questo “slegare” (Green,1992) che prende forma l’intreccio di Thanatos e Eros, quello che riscrive la storia in base a regole altre, non per linearità, ma per attrazione tra ciò che emerge. E così, pur senza una trama, la storia prende forma, la perdita diviene acutissima ma lascia pian piano spazio al lavoro di un lutto che avrebbe potuto essere impossibile.
“Ciò che viene perduto non è (solo) l’altro, l’oggetto, ma il nostro investimento su di esso. La perdita avviene dunque a livello dell’Io, del nostro Io, e per essere elaborata e trasformata in qualcosa altro ha bisogno che l’Io non sia sottoposto a una assoluta e radicale privazione dell’esperienza sensoriale. Ecco perché chi subisce la perdita di qualcuno ha bisogno della presenza dell’altro per poterla accettare.” (Fraire, p.23).
Ed è proprio questo rifiuto del processo secondario a rendere il libro psicoanalitico: l’autore affida al singolo il compito di ricostruire, di legare la storia al fine di lasciare spazio al fantasma, al dolore, all’illusione. È il singolo ad aggirarsi tra gli oggetti, a raccogliere i resti, a proiettare in essi la propria eco, a leggere nei dettagli la vita psichica dei personaggi e, forse, la propria.
Il libro sembra muoversi in quel luogo intermedio in cui psicoanalisi e teatro si incontrano. Il teatro – come l’analisi, come ogni creazione artistica – mette in scena ciò che preme sotto la superficie, dà corpo al non detto, spazio all’evocazione. In Ruol, gli oggetti non sono mai solo oggetti, sono personaggi muti, attori in attesa di trovare parola in una scena spoglia ma densissima. Qui non c’è sceneggiatura, solo inventario – slegato, sparpagliato, insensato – che sprigiona la potenza del dramma psichico. Non per ricostruire il passato, ma per rendere possibile, a partire dalle rovine, un atto di vita, un ritorno alla vita. Un dopo ritenuto, prima, impossibile.
In uno dei frammenti più incisivi del libro il pensiero si concentra su Madre, sulla sua genealogia interna. Un passaggio che contiene, condensato, uno dei nuclei più perturbanti della psiche: l’identificazione con l’oggetto primario.
“Senza volerlo si metteva a pensare a sua madre e al solido rapporto che negli anni aveva costruito: i doveri erano i mattoni, i sensi di colpa la malta che teneva insieme il tutto. Il dialogo tra loro si esauriva nelle comunicazioni utili al proseguimento della routine. Non c’era altro; tenerezza, affetto, intimità erano suppellettili da guardare con sospetto in casa d’altri. […] E lei, che errori avrebbe fatto? Gli stessi? Diversi? Più gravi? Sarebbe riuscita ad essere una madre migliore, o era tutto già scritto nella genetica?
Quando Madre vedeva le foto di sua mamma da ragazza rabbrividiva per quanto le assomigliava. Avrebbe ereditato anche la stessa capacità di rovinare tutto?” (Cesto di vimini, p.19-20).
La figura materna, così evocata durante la gravidanza di Maggiore, appare come elemento concreto, permeabile solo al dovere e al senso di colpa. Da questo vuoto d’intimità emerge come un fiume carsico la domanda che abita il cuore della perdita: il senso di colpa di Madre nei confronti del proprio stile educativo/affettivo.
Ed è nell’eco di questa domanda – Sarò come lei? Destinata a rovinare tutto? – che si introduce un primo spazio di separazione dal proprio destino. Forse, è solo nel momento in cui si osa interrogare la propria eredità che può schiudersi un varco per il futuro….
Ogni oggetto diviene così non solo resto del trauma, ma anche appiglio simbolico per un lavoro di separazione: una possibilità, dolorosissima ma vitale. Scrivere, essere scritti, essere pensati da un altro, diviene esperienza trasformativa. Anche per il lettore.
È in questo “spazio intermedio”, teorizzato da Winnicott e ripreso da Green, che il testo si colloca: una terra di nessuno sospesa tra realtà e fantasia, dentro e fuori, solitudine e presenza.
Qui, l’oggetto narrativo diviene ponte tra ciò che è perduto e ciò che può ancora essere pensato. Presente e assente insieme, in uno spazio dove ciascuno può sostare senza dover scegliere tra la realtà e la fantasia, tra la vita e la morte. E allora diventa spontaneo un collegamento tra questo luogo intermedio e la professione di Ruol – anestestista e rianimatore – abituato ad abitare il confine tra vita e morte, a trattare il dolore sino a sospenderlo, a far riaprire gli occhi. La sua scrittura, invece, riconosce il dolore, lo attraversa, gli dà voce e così facendo rianima, restituisce futuro a chi credeva di averlo smarrito. Un atto necessario e insieme coraggioso, come ogni ritorno alla vita dopo il trauma: fragile, imperfetto, ma irriducibilmente umano. Solo così si può tornare a esistere – non come prima, ma ancora – senza mai lasciare del tutto quel territorio intermedio in cui l’illusione convive con la realtà.
87. Occhiali a specchio: “In quella marea, i corpi di Madre e Padre scomparivano, si moltiplicavano, erano Maggiore, erano Minore, erano Madre e Padre appena ventenni, erano corpi celesti sparsi nella Via Lattea e raggruppati in costellazioni.
Alla fine del concerto Madre e Padre erano esausti, svuotati, grati al rito del concerto che in qualche modo era riuscito a metterli in comunione con quell’entità più grande che prende il nome di umanità e che, nel suo essere sconfinata, nel tempo e nello spazio, comprendeva anche Maggiore e Minore” (p.178).
Vivi, in comunione con l’umanità e al contempo soli. Ecco il vero paradosso del nostro essere umani.
“Ciò che è, e resta nell’ordine dell’incredibile per ognuno di noi – scrive Fraire (2008, p.18-19) – è lo scoprirsi vivi anche separati da qualcosa che di colpo diviene altro da noi stessi, una parte che è quasi “carne della nostra carne” e che si stacca per sempre da noi. Un aspetto inquietante della perdita è anche questo: fare esperienza del fatto che viviamo senza l’altro, da una parte è rassicurante, dall’altra è un incontro brutale con la nostra solitudine e la nostra singolarità.
Bibliografia
Fraire M., Rossanda R. (2008). (a cura di Melandri L.) La perdita. Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
Freud S. (1901). Psicopatologia della vita quotidiana. O.S.F, 4, Bollati Boringhieri, Torino.
Freud S. (1920). Al di là del principio di piacere. O.S.F., 9, Bollati Boringhieri, Torino.
Green A. (1992). Slegare. Borla, Roma.
silvia.mondini36@gmail.com
Centro Veneto di Psicoanalisi