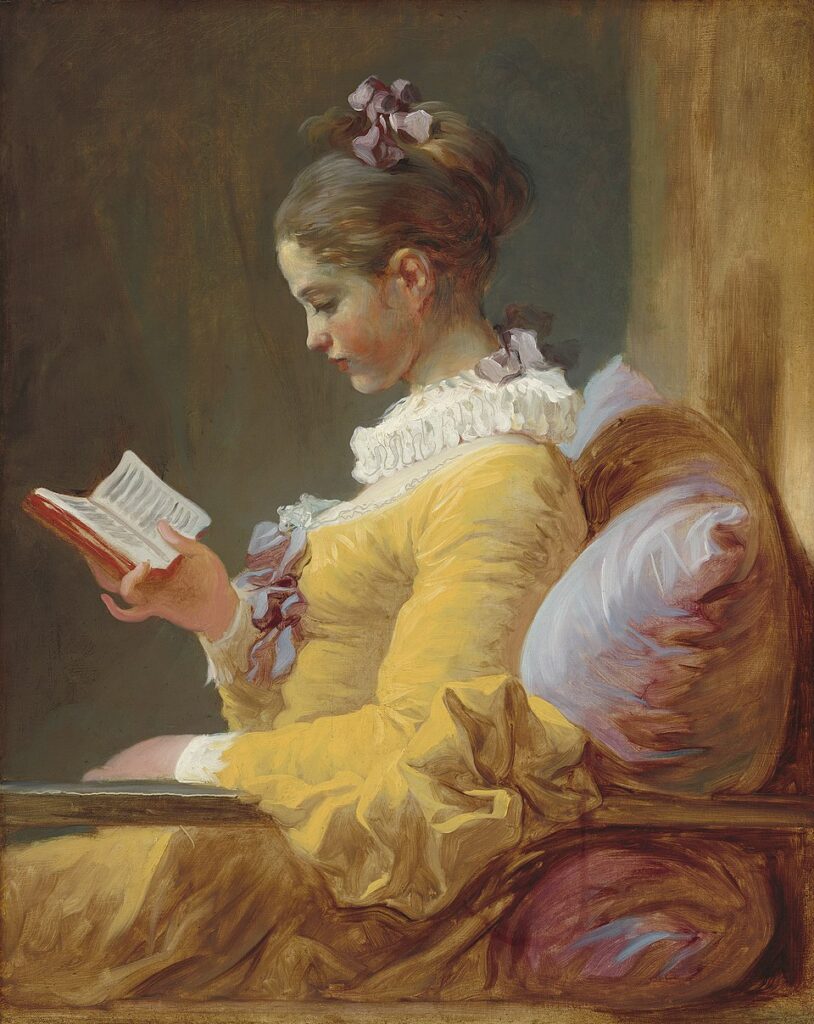
“La lettrice” Jean-Honoré Fragonard 1776
Nel solco tracciato da Libri allo specchio, dove la lettura si fa incontro con ciò che ci attraversa, Malde Vigneri rilegge la Vita di Galileo di Brecht da una prospettiva personale e feconda. Non si sofferma sull’abiura, né sulla cornice storica dell’opera, ma sposta lo sguardo sul dialogo iniziale tra Galileo e il giovane Andrea.
Invece di interrogare la sconfitta della ragione, mette a fuoco l’istante della sua nascita. Con una scrittura intensa e poetica, mostra come la conoscenza profonda, quella che resta dentro, si formi nel calore di una relazione significativa, come accade nel lavoro analitico.
Capace di intrecciare con naturalezza scienza, teatro e psicoanalisi, Malde compone un pensiero che sorprende per la sua forza evocativa e, illuminando senza spiegare, come un piccolo coup de théâtre, riporta lo sguardo là dove tutto comincia.
La Caporedattrice di SPIweb
Stefania Pandolfo
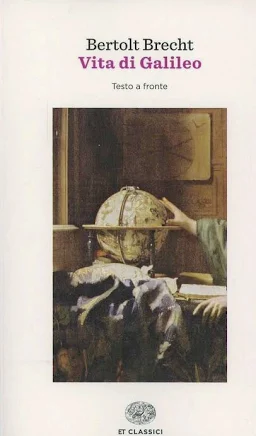
Libri allo specchio
Malde Vigneri
Quarto capitolo: Vita di Galileo di Bertolt Brecht
Ovvero: Le Coup de Theâtre
Parole chiave:
Ci sono momenti speciali e alquanto rari nel corso di un’analisi in cui all’improvviso un’associazione, un sogno, un particolare frammento di memoria, rivelano ciò che Anna Cordioli chiama l’inaudito[1]. Un momento epifanico in cui nella scena del teatro della mente, come il carissimo e indimenticato amico e collega Fausto Petrella ha scritto nel suo magnifico libro[2], un dettaglio inaspettato accende l’intuizione dell’analista consentendo la rivelazione di un evento traumatico determinante e rimosso. Un coup the theatre, direbbe Fausto. Fu così con la mia matura e sofferente paziente: un piccolissimo passaggio di un sogno, una tenda bianca che ondeggiava illuminata dalla luce di una finestra vista dal basso verso l’alto. Nient’altro. Solo la tenda e i vetri della finestra, ma era terrifico. Non so cosa mi consentì di vedere, indietro nel tempo del trauma, in quella tormentata donna in carriera la bambina che era stata. Di vederla con gli occhi della mente analitica, terrorizzata dall’abuso paterno, sdraiata sul letto, aggrappata alle lenzuola con lo sguardo fisso allo svolazzare di quella tenda bianca. O un’altra volta ancora, un’unica scena di un sogno: un cagnolino a tre zampe che si allontanava da una stanza. E, nuovamente, fu una subitanea intuizione a permettermi di collegare l’attuale sofferenza di un’anziana dama a un’infanzia solo apparentemente felice; un’infanzia zoppicante come quel piccolo cagnolino che, nell’emergere improvviso di uno straziante ricordo infantile prima assolutamente dimenticato, le fu donato ma le fu anche improvvisamente tolto da una madre rigida e patofobica che non ne avrebbe mai tollerato la presenza. La mattina dopo era già sparito, primo di una serie di lutti ben più gravi ma non più dolorosi di quella precoce perdita, tanto sofferta quanto rimossa.
Mi ha sempre colpito il modo in cui in tali situazioni la mia mente si appresta a “vedere”: le teorie apprese messe a parete come protezione degli avi e al centro della stanza la scena analitica come uno spazio da colmare. C’è in analisi un legame profondo e sotteso tra l’illuminazione di un’improvvisa comprensione e la trama circostante di teorie e di conoscenze che la rendono possibile e significativa. Il mondo del paziente è come scandagliato da queste due dimensioni, la scienza e quella percezione di subitanea conoscenza che Spinoza chiama di terzo genere. Un intuito videre lui dice: un’intuizione che permette di cogliere l’essenza delle cose in modo immediato e necessario.
Adoro i testi che riescono a parlarne e per quanto il libro che ho deciso di presentarvi oggi apra a ventaglio una grande quantità di considerazioni, è in particolare la pagina che parla di tale specie di rivelazione intuitiva ad affascinarmi, rendendo poi tutto il resto come un vortice che le ruota attorno. Un coup the theatre appunto che conferisce al testo una sorta di insight epico.
Il titolo è Vita di Galileo e l’autore, Bertolt Brecht. Scelgo questo tra i molti capolavori di colui che fu definito il grande trasformatore del teatro, a pensarci bene per una serie di motivi. Principalmente per quel sorriso di stupore che mi ha suscitato il momento dell’arguzia geniale, ma poi forse anche perché fu uno dei testi messi all’indice da Hitler e poi bruciati al rogo il 10 maggio del 1933. Come se il sincizio tra scienza, conoscenza e intuizione intellettiva si facessero beffe di quella che fu un’era buia nella tormentata storia del mondo, proprio suscitando l’anatema del tiranno e piegando la figura di Galileo stesso al vento degli accaduti.
Esistono di Vita di Galileo tre versioni, quella danese scritta da Brecht prima dello scoppio della guerra nel 1938-1939, quella statunitense scritta negli ultimi anni di guerra nel 1943-1945 e quella berlinese scritta 10 anni dopo nel 56. La red line è il modo in cui viene presentato l’abiuro del protagonista: nella prima versione gesto di un eroe astuto e pragmatico, nella seconda di un anti-eroe ambiguo e problematico, nella terza quale messaggero portatore ai posteri di un monito. Nelle tre versioni, l’enfasi sulla speranza del trionfo della verità scientifica si dissolve miseramente all’evento dello sviluppo e dell’uso della bomba atomica, anche se poi a guerra ampiamente ultimata Brecht, oramai vicino alla morte, consolida l’idea della responsabilità etica dello scienziato. Ma nel testo di cui vi parlo, il terzo, quello berlinese, che ha per così dire consacrato definitivamente il mio amore per il teatro, io vedo ancora ben altro. O meglio forse intravedo proprio tale responsabilità morale dello scienziato nel suo delinearsi, fin dalle prime scene.
La tenda si apre, atto primo, scena prima, su una “stanza di lavoro miseramente arredata”. Entra Andrea il figlio decenne della governante di Galileo, “recando un bicchiere di latte e un panino”. “Mamma dice che c’è da pagare il lattaio” Avverte il bambino. E da queste prime parole, nel proseguire nel discorso, inizia un affascinante dialogo fra i due che mi ha sempre scaldato il cuore. E’ così che dovremmo parlare ai nostri figli e aprire la loro mente alla fantasia e alla curiosità. E’ così che dovremmo trasmettere l’amore per la scienza e per le conoscenze: come fossero i pensieri scientifici familiari come i semplici oggetti di quella stanza. Galileo spiega al bambino i saperi della sua scienza con parole essenziali ed efficaci come un gioco tra maestro ed allievo o fra nonno e nipote: citando un astrolabio (pag 9) gli parla del moto degli astri che secondo gli antichi girano attorno alla terra. E pian piano, mentre il bambino si fa sempre più attento e partecipe, lui si va scaldando e le sue parole diventano fuoco, per quanto sempre facili e adatte alla mente infantile. “Muri e calotte: ogni cosa immobile! Per duemila anni l’umanità ha creduto che il sole e tutte le costellazioni celesti le girassero attorno…. Ma ora ne stiamo uscendo fuori, Andrea, e sarà un grande viaggio. Perché l’evo antico è finito e comincia la nuova era. Da cent’anni è come se l’umanità stia aspettando qualcosa.” Seguono pagine intrise di quella bellezza di cui parla Dirac[3] quale vettore primo della verità della Scienza. Pagine che, se pur volte dall’autore a ciò che più avanti (pag 213) la campana di San Marco con i suoi rintocchi funesti decreterà come l’avvenuto abiuro su cui di fatto l’intero testo è imperniato, per me portano a quanto accade invece molto prima dell’esecrata resa. Proprio al termine di quella deliziosa lezione al piccolo Andrea, Galileo ha appena finito di dire: “Dunque: sotto di te tu vedi la Terra…” godendo del tripudio del suo giovane pupillo che esclama: “Bella questa!”, allorquando in scena “entra Ludovico Marsili, un giovane di famiglia ricca”. Un olandese che ha ben poca testa per le scienze, come lui stesso confessa. Galileo è appena appena interessato alle lezioni richieste, pensando solo a quanti scudi può ricavarne, quand’ecco che l’ingenuo giovanotto si lascia sfuggire qualcosa (pag 23). “Dovrete portar pazienza con me. Specialmente perché nelle scienze tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buonsenso”. Ed ecco le coup de theatre. “Prendete per esempio quello strano tubo che vendono ad Amsterdam” continua ignaro: “L’ho esaminato minutamente. Un fodero di cuoio verde e due lenti, una così e una così… E tutto si vede cinque volte più grande là dentro.” Le pagine seguenti sono deliziose, per l’eccitazione di Galileo che intuisce immediatamente la portata di quell’oggetto e per il modo in cui lo presenta al Procuratore, giunto poco dopo, che gli chiede: “Escogitate qualche altro bell’oggettino…”. Dopo un divertente tiramolla, Galileo riflette: “Uno strumento magico, in verità… Forse, caro Priuli, ho qualcosa del genere” presentando infine come propria l’invenzione del cannocchiale.
Amo molto queste trovate che in teatro aprono la scena ad un inusitato che stravolge le cose, come talora accade in certi momenti particolarmente proficui in analisi. Brecht ha il pregio di farci sentire come sia indispensabile un nutrito substrato teorico e una dose di talento perché le porte della conoscenza intuitiva si aprano.
In certi altri testi, il colpo di scena è fragoroso come un tuono, e rapido come una spada argentata, proprio come lo svolazzo della mia tenda bianca. Ne ricordo uno tra tutti, forse il più spettacolare. E’ un momento teatrale che il genio del Grande Bardo rende indimenticabile. Ricordate? Siamo a Venezia e si sta svolgendo in tribunale la causa intentata da Shylock il Mercante contro Antonio. Sembra che il destino di quest’ultimo sia segnato. Porzia sotto le mentite spoglie del giovane avvocato Bellario sembra dovere cedere ad una legge inesorabile: che la pena dunque venga eseguita, che ad Antonio venga strappata una libbra di carne. Il coltello sta per trafiggere il cuore di Antonio, quando ci giunge la voce di Porzia-Bellario che avverte: non una sola goccia di sangue sia versata e non sia tagliata né più né meno di una libbra esatta di carne. E il gioco è fatto.
Ma seppur sempre estasiata da Shakespeare e dalle sue trovate ingegnose che colgono di sorpresa vincendo su tutto, quello che amo particolarmente nel testo di Brecht è questo ineffabile legame tra la scienza insegnata a un bambino e una percezione aperta e intuitiva verso il nuovo e verso ciò che ancora non conosciamo. E, come conclude lo stesso Andrea alla fine del testo: “Impara ad aprire gli occhi …. Ma, naturalmente non si può dire. Ne sappiamo troppo poco…Davvero: siamo appena al principio.”
[1] Cordioli A. (2024), L’inaudito e l’arcobaleno. Trasformazioni di un’analista durante un viaggio nella musica queer in Musica e adolescenza, Rivista KnotGarden 2024/1, www.centrovenetodipsicoanalisi.it.
[2] Petrella F. La mente come teatro. Centro scientifico torinese, 2011
[3] Dirac P.A.M. (1925) La bellezza come metodo Scienza e idee Milano 2019
