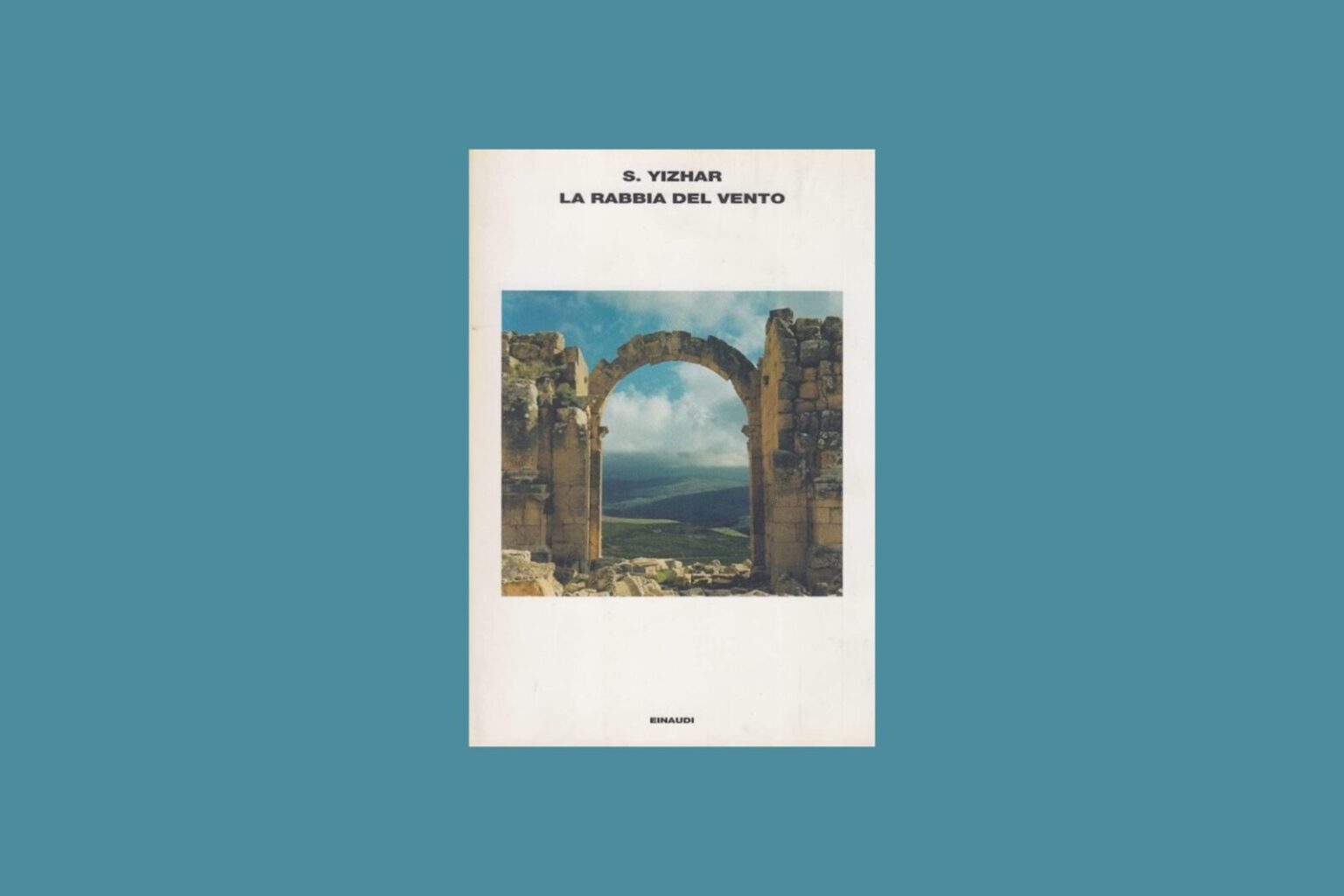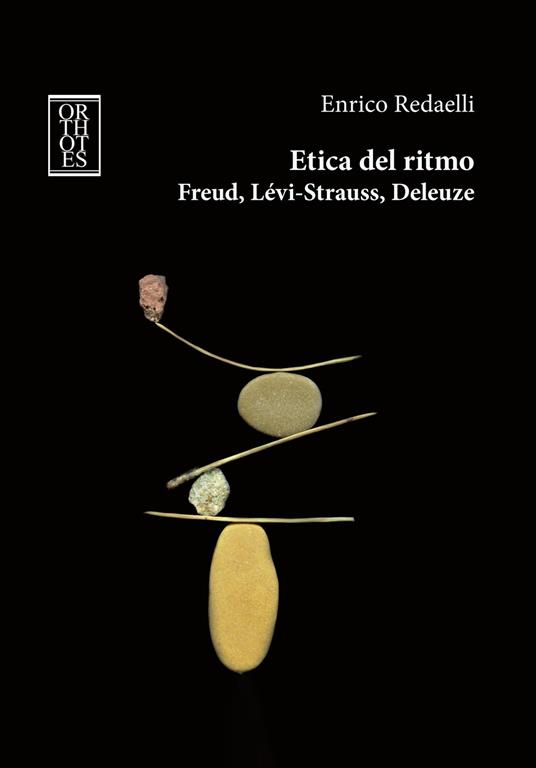Parole chiave: #maternità, #follia, #scrittura, #padri
QUEL CHE SO DI TE
di Nadia Terranova (Guanda, 2025)
Recensione di Daniela Federici
Tutte le vite sono finzioni,
almeno nel senso che sono costruzioni.
Coetzee, La buona storia
Non sono mai stata certa che l’amore possa curare le distorsioni ma, dal giorno in cui la bambina è atterrata sul mio pianeta, vivo su un confine contaminato da una promiscua pienezza.
Come si torna a scrivere dopo un parto, come si continua a essere spietati sulla pagina?… Scrivere è appiccare incendi, bombardare città, stanare i prigionieri. I figli invece si proteggono, si strappano alle rovine, si portano via dai roghi. Scrivere dopo una figlia significa esporti al doppio della fatica: devi fermarti dopo pochi passi per tirarla fuori dalle macerie, mentre il tuo disturbo corre giù per la linea delle antenate.
Quest’ultimo libro di Nadia Terranova è una riflessione sulla passione di scrivere – espressione dell’umana spinta a dare forma continuamente al proprio mondo -, è un’indagine sulla propria storia e la propria interiorità, sulla maternità che la convoca a richiamare il filo delle radici e rispondere al desiderio di sapere da dove vengo. Perché non c’è neutralità nelle genealogie, ogni storia riceve senso dai piani slittati delle coincidenze e delle premonizioni.
La incontro spesso in sogno, la mia bisnonna: una donna minuta e silenziosa sulla soglia di un manicomio che sarebbe diventato un esilio.
La storia di Venera risuona degli echi di alcuni romanzi precedenti dell’Autrice, di una vita abitata da presenze sospese, fantasmi e lutti silenziati, di un femminile immaginifico e stregato.
Esistevano sussurri che sentivo solo io…(…) La sentivo vagare per casa come uno spettro incastrato che non trova più la strada per tornare indietro, si era incarnata in un bisbiglio, in una parola lasciata cadere e subito messa al riparo.
Le storie di famiglia sono formule magiche, come una fiaba che si invera per ripetizione, nell’oralità.
Quando Venera è incinta della sua terza figlia la perde drammaticamente e sprofonda nel mutismo.
Il silenzio è lo spettro di un enorme catino vuoto…
Sopravvissuta ai molti aborti della propria madre, cresciuta come una bimba da sempre silenziosa, viene ricoverata in manicomio per alcuni giorni: l’aborto le ha fatto tornare in mente che ogni nascita è un caso, la vita un inspiegabile, fortuito deragliamento.
In certe vite la disgrazia è un dono perché rende concreta la stranezza, la incatena a un fatto. Ma su una madre straziata, la diagnosi che sentenzia l’attraversamento di quella soglia suona come negazione del diritto all’elaborazione della perdita, al tempo di un dolore scomposto.
C’è una zona disturbata in cui le diagnosi sono costrette a guardare in faccia le biografie,in cui la medicina deve fare i conti con l’umano che straborda e disobbedisce al dizionario scientifico; per guardare dentro le storie degli altri, afferma la Terranova, occorre l’apertura a una lingua che non esiste ancora.
Così quando diviene madre a sua volta, l’Autrice ripercorre la storia della sua antenata, restituendo una voce a chi l’aveva perduta con una tessitura evocativa e partecipata delle pagine mancanti: la famiglia è la storia che ti racconti, il modo in cui te la racconti, mentre ognuno vive il suo pezzo di vita, la sua parte nel gruppo, a tratti indifferente alla versione degli altri. Scrivere è interrompere il non detto, o crearne uno nuovo… Scrivere è creare un incantesimo: se lo scrivo, accade. Scrivere è spezzare un incantesimo: se lo scrivo, non accade più. E’ cercare un varco tra le versioni…
Dare forma agli inelaborati cui la Mitologia Familiare a un tempo la rimandava e la teneva distante, la mette davanti al dilemma di ogni creazione: come coniugare la spinta a comunicare e il bisogno di non mettere a nudo, gli altri o l’intimo che sempre riveliamo.
La parola, come la scrittura, sono una messa in versi di noi, un’espressione simbolica per creare il mondo e crearsi, non diversamente dal gioco fra soggettivo e oggettivo con cui ogni bimbo scopre e inventa il mondo significandolo, perché è quella la sorgente di ogni nostra creatività. La capacità riflessiva dell’essere che si osserva, è contatto con le proprie esperienze nascoste, con i fenomeni soggettivi che ci regalano il senso del reale, con le possibilità trasformative di un’esperienza che diviene conoscenza varcando e ricomponendo incessantemente i nostri confini, permettendoci di divenire più pienamente noi stessi, espandendoci e arricchendoci.
Quando poi la lingua impiegata sa ascoltare e tradurre i suoni vivi del discorso, quel che Frost definiva “l’orecchio dell’immaginazione”, allora quell’impronta personale arriva a comunicare l’esperienza umana con risonanze universali.
Quando scrivo creo forme di verità circoscritte da un limite, è il confine a renderle autentiche, a dar loro la concretezza che serve.
Venera non è solo una splendida protagonista, un fantasma familiare che insidia le notti dell’Autrice fin da quando era bambina con enigmatici messaggi da tradurre, è anche una riflessione sulla condizione femminile e quelle ‘devianze’ che tanto attraggono saggisti e letterati, è un dire di sé che offre uno specchio in cui ritrovarsi, perché quei giorni di ricovero sono metafora delle fatiche e degli inciampi del vivere di ognuno.
Non c’è una ragione per tutto, il corpo e la mente sono fallibili, possiamo cadere e basta.
Venera è la storia di ogni materno intenso e scosceso che ha bisogno di una lingua che sappia stare nella contraddizione, che parli di quel che elettrizza, entusiasma, anestetizza la stanchezza e insieme del buio, del pianto che fa perdere la ragione, dello sgomento di un amore che si vacilla a gestire, felici e tristi insieme. Siamo più di questo lessico insufficiente, madre è più di una parola, è un varco…
Deliziose le pagine in cui la scrittrice, descrivendo l’incontro con la sua bimba, raffigura come l’essere umano nasca psichicamente all’interno del rapporto, muovendo i suoi primi affacci a partire da una solitudine fondamentale, un albeggiare in cui non c’è ancora “un punto da cui guardare”, come lo definiva Winnicott, da cui discernere un ambiente non-me. Una madre non è niente. L’inesistenza è il mio ultimo sollievo. Se non esisto non posso sbagliare. Il verde degli alberi incombe dalla finestra, mia figlia mi guarda ma non mi vede. In quel momento, dentro quel preciso nulla, nell’isolamento dell’ospedale in cui ho appena partorito, capisco cosa non potrò mai più permettermi di fare. Impazzire.
In quella simultaneità paradossale di unione fusionale e separazione, l’estrema sensibilità che chiamiamo “preoccupazione materna primaria”, con il suo coinvolgimento corporeo e l’elaborazione immaginativa, fa spazio al “venire a essere” della soggettività del bambino a rischio di perdere il senso di fondatezza di sé.
Le figlie espropriano il corpo della madre, che per via di quell’esproprio può impazzire, provare un’insofferenza esasperata, sognare di tornare libera e nuda, prima di loro, senza di loro. Per poi soffrire una mancanza indicibile quando i corpi che ha generato sono lontani e non incombono più. quando contro ogni evidenza la loro presenza resta, come quella degli arti amputati.
Nadia Terranova rende superbamente il lavoro psichico che occorre alle madri per restare vive nella propria soggettività e non ritorsive, per offrire un’esperienza di continuità salda e di capacità a trasformare le tensioni, per non gravare il figlio delle proprie parti buie: la bambina sarà un’adulta dalle spalle libere. Il macigno gliel’avrò tolto io.
Quanto è difficile l’incontro con l’altro, a maggior ragione se è stato un’estensione di sé. È un viaggio che fanno insieme, madre e figlia, e che ha bisogno dei padri per fare i conti con l’irriducibile alterità che costruisce il reale. Magie e turbolenze narrate con onestà: finiamo schiacciate da domande create apposta per paralizzarci, vicoli ciechi che ci portano dritte al collasso performativo. Lasciateci libera di non farcela, né come madri né come artiste. Lasciateci sperimentare il fallimento, lasciate che ci concentriamo sull’unica cosa che importa: non cadere, o cadere senza uccidere chi amiamo.
Una splendida storia, con cui l’Autrice invita ad aver cura delle proprie cadute e a non temere troppo ciò che ci abita così come quel che non possiamo prevedere.