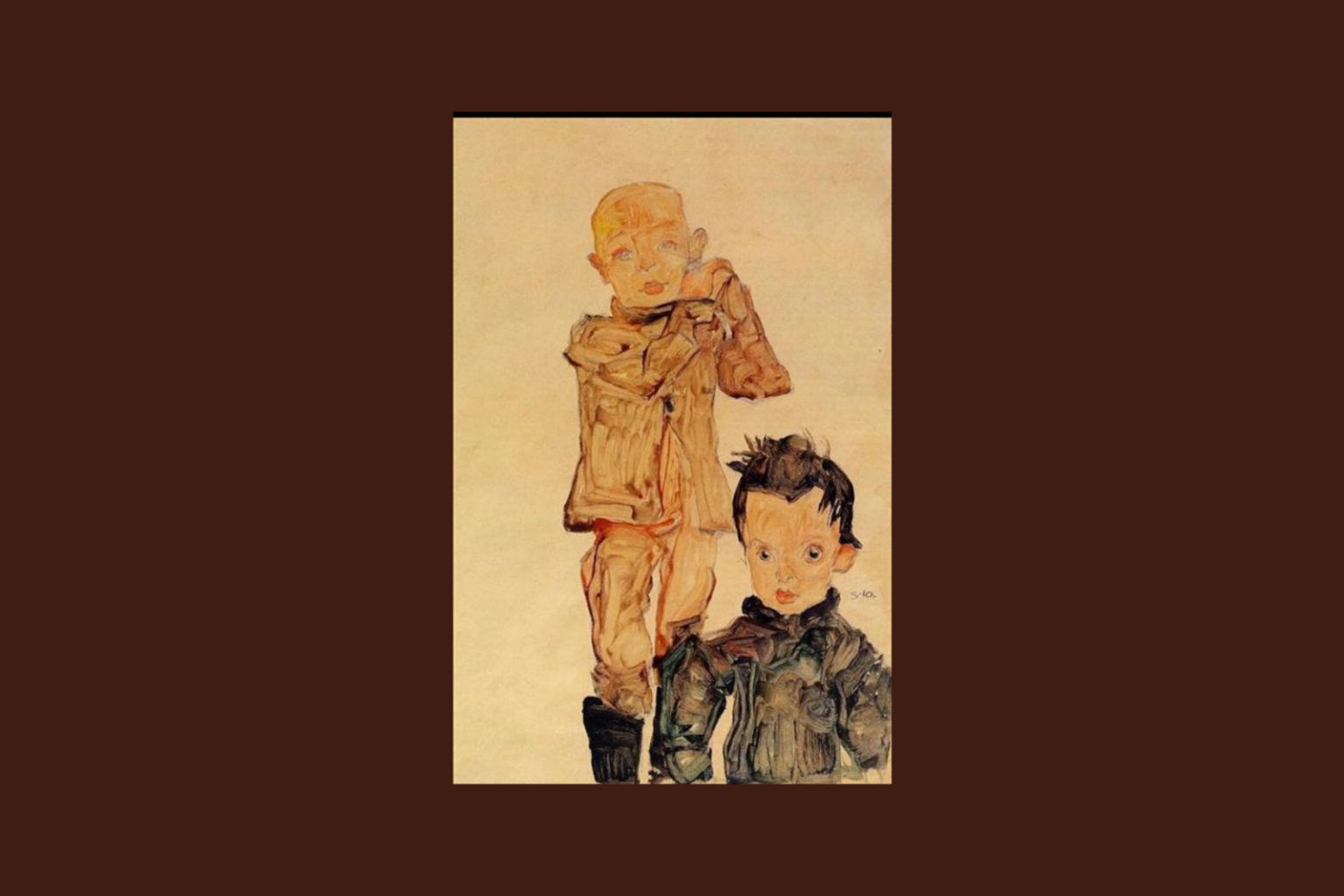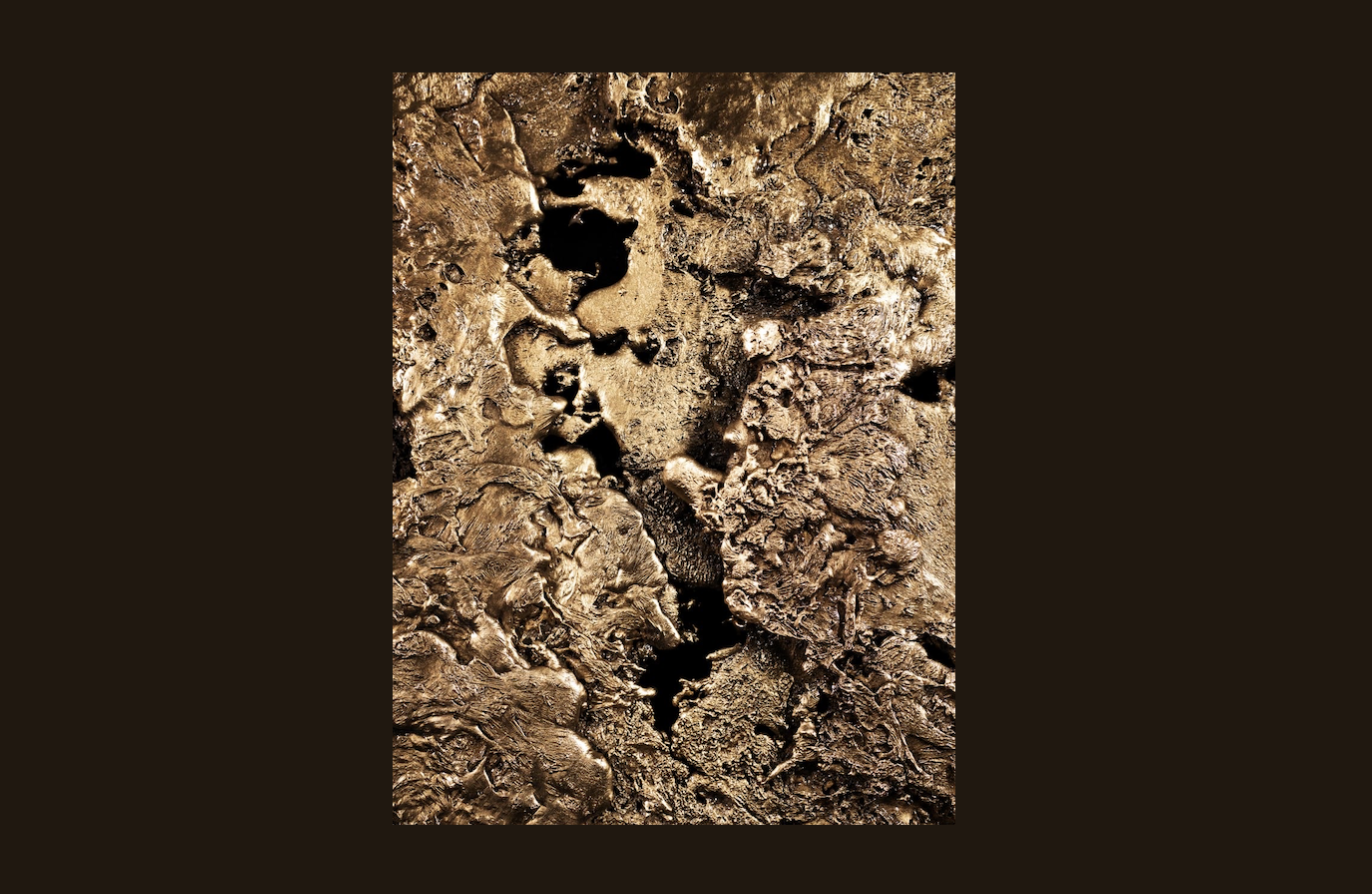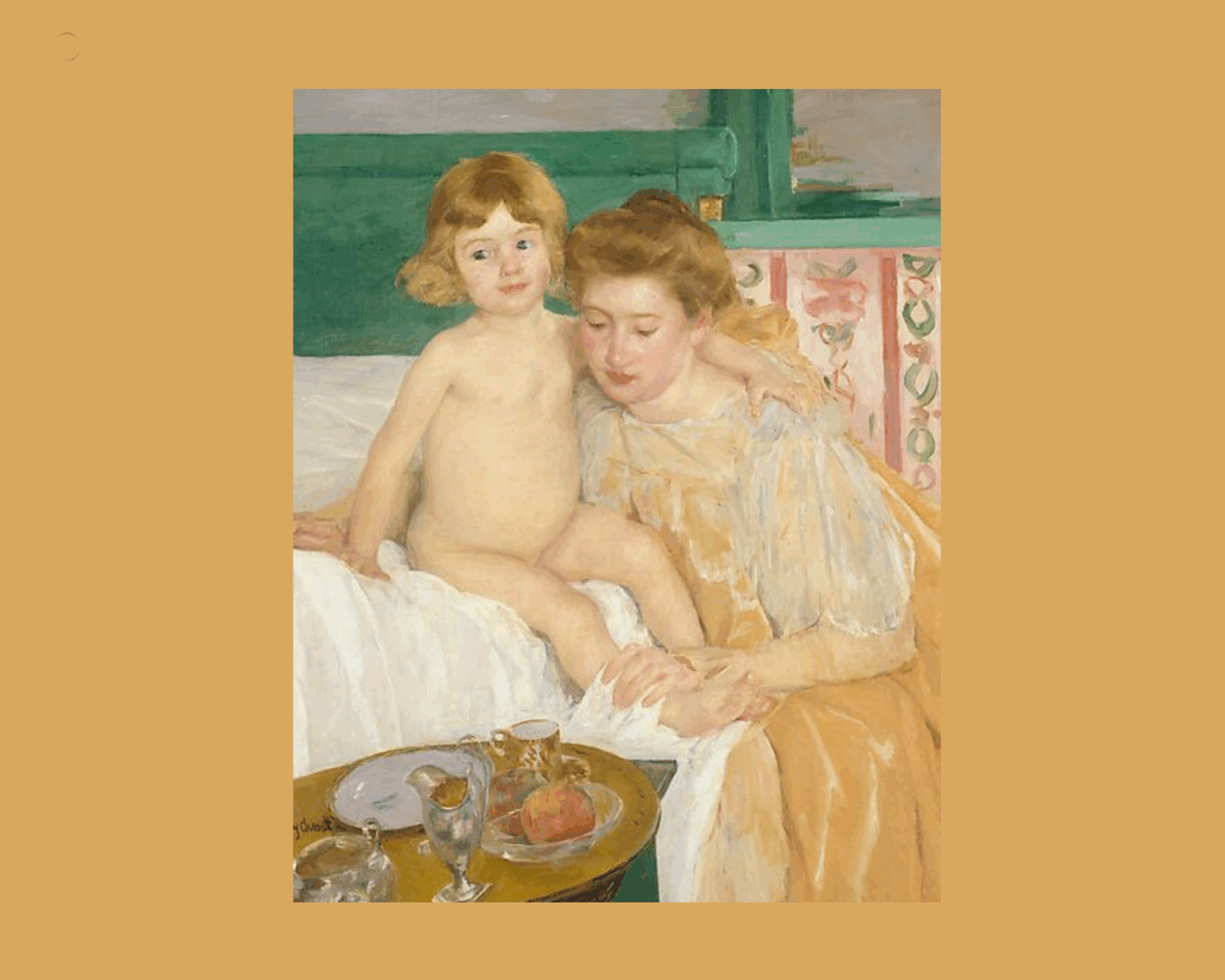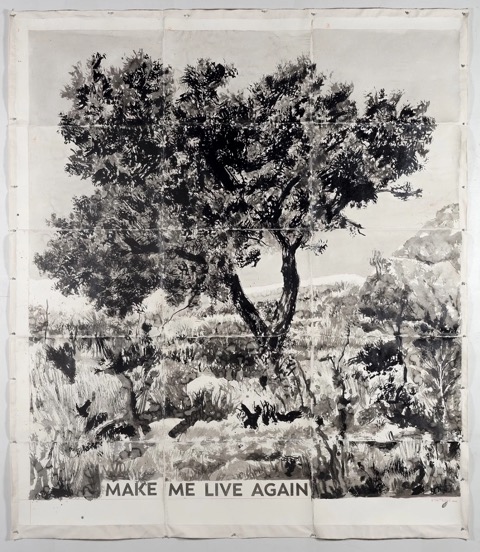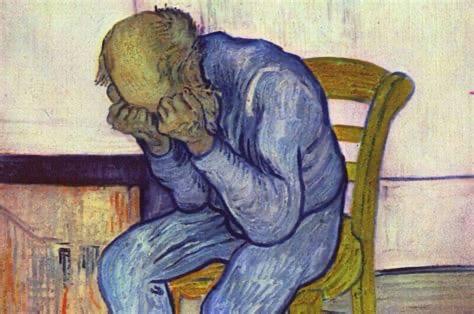
Parole chiave: transgenerazionale, intergenerazionale, gruppi famigliari, Badaracco
Quello che ci viene proposto è un “a proposito” radicato negli aspetti storici delle teorizzazioni, ma
mai disgiunto dall’esperienza clinica e dalla pratica terapeutica. L’autore intreccia queste due fila del
discorso in un insieme organico, potremmo dire che in tal modo raccoglie e motiva la sostanza del
termine transgenerazionale.
A proposito dei fenomeni trans-generazionali
di Andrea Narracci
Partiamo dal presupposto che riteniamo plausibile che possa verificarsi una trasmissione psichica tra uno o più membri di una famiglia, appartenenti ad una generazione e uno o più i membri che appartengono ad una generazione subito successiva; oppure che la trasmissione psichica venga effettuata su quella successiva, ma che questa rimanga silente e si limiti a passare tutto alla generazione successiva ancora. La sostanza del problema cambia molto parzialmente.
Ci sarebbe molto da domandare su come si verifichi, a parte che attraverso l’inconscio, però è difficile negare che si verifichi.
Lo do’ per scontato e rimando ogni ulteriore discussione in merito al “come” ad altro contesto.
Propongo di riflettere insieme sulla “forma” in cui questa trasmissione si verifica.
Dobbiamo a Evelyn Granjon la definizione chiara della differenza tra una trasmissione intergenerazionale ed una transgenerazionale dei contenuti appartenenti alla storia evolutiva, dai membri di una generazione precedente a quelli di una generazione successiva, della stessa famiglia.
Prima di tutto va ricordato che, secondo questa Autrice, affermazione su cui io concordo, le due modalità di trasmissione, intergenerazionali e transgenerazionali, sono complementari e intricate.
Nel primo caso, quello della trasmissione intergenerazionale, si tratta di un modo “che implica trasformazioni successive di ciò che è trasmesso, uno scarto e dei legami tra chi trasmette e chi eredita”.
Nel secondo, quello della trasmissione transgenerazionale, “il passaggio di vissuti bruti, traumatici o interdetti, si impone alle generazioni successive, ai gruppi familiari e agli eredi”.
Mentre nel primo caso, la trasmissione risulta essere fisiologica, nel secondo caso, possiamo ipotizzare che non lo sia e che è abbastanza probabile che ciò possa dare luogo a dei problemi.
Non ho l’impressione che saremmo nel giusto se ipotizzassimo che tutto dipenda dal modo in cui vengono trasmessi i messaggi tra una generazione e l’altra o le altre.
In realtà il discorso è ben più complesso.
Prima di tutto, a mio parere, è necessario prendere in considerazione un’altra questione di fondo: dove si forma e perché quella che tutt’ora definiamo la malattia mentale grave?
Dentro un individuo oppure nella relazione tra due individui?
E’ un processo che riguarda una persona oppure almeno due e, con una certa probabilità, anche altri componenti della stessa famiglia?
Mi riferisco alle due ipotesi esplicative più accreditate: la malattia mentale grave nasce e insorge dentro una persona oppure nella relazione tra due? Implica l’essersi venuto a determinare qualcosa che si svolge anche sul piano biologico oppure prevalentemente su quello psicologico?
A mio parere, quando poniamo l’accento sulle questioni riguardanti il modo in cui si organizza ed evolve, nel tempo, una relazione tra due persone, non stiamo parlando di qualcosa che avviene inizialmente sul piano biologico ma su quello psicologico e la cui evoluzione, a lungo andare, può avere ripercussioni anche su quello biologico.
Dunque, opto per la presa in considerazione di quello che avviene tra due persone, una più grande, generalmente un genitore ed un figlio/a.
Stiamo parlando di un particolare tipo di relazione intensa che prende il nome di “legame”, come ci ha suggerito Enrique Pichon-Riviere, che per primo ha utilizzato questa espressione.
Per legame, si intende tutto ciò che passa, sia a livello conscio che inconscio, tra una persona e un’altra e viceversa e che dà luogo ad una relazione particolarmente significativa.
Un’ipotesi esplicativa chiara, a mio parere, a proposito di quello che accade nelle malattie mentali gravi, schizofrenia, disturbo bipolare e disturbo border-line di personalità, ma non soltanto, l’ha formulata Jorge Garcia Badaracco. Quando questo Autore argentino, negli anni ’60 del secolo scorso, stava dirigendo un reparto per pazienti uomini, in cui erano ricoverati, per il 70 per cento, persone affette da schizofrenia, poiché alcuni pazienti stavano meglio, aveva convocato i loro familiari per capire se fosse possibile dimetterne alcuni. Cominciarono a venire molti familiari e a quel punto, davanti agli occhi suoi e degli operatori, si presentò un’immagine che risultò contraddittoria rispetto alle loro aspettative: almeno uno dei due genitori, che fino a quel momento dichiarava quanto fosse diverso da lui/lei il proprio figlio contrariamente a quanto da loro dichiarato, dato che fino a quel momento, ogni genitore non era riuscito a spiegarsi quanto fosse diverso da loro il proprio figlio/a patologico/a, apparve simile al figlio e il figlio apparve a tutti i partecipanti all’incontro come una “caricatura” del genitore.
Allora ripensò al concetto psicoanalitico di simbiosi e a tutto quello che quel concetto implicava: il genitore e il figlio rimangono incastrati in una situazione in cui il processo di crescita si interrompe e l’uno resta legato all’altro, come se ognuno potesse seguitare a vivere tranquillo, soltanto mantenendosi in quella posizione.
Osservata da questo punto di vista, la malattia mentale grave, a cominciare dalla schizofrenia, ma in realtà il discorso vale per tutte le patologie mentali, indipendentemente dalla specificità dei sintomi manifestati e, quindi, delle diagnosi a cui si può giungere, viene fatta risalire al fatto che si sia costituito, nel tempo, un legame che non si è sviluppato e che, quindi, non ha permesso di crescere ed evolvere al paziente, in primo luogo, ma anche al genitore, altrettanto coinvolto in esso.
In poche parole, viene presa in considerazione l’idea che entrambi non siano in grado di vivere il processo di separazione-individuazione l’uno dall’altro e viceversa e che, quindi, rimangano nella posizione di anteporre la necessità di considerare questo “legame” prima di tutti gli altri.
Trattando situazioni di questo tipo, seguendo l’impostazione osservativa psicologico-psichiatrica classica, abitualmente siamo indotti a pensare che la difficoltà a vivere il reciproco processo di progressiva separazione-individuazione dipenda originariamente da qualcosa che riguarda il più piccolo dei due, la persona identificata come il malato.
Man a mano che si frequentano i gruppi multifamiliari, che mettono insieme tante famiglie compresi i pazienti o, almeno, alcuni rappresentanti, anche soltanto uno, di tante famiglie, appare sempre più chiaro che il problema è ripartito tra il figlio e il genitore tipicamente più coinvolto.
Viene, inoltre, da pensare che tra i due sia più facile che la difficoltà a separarsi dall’altro sia insorta prima nel grande piuttosto che nel piccolo. Perché dovremmo aspettarci che sia il più piccolo ad insegnare al grande come si fa a separarsi progressivamente dall’altro?
A questo punto, viene fuori la domanda: ma come è che ad un genitore, proprio in quel momento della sua vita, risulti difficile separarsi da quel figlio/a e avviare il processo che al figlio/a consenta di individuarsi e al genitore di vivere parallelamente il piacere di ritrovare la propria autonomia, man a mano che l’altro/a cresce?
Io credo che per rispondere a queste domanda possa risultare molto utile pensare che il grande abbia sperimentato un lutto o un trauma o entrambi, che non li abbia elaborati ma scissi e dissociati e, perciò, li abbia resi non recuperabili e di cui non ha nemmeno il ricordo che si siano verificati. Ma che, però, tali accadimenti abbiano lasciato in lui dei “buchi”, la cui dolorosa presenza sia stata colta e presa in considerazione da quel figlio/a.
La presa in considerazione della presenza di un dolore nel proprio genitore rimanda alla definizione che aveva dato Ferenczi, all’inizio del secolo scorso (1908), della sofferenza dei genitori percepita come “terrorismo” da parte del figlio: cioè come qualcosa che atterrisce e da cui non ci si può difendere.
A ragione, Kaes ci ha insegnato che la Psicoanalisi, da quando ha iniziato a prendere in considerazione le coppie e le famiglie ha subito una trasformazione, tanto che arriva ad ipotizzare che sarebbe necessaria una “terza topica”, la topica del legame.
Il figlio inizia a sentire la sofferenza come se fosse propria e tende ad impostare la sua vita, del tutto inconsapevolmente, per fronteggiarla. D’altronde la sofferenza ha colpito la persona a cui è più legato, che gli da sicurezza e occuparsi del suo benessere significa mantenere il proprio.
All’interno di un gruppo multifamiliare, un paziente ad un certo punto se ne esce con una frase, riferita alla madre: ”Tanto io l’ho sempre edificata”.
Un paio dei colleghi presenti ipotizzano che quella frase corrisponda alla ricomparsa di una lettura delirante della realtà. Prima di abbandonarci a questa idea, proviamo capire e dopo un po’ il paziente spiega che la propria madre era la quinta di undici fratelli, che la sua famiglia era rigidamente patriarcale, che lei si era ribellata e che aveva poi dovuto combattere tutta la vita per farsi perdonare. Per farci capire meglio, il paziente ci racconta che quando loro andavano a pranzo a casa dei nonni, egli sentiva che la nonna lo trattava in un modo tale da fargli capire che, se loro non fossero venuti, sarebbe stato meglio per tutti. E che egli, di fronte a questo atteggiamento aggressivo della nonna nei confronti di lui e della madre, aveva sentito la necessità di portare avanti la missione di difenderla, prima di tutto dagli attacchi della nonna.
Questo breve frammento clinico sembra confermare appieno l’ipotesi formulata: il figlio molto piccolo, sente la presenza di una sofferenza, legata in questo caso alla comunicazione, da parte della nonna alla madre, di non poterla perdonare per la mancanza di rispetto ricevuta, ribellandosi.
Mobilita le sue energie, da quel momento in poi, per attenuare la sofferenza nella madre da cui, evidentemente, non è più possibile separarsi. Quel compito darà forma alla sua vita.
L’effetto del venirsi a determinare di una situazione in cui due persone, una appartenente ad una generazione ed un’altra, appartenente a quella successiva, contraggono un legame da cui non possono liberarsi, comporta a lungo andare conseguenze differenti.
Il grande, il genitore “che aveva da sempre mantenuto un occhio vigile sull’evoluzione della storia di quel figlio, che non era andata bene fin dall’inizio”, dopo l’infanzia e l’adolescenza in cui la situazione del figlio aveva incontrato molte difficoltà ma, con il suo aiuto e del resto della famiglia era riuscito ad andare avanti, al momento dell’insorgenza della prima crisi, in cui il figlio viene diagnosticato, inizia ad occuparsi di lui a tempo pieno fino a sostituirsi a lui: perché il genitore ritiene di sapere, meglio del figlio, quello che il figlio sente, pensa, dice e dovrebbe fare.
Il figlio, il paziente, che, fino a quel momento, si era identificato nel genitore e si era preoccupato di corrispondere alle sue aspettative, se e quando scopre, per es. attraverso un amico, che esiste un mondo altro, in cui si accorge di sentire “qualcosa di proprio” che, fino a quel momento non aveva nemmeno ipotizzato esistesse, inizia a chiedersi quale è la parte di sé che rappresenta di più sé stesso. A quel punto o “si ritira” dal mondo oppure “si rompe” in una crisi dissociativa.
Tutto ciò riformula il campo di cui ci stiamo occupando: viene ipotizzato che la psicosi non si organizzi e si sviluppi dentro una persona, ma nel rapporto tra due e dopo i contributi di Shore e delle Neuroscienze, in generale, è difficile seguitare a pensare che, come tutto il resto che vive un bambino, addirittura da prima della nascita e sicuramente dal secondo mese, dopo la nascita, anche questo non dipenda dal particolare tipo di interazione che ha avuto luogo prima tra quel bambino e quella madre, e contemporaneamente e in seguito con quel padre. Non che possa organizzarsi autonomamente dentro il bambino, senza dimenticare che la Genetica che conta è l’Epigenetica, che viene influenzata dall’ambiente.
Se lo sviluppo di quello che accade intersoggettivamente tra il bambino e il suo care giver è fondamentale ed influisce su quello che accade intra-psichicamente nel bambino e questi due mondi sono perennemente in comunicazione e si influenzano a vicenda, non possiamo non chiederci: come, attraverso quali strumenti? La risposta, secondo le Neuroscienze e Shore che le riassume e attribuisce loro un senso, è che tutto questo processo si basi sulla possibilità di vivere emozioni, da un lato e dall’altro e di scambiarsele ininterrottamente.
A mio parere, è stato il riconoscimento della centralità di questi due elementi, l’intersoggettività e lo scambio delle emozioni a contraddistinguere il “campo” in cui possiamo ipotizzare che riusciamo a prendere in considerazione i fenomeni trans-generazionali: e, cioè, che sia presente, all’interno del più grande una sofferenza, propria o di chi lo ha preceduto, da poco o da molto nella storia familiare e che, per difendersi dai danni che avrebbe potuto provocare una simile sofferenza, il più grande, appartenente alla relazione in cui il più piccolo diviene malato, utilizza o viene utilizzato da meccanismi di difesa radicali. Che rendono “non vissuto” (diniego) da lui stesso oppure “conosciuto non pensato” (Bollas C.), cioè conosciuto inconsciamente ma non pensato, sempre da lui stesso, anche se era stato vissuto da chi era venuto prima di lui, il fatto da cui derivava la sofferenza. Quella sofferenza che, fino ad oggi, non ha potuto essere pensata e vissuta o, almeno, rivissuta.
Tale sofferenza viene, però, percepita dal più piccolo della coppia patologica e si trasforma nel primo pensiero a cui dedicare la propria attenzione inconscia.
Una paziente, nel corso di un recente gruppo multifamiliare, proprio alla fine di un gruppo, ha raccontato che lei, uscito il marito da casa per andare a lavorare, “scappava” a casa della madre e che lei si era sempre preoccupata per questa madre, giungendo, quando era piccola, a risparmiare sulle merendine per comprarle un vestito nuovo.
Tale sofferenza ricompare, improvvisamente nella vita del più piccolo, spesso prendendo forma di dispercezioni e deliri incomprensibili, tanto da far pensare ad alterazioni presenti esclusivamente nel malato, che viene, in seguito a ciò, ricoverato e curato.
I farmaci completeranno l’opera di oblio. La ricostruzione diviene molto più difficile.
Comunque non impossibile. A patto che si costruisca una situazione in cui risulti possibile raggiungere il risultato di consentire ad ognuno dei partecipanti al gruppo multifamiliare di sperimentare una posizione auto-riflessiva. A cominciare dalla partecipazione al gruppo multifamiliare ma che, poi, può essere sviluppata in una psicoterapia individuale, di un singolo nucleo familiare e/o di gruppo costituito da pazienti, di dimensioni contenute (generalmente 8 pazienti) orientate in senso psicoanalitico. Una posizione auto-riflessiva che consenta ad ognuno di utilizzare sia il funzionamento della propria mente secondo il principio secondario che attraverso il contatto con il principio primario (libere associazioni, sogni, etc. etc.).
Bibliografia
Jorge Garcia Badaracco: “La Comunità terapeutica psicoanalitica di struttura multifamiliare”, 1997, Franco Angeli, Milano.
Jorge Garcia Badaracco: “Psicoanalisi Multifamiliare”, 2003, Bollati Boringhieri, Torino.
Jorge Garcia Badaracco: “Selection de trabajos”, tres volumen, 2018, APA Editorial, Buenos Aires.
Jorge Garcia Badaracco e Andrea Narracci: “La Psicoanalisi Multifamiliare in Italia”, 2011, Antigone Edizioni, Torino.
Bollas C.: “L’ombra dell’Oggetto”, psicoanalisi del conosciuto non pensato”. Roma, Borla, 1987.
Ferenczi S. “Opere”. Milano, Cortina, 1989.
Grandjon E.: “Du retour du forclos genealogique aux retrouvaillesavec l’ancetre transferenziel“, in Le Divan familial, 1, In Press, Paris.
Kaes R.: “Un singolare plurale. Quali aspetti dell’approccio psicoanalitico dei gruppi riguardano gli psicoanalisti?” Roma, Borla 2007.
Kaes R. “Per una terza topica dell’intersoggettività e dell’individuo all’interno dello spazio psichico comune e condiviso”, Funzione Gamma 21, http://www.funzionegamma.edu.(2008).
Kaes R.: “Le alleanze inconsce”. Roma, Borla, 2010.
Mitre M E: “Le voci del silenzio”, 2021, Angelo Fioriti, Roma.
Andrea Narracci, a cura di: “Da oggetto di intervento a soggetto della propria trasformazione”, 2021, Bruno Mondadori, Milano.
Russo F, Maone A, Antonucci A e Narracci A: “Psicoanalisi Multifamiliare come esperanto”, 2015, Antigone Edizioni, Torino.
Shore A: “La psicoterapia con l’emisfero destro”, 2022, Cortina, Milano