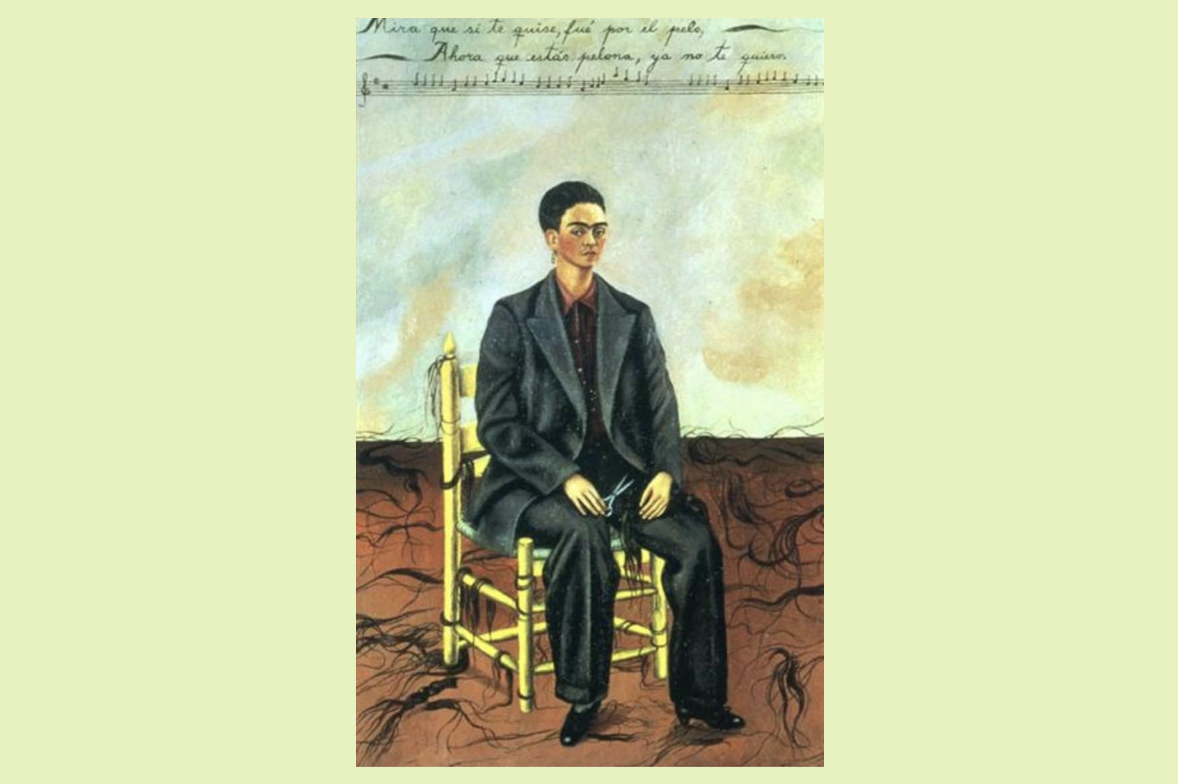Parole chiave: psicoanalisi infantile, Flegenheimer, setting
Nelle scorse settimane su iniziativa di Giuseppe D’Agostino, il Centro Torinese di Psicoanalisi ha voluto ricordare, con le parole delle colleghe Maria Teresa Palladino e Marinella Lia, la figura di Federico Flegenheimer, scomparso a Torino lo scorso 17 giugno.
Per molti di noi – e anche per me, che ho avuto la fortuna di incontrarlo come primo supervisore, come punto di riferimento costante e, negli anni, anche come compagno di studio – Federico ha rappresentato una presenza discreta e rassicurante, capace di trasmettere insegnamento e pensiero senza mai ostentare, ma con la naturalezza di chi lascia spazio anche alla creatività dell’altro.
Il ricordo che pubblichiamo restituisce la ricchezza di un percorso di vita attraversato da migrazioni e sfide, dalla formazione con maestri come Heinrich Racker, fino al radicamento a Torino.
Il ritratto che Palladino e Lia ci consegnano è quello di un collega che sapeva unire saggezza e leggerezza e che ha lasciato un’impronta profonda tanto nella psicoanalisi infantile quanto nell’insegnamento deontologico e nella trasmissione dell’etica del lavoro analitico.
Con gratitudine e affetto, lo condividiamo con i lettori di SPIweb come testimonianza viva della sua eredità.
Stefania Pandolfo
(caporedattrice di SPIweb)
In ricordo di Federico Flegenheimer. Di M. Lia e M.Teresa Palladino
Federico Flegenheimer è mancato a Torino lo scorso 17 giugno.
(il destino ha voluto che nello stesso giorno, a Londra, morisse il pianista Alfred Brendel, suo grande amico e interlocutore)
Federico era nato a Rotterdam nel 1929. La sua famiglia fu costretta ad emigrare in Argentina in seguito alla occupazione nazista del 1940. In Argentina studiò medicina (curiosamente, per un breve periodo fu compagno di studi di Che Guevara) e iniziò il percorso psicoanalitico con una prima analisi con Heinrich Racker e, dopo la sua morte, con Luisa Alvarez de Toledo. Di lei diceva: era dotata della enorme saggezza che si acquisisce con l’esperienza di una lunga vita, e non aveva paura dell’inconscio.
E’ certamente quello che noi possiamo dire di lui.
Nel 1976 con il colpo di stato in Argentina si trovò costretto ad emigrare un’altra volta e scelse Torino come meta di approdo.
Per lui Torino fu un rifugio stabile, in cui ricominciare la vita con la sua famiglia; per noi torinesi Federico fu un dono del destino. Analisi di training, seconde analisi, prime analisi, supervisioni del lavoro con gli adulti, supervisioni del lavoro con i bambini, sono pochi gli analisti e gli psicoterapeuti che non hanno chiesto e ottenuto il suo aiuto e la sua guida.
Era privo di narcisismo e di seduttività, e il suo modo di trasmettere conoscenza aveva una caratteristica più unica che rara: con poche parole, con una battuta, un aneddoto, una immagine, sapeva attivare il pensiero di chi lo ascoltava in direzioni libere e sorprendenti.
Una illustrazione particolarmente evocativa del suo modo di parlare e di pensare è la molto citata definizione di setting: il buio al cinema, il silenzio al concerto.
Ringraziamo Francesco Barale per avere messo in parole in cui noi tutti ci riconosciamo la sua esperienza di un incontro con Federico al Centro Torinese di Psicoanalisi: “con un tono quasi di scusa per il suo andare diretto al cuore di questioni tanto radicali con tanta semplicità, senza retorica, senza nessun autocompiacimento o sbrodolatura ideologica, fece una serie di osservazioni che mi colpirono per il mix raro di acutezza, precisione, pacatezza e understatement.”
Nel comunicato dell’Esecutivo Nazionale Ronny Jaffè ne sottolinea la capacità di trasmettere a generazioni di allievi l’etica del pensiero e del modo di stare col paziente. Per molti anni ha tenuto l’insegnamento di Deontologia all’Istituto Nazionale di Training, e non si potrebbe pensare ad un insegnante più adatto alla materia.
La sua visione della astinenza nel rapporto analitico, per esempio, non aveva niente di moralistico o di rigido ma era ispirata dalla preoccupazione di non invadere il campo delle potenziali capacità riparative del paziente.
Una illustrazione molto toccante la si trova nel suo articolo, pubblicato nel 1983 sulla Rivista di Psicoanalisi, intitolato ‘Divergenze e punti comuni tra psicoanalisi infantile e psicoanalisi degli adulti’ (articolo ispirato, tipicamente, da una domanda semplice: lei dove si siede quando è nella stanza dei giochi?)
Descrive un bambino di sette anni di età, che nei tre anni trascorsi dall’inizio della sua analisi aveva trasformato la sua scatola di giocattoli in una vera pattumiera, piena di giocattoli rotti, inservibili, calpestati, pieni di frantumi di materiali irriconoscibili. Un giorno questo bambino gli chiede di portare della colla, perché voleva unire due pezzi di carta. Federico descrive una potente spinta controtransferale ad esaudire il più presto possibile la sua richiesta: era la prima volta che il bambino esprimeva un desiderio riparativo, e sentiva di dovere essere lui a fornire il materiale necessario, perché nella scatola non c’era niente che potesse servire. Decide tuttavia di interpretare la confusione del bambino invece di affrettarsi ad esaudire la sua richiesta. Gli dice che ciò che serviva e ciò che non serviva si mescolavano in lui, e gli parla del suo timore di guardare dentro la scatola (dentro sé stesso) per non trovarsi con tante cose rotte.
Dopo alcune sedute il bambino incomincia a esaminare la sua scatola dei giocattoli, e trova un tubo metallico di colla, calpestato e completamente schiacciato. Prende le sue forbici e taglia il tubo a metà, e nell’interno trova una sola goccia di colla, che utilizza per unire due pezzi di carta.
Federico commenta che quella goccia di colla era molto più importante di tutta la colla che lui avrebbe potuto fornirgli, e che c’era nel bambino più capacità riparativa di quella che entrambi credevano possibile.
Chi è stato in analisi con Federico, o in supervisione, si può riconoscere nella sua capacità di lasciare emergere creatività e riparatività là dove il desiderio sarebbe di convincerlo a venire prontamente in soccorso con la sua superiore esperienza e saggezza.
La psicoanalisi infantile a Torino ha avuto molto da guadagnare con l’arrivo di Federico. Oltre ad occuparsi per molti anni, con Delia Luzzati, di formazione nell’ambito dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile del Comune di Torino, Federico ha facilitato una importante sinergia fra il Centro Torinese di Psicoanalisi e il gruppo di Livia Di Cagno, che al Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile aveva attivato una pionieristica formazione in psicoanalisi infantile. Analiste della British Psychoanalytical Society (Edna O’Shaughnessy, Athol Hughes, Judy Jackson e della Tavistock Clinic (Anne Alvarez, Iska Wittemberg) sono venute per anni ad insegnare alla Clinica Universitaria, mentre la presenza di Federico consentiva continuità nel lavoro di supervisione.
Quando Federico ha scritto per pubblicare lo ha fatto attingendo alla sua esperienza vissuta. Oltre all’articolo sulla psicoanalisi infantile, che rimane ancora oggi profondamente illuminante e orientativo, vale la pena di ricordare un suo lavoro molto bello comparso sulla International Review of Psychoanalysis nel 1989, intitolato ‘Languages and psychoanalysis: the poliglot patient and the poliglot analyst’. Federico si interroga su quello che succede quando un analista è costretto a lavorare in un linguaggio che non è il suo: che problemi nascono, quali sono i limiti di questa specifica situazione, quali sono le conseguenze nella tecnica? Alcuni analisti ritengono che il linguaggio non abbia importanza, l’Edipo è lo stesso dappertutto, altri semplicemente si rifiutano di lavorare in un linguaggio che non sia il loro. Federico riesce a confrontarsi con inconvenienti e limiti senza edulcorare e senza estremizzare, e la accettazione dei limiti, del ‘lutto’ (il bisogno di costanti richieste di chiarimento, i possibili fraintendimenti, la perdita dei significati più profondi dei giochi di parole e delle battute, la non completa condivisione del background culturale) gli consente di indicare alla fine una direzione di lavoro impegnativa ma fertile: se l’analista non ha una sufficiente familiarità con il mondo del paziente, questo può talvolta portarlo ad una visione più spontanea della situazione analitica, libera da preconcetti. Dovendo rivedere i suoi stereotipi interpretativi, l’analista è costretto ad affinare i suoi strumenti, a focalizzarsi di più sulla dinamica delle sedute e ad usare con cura il suo controtransfert. La conclusione è che arriva un momento in ogni analisi in cui l’analista è sperimentato come una persona diversa dal paziente, una persona che capisce e che può, con le sue parole, dare al paziente qualcosa di buono. E’ a questo punto che viene ad esistere quel particolare linguaggio che si crea e si ricrea fra il paziente e l’analista in ogni analisi degna di questo nome.
Vorremmo concludere con una testimonianza su Federico come persona.
Una di noi ha avuto, non molto tempo fa, l’opportunità di osservare Federico in un momento della sua vita privata: accompagnava la moglie Lucia, le cui difficoltà di vista erano già avanzate, a fare shopping in una boutique neo-romantica nei paraggi della loro abitazione. Lucia era accudita affettuosamente dalle titolari del negozio e si divertiva ad indovinare come poteva fogge e colori di un vestito dopo l’altro, mentre Federico leggeva il giornale seduto sullo scomodo scalino di una piattaforma di legno. La sua espressione era sorridente e pacifica, quella di un marito amorevole disposto a tenere compagnia alla propria moglie senza limiti di tempo né di pazienza.
I limiti di tempo non li ha decisi Federico, e la sua famiglia e noi colleghi possiamo solo rimpiangerlo, e continuare a lasciarci ispirare dalle esperienze che ci ha reso possibili.
Marinella Lia
Maria Teresa Palladino