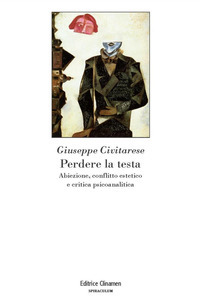
Perdere la testa. Abiezione, conflitto estetico e critica psicoanalitica.
Editrice Clinamen, Firenze, pag. 137. , (2012)
Recensione di Giorgio Bubbolini
Questo nuovo libro di Giuseppe Civitarese tratta di psicoanalisi e arte. La sua originalità consiste nella forza e nella sicurezza con cui si spinge oltre la tradizione freudiana della psicoanalisi applicata all’arte, e in particolare il suo riduzionismo patobiografico, in nome di un nuovo e più ampio paradigma teorico, fondato sulle prospettive aperte dal modello bioniano e, soprattutto, post-bioniano. Il suo metodo si fonda sul ruolo centrale attribuito alla funzione onirica della veglia nell’esperienza estetica, artistica e critica. Il suo vettore euristico determina una progressiva espansione del campo psicoanalitico, che così si espone ad un maggiore livello di entropia.
Civitarese prende le mosse dal fascino provato per «il tema della decapitazione nell’arte come figura della distruzione della mente», e dall’idea che in esso «si giochi una delle partite fondamentali della nostra vita psicologica» (9). Per far valere questi punti di vista, egli precisa di avere messo tra parentesi miti e storie collegati all’argomento e di essersi abbandonato all’immagine pura e semplice, una donna ed una testa tagliata di un uomo. Con questo metodo, egli mostra di privilegiare l’elemento formale, inteso come garante delle motivazioni più profonde dell’artista e insieme come antidoto contro le leggi della Storia. Osservando poi che, in quella situazione, donna e uomo gli appaiono, «come dice Bion del paziente e dell’analista nella stanza d’analisi, due animali feroci e spaventati» (ibid.), l’Autore chiarisce ulteriormente la via che intende seguire, cioè rendere il dispositivo onirico (post-)bioniano il motore dell’esperienza estetica.
Al tema della decapitazione fa poi subito da contrappunto quello della “sacra conversazione”, Madonne che allattano e incrociano lo sguardo del bambino. L’Autore, allora, chiude il cerchio affermando che «nella prima è raffigurata come è uccisa una mente, nella seconda come nasce» (ibid.). Lo scenario si presenta subito assai controverso: davvero l’arte può raffigurare l’uccisione di una mente? e, nel caso, di quale mente?
Fin da subito, dunque, nel mentre mette sullo sfondo la Storia, Civitarese pone al centro della discussione alcune potenti suggestioni, sui destini primi e ultimi della mente. Ad altro, però, sembra riferirsi il titolo del libro “Perdere la testa”, così icastico ed evocativo, precisamente a ciò che può accadere ad una persona quando lascia spazio al fiorire di una passione. In una fitta rete di opzioni teoriche e culturali, Civitarese delinea appunto l’itinerario di una passione, certo la passione per l’arte, ma ancor più per il sognare dell’arte e sull’arte. In questo senso, però, occorre tenere presente che nello stesso titolo si può egualmente riconoscere anche l’opposto. Se perdere la testa è necessario per appassionarsi, anche un eccesso di passione può a sua volta far perdere la testa. La citazione dal critico Pierre Bayard «E’ possibile applicare la letteratura alla psicoanalisi?» (25; corsivo dell’Autore) mi sembra andare proprio in questa direzione, un po’ sovversiva e un po’ confusiva. I confini si fluidificano, i vettori s’invertono; e in questa colta e contagiosa rincorsa tra arte, sogno e psicoanalisi, al lettore, ma forse anche all’Autore, può persino accadere di essere colto da una vertigine da carenza di contenitore, e ciò proprio su un terreno in cui, tradizionalmente, la sua tenuta dovrebbe dare miglior prova di sé.
Ora, credo anche in rapporto a tale rischio che, nel primo capitolo del libro, “Per una (nuova) critica psicoanalitica”, in cui sono tracciati i lineamenti di una neo-disciplina, la «critica estetica psicoanalitica» (10, 13 e sg.), Civitarese e i suoi co-Autori, Boffito e Capello, ripropongono il tema della Storia. Pur ribadendo che l’arte va intesa come una «forma che coinvolge attivamente le strutture e i contenuti più profondi della nostra vita mentale», il loro primo quesito è: «Quale parte ha la Storia non solo nel progressivo determinarsi del giudizio estetico, ma nel più ampio progetto di rendere la psicoanalisi un valido strumento per la storia letteraria, oltre che un meta-storico reagente critico?» (14-15). Dopo quanto affermato nella “Premessa”, ora gli Autori riconsiderano che l’arte è anche, inevitabilmente, forma istoriata ed istoriante, laddove la Storia che vi si legge sia intesa anche con la s minuscola. Perciò, si pone loro, necessariamente, un’ulteriore questione, cioè la ricerca «di un equilibrio dialettico tra l’orizzonte della specificità storica, quello della forma artistica e delle sue strutture e, infine, quello della continua risemantizzazione retrospettiva, alla quale la storia e l’analisi formale […] sono inevitabilmente soggette» (16).
Ora, però, l’uso che gli Autori fanno del loro dispositivo non sempre garantisce tale equilibrio; e definendo la psicoanalisi come un “meta-storico reagente critico”, neppure sembrano avvertire la necessità di ottenerlo. A mio avviso, la tensione tra Storia e meta-Storia, tra indugio risemantizzante dell’interpretazione storica ed il suo continuo rilancio metastorico nell’onirico, ricade in modo vertiginoso sulla “critica psicoanalitica”. Gli Autori sono abitati da questa tensione, la cui resa euristica, però, non dipende appunto dalla realizzazione di un “equilibrio dialettico”, ma da come e quanto riescono a mettersela alle spalle e ad accelerare nella direzione di un diverso statuto, estetico e critico, della psicoanalisi. Qui, a mio parere, la meta-Storia inizia a prendere il sopravvento sulla S-s-toria. L’idea che l’esperienza estetica si strutturi sullo stesso dispositivo onirico che opera nell’esperienza clinica assume i tratti di un modello forte. Non a caso, tra gli psicoanalisti di riferimento, oltre a quelli più familiari, Bion, Grotstein, Ogden e Ferro, gli Autori annoverano subito anche Meltzer; ma non il Meltzer del “conflitto estetico”, cioè, per così dire, lo storico delle emozioni, di cui vedremo tra poco, bensì quello che già vede nell’analista-interprete del sogno un “critico teatrale” del dramma inscenato dall’analizzando nel momento in cui lo racconta (17) e che pensa che «i sogni non vanno spiegati, ma semmai interpretati con altri sogni, con altre forme simboliche» (19). Questa posizione, in cui il conflitto estetico cede il passo ad un conflitto drammaturgico, appare decisamente esposta in senso fenomenologico. Al riguardo, vorrei qui ricordare come anche Fausto Petrella, in La mente come teatro, usi la metafora teatrale, ma avendo cura di circoscrivere l’analogia tra mente e teatro a livello del loro funzionamento, proprio con l’intento di salvaguardare, con la psicoanalisi dell’inconscio, anche il punto di vista della S-s-toria.
Giocoforza, la metafora drammaturgica meltzeriana conduce alla figura dell’«analista-critico» (21), credo perciò in corrispondenza con quella di paziente-artista; entrambe accomunate, comunque, da un identico destino attoriale (direbbe Carmelo Bene), «attori sulla scena dell’analisi» che «danno vita ad una rappresentazione narrativa che appare “in continua costruzione↔decostruzione da parte di un drammaturgo interno”» (23, citazione da Grotstein). Qui giunti, gli Autori, ripresa l’immagine bioniana della “sonda” che espande il territorio che esplora (19), definiscono la reciproca inerenza tra arte, psicoanalisi ed esperienza estetica giustapponendo la metafora meltzeriana al modello grotsteiniano del dreaming ensemble, poi riformulato come «d-reading ensemble (leggere/read, sognare/dream e terrore/dread)» (22). Questo quasi-anagramma mi pare di particolare interesse. Esso evoca la persistenza, nell’esperienza estetica, di un roccioso residuo d’angoscia depressiva che, questa sì, chiama direttamente in causa il “conflitto estetico” meltzeriano (Meltzer, 1988), ed anche, aggiungono gli Autori, l’“abiezione” di Julia Kristeva. Come noto Meltzer, riferendosi alla caducità e irripetibilità dei vissuti della bellezza materna, coglie nell’evoluzione del bambino uno scarto estetico originario dalle conseguenze nostalgico/depressive. Non solo. Egli sembra anche indicarvi un livello primario dell’esperienza, che non solo non ha bisogno di essere sognato per non diventare patogeno, ma che avvicinerebbe all’idea di una funzione nostalgica della mente che tanta parte ha, a mio parere, nella sublimazione artistica. Cercherò tra poco di mostrare come, nella mia lettura, il “conflitto estetico” assuma nel libro una particolare configurazione. Già si può però ritenere che la prospettiva che ne trae Civitarese è volta a sancire l’assimilazione dello “psico-storico” (Sini, 1981) nell’onirico-estetico e a garantire, così, le funzioni metaboliche della “critica psicoanalitica”.
Ciò posto, nei sette saggi critici successivi Civitarese mette alla prova la “(nuova) critica psicoanalitica”. Nel primo, “Conflitto estetico ed abiezione nella (L)Isabetta del Boccaccio” (27), novella che ha come motivo il tema della decapitazione, si nota come attorno alla questione del significato, cioè della rilettura storica delle emozioni, si giochi la feconda (in)coerenza della neo-disciplina. La via sembra la liquidazione dei riferimenti ad angosce inconsce di natura depressiva (conflitto estetico) od orrorifica (abiezione), qui ricondotte le une direttamente alla morte (42), cioè all’insignificabile, le altre all’horror vacui (60-62), cioè al mancante di significato. Prima Civitarese riconosce nel vaso di basilico, in cui Lisabetta ha riposto la testa decapitata dell’innamorato Lorenzo, una funzione specifica dell’arte: «L’orrore è impensabile, ma l’arte gli dà un vaso, una pensabilità e lo trasforma in cibo per la mente. Quello che si produce è lo shock piacevole del recupero del significato lì dove sembrava di assistere all’insensato puro della morte» (41). Poi però precisa, in un certo senso correggendosi: «Il taglio della testa è il punto in cui convergono le linee di forza della novella: l’inconoscibilità dell’animo umano (cioè lo scandalo dell’ambivalenza affettiva, ovvero il conflitto estetico) qui s’intreccia con i limiti della conoscenza in generale del reale e della morte (l’abiezione secondo la Kristeva). Il testo espone così la sua verità, che è quella dell’inconoscibilità dell’enigma della morte» (42). Poco oltre, la contraddizione sembra risolversi proprio con la definitiva rinuncia al significato e, con esso, all’interpretazione: «Per capire il testo, bisogna non capirlo, accecarsi artificialmente» (43). La linea dell’accecamento si conferma, infine, anche all’inizio del capitolo successivo, il terzo, “Dal Vas Luxuriae al futurismo elettrico. Corrado Govoni a corrente alternata” (45), quando Civitarese rivendica le ragioni del proprio metodo, cioè concentrarsi «sugli specifici aspetti formali legati alla fruizione affettiva delle narrazioni» (46). In questi riconoscimenti, credo si colga bene come egli intenda il funzionamento del dispositivo onirico nell’esperienza estetica. Interpretazione e pensiero hanno preso a viaggiare su binari divergenti, l’una ha perduto ogni residuo di funzionalità per l’altro. La discussione si orienta sempre più ai temi del contenitore (individuale, gruppale, istituzionale e culturale) (46-49) e della sua tenuta (64-65), dell’equazione sogno↔pensiero, all’idea che il significato S-s-torico si ponga solo in quanto tra-ducibile in uno scenario onirico in continua espansione.
Nei capitoli dal quarto al settimo, la “critica psicoanalitica” si cimenta col testo cinematografico. I film in esame sono scelti con estrema cura e sensibilità, Nightmare detective di S. Tsukamoto, Persona di I. Bergman, Niente da nascondere di M. Haneke e Il servo di J. Losey; opere straordinarie che, complice una visionarietà in cui l’onirico sfocia spesso nell’(auto)ipnotico, ben si prestano a metterne alla prova il dispositivo. Questo passaggio dal testo letterario a quello cinematografico costituisce una testa di ponte per un ultimo balzo nel mondo dell’audiovisivo, precisamente in quello delle installazioni-video. L’ottavo e ultimo capitolo, “The Last Riot e le decollazioni stile deja vu dell’AES+F Group” (117), è dedicato infatti ad un’installazione che riprende il tema della decollazione. Sebbene non l’abbia vista personalmente, la vivida descrizione che ne fanno gli Autori mi consente alcune considerazioni sul significato complessivo di questo libro, che poi trovano conferma nell’ultimo paragrafo di questo stesso capitolo, dedicato al sogno di Hans Castorp ne La montagna magica di Thomas Mann, che con una torsione improvvisa, ma non casuale, ci riporta al testo letterario.
Il video, scomposto in tre schermi dislocati a semicerchio, presenta sullo sfondo scene di varia apocalisse, mentre in primo piano bellissimi giovani aspiranti tagliatesta, dallo sguardo fisso e imperturbabile, mimano, senza compierlo, il gesto della decollazione su altri giovani, anche loro egualmente impassibili. Nel corso di 19 minuti, la scena si ripete di continuo, secondo un palinsesto circolare che, arrestando e rinnovando la medesima narrazione, raffigura anche la rinuncia al punto di vista storico. Gli Autori, Civitarese e Boffito, giunti al limite estremo della sua estromissione («L’utopia di un’umanità senza tempo, colta nel momento del suo massimo fulgore, sembra essersi tramutata in un incubo terribile» (118), tornano allora a confrontarsi con la S-s-toria, perché «proprio per l’assenza della Storia, dispersa in una serie di eventi privi di senso e in un eterno e confuso presente, questa umanità sembra destinata a perire» (119). Il problema si pone qui in relazione alla mimesi ed alla ripetizione di un gesto, quello della decollazione, che nella visione degli Autori realizzerebbe una sorta d’impasse dell’onirico. A mio parere, tale arresto illumina retrospettivamente il significato di questo libro, che proprio dalla rinuncia alla S-s-toria e dall’enfasi sulla forma aveva preso le mosse.L’interrogativo è ancora quello anticipato all’inizio: l’impasse dell’onirico nella forma artistica esprime il punto di non-pensabilità cui è giunto il suo contenuto emozionale, come mi pare sostengano gli Autori, o è proprio ciò che ne apre la pensabilità nei termini dei suoi significati storici? In altri termini: la pensabilità dell’arte è affidata all’esperienza estetica del critico psicoanalitico, cioè si pone sul piano della meta-Storia, o si realizza già nella sua stessa forma, precisamente nel punto in cui la narrazione s’interrompe e la sua essenza mimetica si svela, ciò che allora ci riporterebbe direttamente al cuore della vecchia, ma ancora attuale, mimesis aristotelica? A mio parere, qui più che in precedenza la critica psicoanalitica mostra il proprio scacco ogni qualvolta concepisca l’arte non solo come una «trasformazione estetica» (121), ma anche come fenomeno istoriato ed istoriante, come rice-trasmittente della S-s-toria. Quest’ultima, infatti, resta l’argine cui fare appello ad ogni minaccia d’esondazione dell’onirico e di deriva dell’estetico. Senza di essa, il critico psicoanalitico può sempre trovarsi irretito nell’immagine onirica o nella sua declinazione “stile deja vu”, in modo simile a quanto accade al flaneur nella città moderna (Benjamin, 1927-40) o al situazionista nella Società dello Spettacolo (Debord, 1959). In questo senso, nulla più garantirebbe il discrimine tra esperienza estetica e piacere (auto)suggestivo e/o (auto)ipnotico.
Così, più che il deja vu, proprio l’impasse dell’onirico sembra costituire il filo conduttore che porta da The Last Riot al sogno-incubo di Hans Castorp (123). Indubbiamente, la lunga fantasticheria del protagonista sotto la tempesta di neve (124), che precede l’addormentamento, ben si presta alla “critica psicoanalitica”. Essa, tuttavia, culmina in due immagini che rievocano la premessa da cui Civitarese era partito: la prima, ancora nella veglia, una madre che allatta il proprio bambino; la seconda, il vero e proprio incubo, due donne laide e cannibali che, in un sacro tempio, fanno osceno bacchetto di un bambino piccolo. Qui gli Autori, per avvalorare il proprio dispositivo, riprendono un’osservazione dello stesso Thomas Mann, secondo cui il brusco e confortante risveglio da questo incubo non impedisce a Castorp di «seguitare a sognare … non più con immagini, ma con pensieri». Essi, però, omettono di completare la citazione: « … ma con pensieri che, in ogni caso, non erano meno rischiosi e arruffati» (Mann, 2010, 731). Solo sorvolando su questo aspetto insidioso e confusivo del sognare da svegli e omologando l’esperienza estetica prodotta dal testo letterario al sogno di un analista che prosegue quello del paziente dal punto della sua impasse onirica, gli Autori possono allora commentare l’incubo con le parole di Ogden, che sono pur sempre parole di un clinico: «Il sognare è interrotto in un punto in cui la capacità dell’individuo di generare pensieri onirici e di sognarli è travolta dagli effetti disturbanti dell’esperienza emotiva che viene sognata» (126). Proprio la domanda sulla funzione della forma nell’esperienza estetica, infatti, non è raccolta, né poteva esserlo, da queste parole: deriva, casualmente, dall’infinito mondo delle forme possibili, anch’essa “rischiosa e arruffata” come spesso accade nei sogni notturni, o mette appunto in questione una S-s-toria, dell’artista e del critico psicoanalitico?
Per concludere. Molto si trae dalla lettura di questo libro su una certa evoluzione del pensiero psicoanalitico contemporaneo. Si potrebbe dire che la misura dei problemi sollevati dalla “critica psicoanalitica” si coglie in ragione inversa 1) a quanto vi si riconosce in rilievo, pagina dopo pagina, il primato di un dispositivo ben preciso e, all’opposto, 2) a quanto il punto di vista della S-s-toria resista alla prova del suo utilizzo. Il testo è segnato profondamente da questa polarità, e ciò nel mentre rimane del tutto impregiudicata la possibilità di farla convergere in un nuovo e più avanzato “equilibrio dialettico”. Senza dare spazio a tale possibilità, ad ogni cambio di palinsesto non possono che risuonare gli stessi interrogativi: sogno come funzione della mente, e perciò meta-Storia, o come fenomeno psichico, e perciò S-s-toria? E, per altro verso: capogiro progressivo del sognare-pensare o vertigine regressiva dell’interpretazione? Davvero il pensiero onirico della veglia è sempre a tal punto vigile da inibire l’irruzione, in esso, di quello della notte e dei suoi depositi mnestici e traumatici non ancora sognati e non per questo necessariamente patogeni? Alla “critica psicoanalitica”, perciò, per esercitarsi realmente, non sembra sufficiente il d-reading ensemble, Civitarese lo sa e i suoi saggi lo mostrano. Le occorre anche una buona dose di “accecamento”, appunto sul ruolo della S-s-toria.
Così, “Perdere la testa” non sembra più riguardare neppure tale accecamento. Dietro le quinte della “critica psicoanalitica” s’insinua, irriducibile anch’essa come la S-s-toria, la vecchia “strega metapsicologica”. Civitarese stesso ne fa percepire l’insistenza attraverso l’iniziale riferimento ad uno degli ossimori freudiani epistemologicamente più complessi e fecondi, il “fantasticare metapsicologico” (17). E’, ritengo, con questo tipo di fantasticheria che ogni mente che pensi psicoanaliticamente, ancor più quando il suo pensare oltrepassa i confini dell’osservazione clinica, si trova di continuo fare i conti: l’embricarsi di continue aperture intuitive ed onirico/immaginative con i presidi forniti dalle teorie, dai modelli metapsicologici (tutti), dalla S-s-toria. In questo senso, la strega (o la tigre) metapsicologica si può più facilmente eludere o cavalcare che rendere operativa. L’alternativa mi sembra quello di un altro “accecamento”, che però, in tal caso, difficilmente risulterebbe altrettanto percorribile del precedente.
Maggio 2012
Bibliografia
Benjamin, W. (1927-40). I passages di Parigi. Einaudi, Torino, 2010.
Debord, G. (1957). Rapporto sulla costruzione delle situazioni. Nautilus, Torino, 1989.
Mann, T. (1924). La montagna magica. Mondadori, Milano, 2010.
Meltzer, D. (1988). Il conflitto estetico: il suo posto nel processo di sviluppo. In Amore e timore della bellezza. Borla, Roma.
Petrella, F. (2011). La mente come teatro. Edi-Ermes, Milano.
Sini, C. (1981). Passare il segno. Semiotica, cosmologia, tecnica. Il Saggiatore, Milano.
