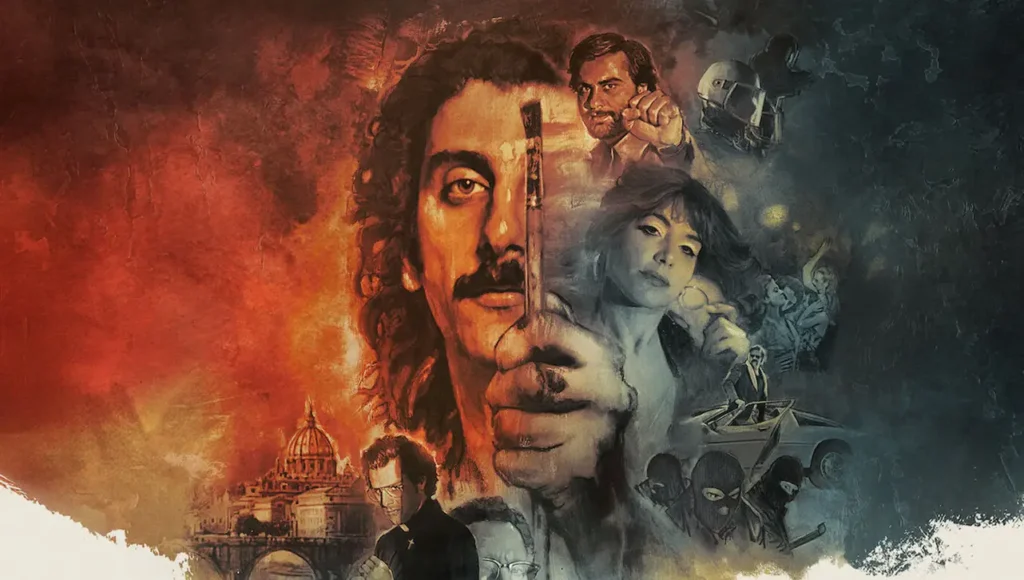Parole chiave: guerra, distruttività, infanzia
“Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini. Report di Alice Piacentini
All’interno del ciclo di proiezioni della rassegna cinematografica Cinemente, promossa dalla Società Psicoanalitica Italiana quest’anno dedicata al tema della distruttività, si è tenuta l’ultima serata del ciclo, attorno al film “Il Treno dei Bambini” di Cristina Comencini. La pellicola, ispirata al romanzo di Viola Ardone e tratta da una storia vera, è stata accompagnata dagli interventi di Fabio Castriota, Anna Maria Niccolò, Chiara Buoncristiani e della stessa regista Cristina Comencini, che ne hanno discusso le implicazioni storiche, sociali, psicoanalitiche.
“Il Treno dei bambini” è innanzitutto un film sulla durezza della guerra e della fame ma, anche, sulla forza delle relazioni affettive e sulla possibilità di sopravvivenza e di fioritura della capacità umane. Il racconto si ispira ad una vicenda storica: il Partito Comunista Italiano insieme all’Unione delle donne organizzarono la partenza di migliaia di bambini provenienti dalle città del sud, da Napoli e dai quartieri più poveri delle città martoriate dalla guerra permettendo loro di trascorrere la stagione invernale nell’Italia del nord, in provincia di Modena, ospitati da famiglie che aprirono le loro case e li accolsero.
Il film si svolge sul finire della guerra in una Napoli squassata dalla povertà e dalla lotta per la sopravvivenza: qui ci sono un bambino di otto anni, dal nome incantato di Amerigo Speranza e sua madre. La partenza e il viaggio, dopo il terrore fantasmatico di ritrovarsi nelle steppe siberiane o addirittura mangiati dai comunisti, aprirà ai bambini, e al nostro Amerigo con loro, un mondo altro: altri suoni, voci, luci e colori. Questo, tuttavia esporrà i bambini e le loro famiglie ad un conflitto tra l’appartenenza alle proprie origini e a un mondo piegato dalla necessità e l’ingresso in famiglie in grado di offrirgli nuovo nutrimento fisico e psichico.
Oltre a narrare il macrocosmo della spinta alla ricostruzione dopo la guerra in un clima in cui era ancora possibile una forma profonda di solidarietà, il film entra nell’universo intimo della spinta ad esistere e della determinazione di un bambino, che, pur abitando le molteplici forme del trauma, va a cercarsi e a prendersi la vita che può trovare, se ne nutre e non si arrende. Il film racconta inoltre la forza del femminile e delle diverse forme del materno, che poi sono forse una forma sola che contiene moltitudini: un materno disposto a lasciar andare sotto la spinta universale del desiderio di far stare meglio; un materno disposto ad accogliere e a scardinare il proprio assetto difensivo per lasciar entrare lo scatenarsi imprevedibile della vitalità.
Durante il dibattito, Anna Maria Niccolò ha evidenziato la ricchezza articolata e complessa del film, che si muove su livelli politici, storico-culturali e naturalmente psicologici: cosa significa essere madre? Nel film possiamo rintracciare, l’idea che la maternità non sia soltanto qualche cosa che una donna è in grado di dare con generosità, ma una relazione biunivoca e trasformativa, dove è possibile imparare a ripararsi reciprocamente. Al centro del film si pone poi, certo, la questione del trauma – afferma Niccolò, ma anche della capacità del protagonista di procedere oltre, animato com’è dalla determinazione e della speranza che il suo nome contiene.
Chiara Buoncristiani ha descritto il film come commovente, complesso e articolato, capace di rappresentare le ambivalenze dell’amore materno, il sogno e l’incubo di ogni madre: affidare a qualcun altro il proprio figlio perché se ne prenda cura forse meglio di come pensiamo di poter fare noi, il saper fare a meno dell’aspetto possessivo dell’amore materno. Ha posto poi l’accento sull’enigma della doppia madre che avvince immediatamente lo spettatore nella prima scena del film: crescere tra due madri, tradire la propria origine e diventare adulti, è un archetipo della soggettivazione: operare un distacco-tradimento delle proprie origini, “andare lontano”, salvo poi ritornare e riconoscerle lì dove si pensava fossero perse.
Cristina Comencini ha messo in luce il doppio registro del suo film: un livello privato, intimo, relazionale e uno politico nel quale si racconta la spinta per la ricostruzione subito dopo la guerra, quando per un gruppo di persone era semplicemente inaccettabile che dei bambini morissero di fame nel loro stesso paese. Dietro a tutto questo c’era un’utopia, la spinta a rifare un’Italia diversa, attraversata da un profondo senso di unità. La regista ha sottolineato come in quegli anni sia stata fatta una cosa straordinaria, ma ancora oggi l’ospitalità è un atto forte, che richiede un lavoro, un pensiero, uno slancio: “Se lo hanno fatto allora, significa che è possibile rifarlo”. Intrecciato al tema politico, viene affrontato il tema più intimo della cura femminile e materna, vengono rappresentati due modi diversi di essere madre: l’amore materno è quello che consente di dare il figlio in adozione a qualcun altro, ma è anche l’amore che si impara e si costruisce. Il lavoro della madre è eroico, è quello di dare tutto, per poi lasciare andare.
Dal pubblico è stata rilevata l’assenza del maschile nel film. Cristina Comencini risponde che quella raccontata è una storia per lo più fatta dalle donne, che ne sono le protagoniste: “Ne abbiamo il diritto!”. L’amore per gli uomini, nondimeno, sta nella figura del “padre del Nord”, padre stupendo e in Amerigo stesso, bambino intelligente e bellissimo.
Il dibattito si è infine concluso riflettendo insieme sul “principio” femminile e sulla sua potenzialità salvifica. Fabio Castriota ha posto una domanda che a suo parere ha percorso tutte le serate della rassegna: forse, di fronte alla distruttività, le donne possono salvarci? Non il femminile nel suo aspetto biologico, bensì i funzionamenti femminili presenti anche nell’universo psichico maschile? Possiamo immaginare che il mondo possa essere salvato da un principio femminile? Nella sua risposta, Cristina Comencini sottolinea come quello della donna sia un pensiero sempre incarnato nel corpo e come questo sia un elemento centrale: il corpo ha una consueta e naturale dimestichezza con la nascita, con la morte e con il prendersi cura. Quando Heidegger sosteneva che noi, come esseri umani, siamo gettati nel mondo, Hannah Arendt gli rispondeva che noi piuttosto nasciamo nel mondo e questo cambia tutto: abbiamo un’origine che passa attraverso il corpo, c’è un primo cominciamento e la presenza dell’inizio cambia necessariamente le carte in tavola, così come cambia anche la fine.
“Il Treno dei bambini” ha offerto una prospettiva diversa sul tema della distruttività, mostrando come dalla devastazione della guerra possa nascere una forma di resistenza e ricostruzione profondamente umana. Il film diventa così non solo il racconto di un’Italia che sa ancora prendersi cura dei suoi bambini, ma anche la metafora di una possibilità trasformativa che, attraverso l’accoglienza e la cura, permetta una rinascita tanto individuale e intima, quanto collettiva.