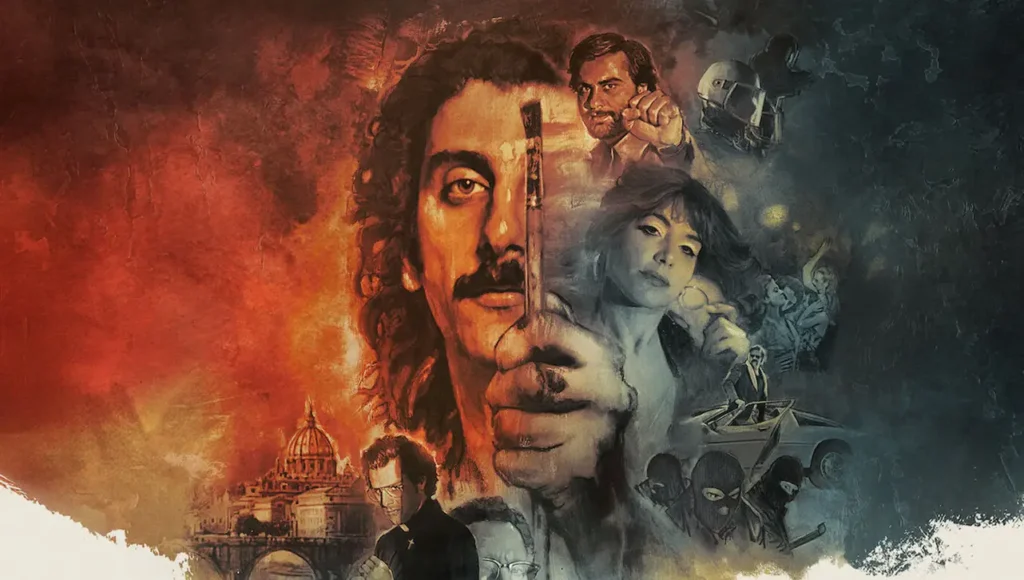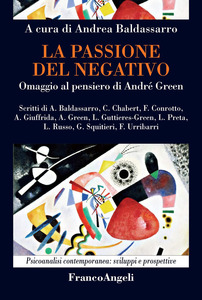Parole chiave: trauma, lavoro del negativo, cinema e psicoanalisi
Autore: Ludovica Blandino
Titolo: “Amanda”
Dati: regia di Carolina Cavalli, Italia, 1h34m
Genere: commedia
È un mondo povero di vicinanza emotiva, condivisione, autenticità, quello presentato dal film “Amanda”, esordio alla regia di Carolina Cavalli. La pellicola, in concorso a Venezia nel 2022, ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento e 3 candidature al David di Donatello.
Questa giovane donna venticinquenne, interpretata da Benedetta Porcaroli, è intrappolata in una condizione di isolamento relazionale ed è alla disperata ricerca di un affetto che non è in grado di trovare in primis nella famiglia e poi nel mondo che la circonda. Amanda vorrebbe tanto sentirsi amata e cerca disperatamente di colmare un vuoto interno (Khout, 1971) che si accompagna a un sentimento di abbandono e a un vissuto di estraneità che permeano la sua esistenza.
La famiglia di origine appartiene a una borghesia dove ciò che conta massimamente è la formalità, i rapporti risultano dunque superficiali e distanti e i membri sono lontani e depressi, sicuramente incapaci di fornire contenimento emotivo. Amanda è circondata da relazioni che falliscono nel trasmettere calore e appartenenza: la madre in silenzio, da sola, guarda il nulla fuori dalla finestra, la sorella è ostile e la nipote presa da una ossessione religiosa per Gesù che reputa una “bella persona”. Emblematica la scena in cui la protagonista chiama il negozio “Emilio elettrico” per vendere un ventilatore e si emoziona quando scopre di parlare con Emilio in persona, come se si fosse concretizzata la possibilità di un incontro reale e autentico con qualcuno di irraggiungibile e robotico.
L’unica figura di accudimento, già nell’infanzia, sembra essere la domestica peruviana che la salva da un bizzarro tentativo di suicidio, e con la quale si è instaurata una relazione autentica. È con lei che Amanda a volte esce, andando ai rave party.
Il film a tratti vira verso atmosfere più pop e quasi iperrealistiche, mentre l’ironia e il tono surreale e straniante con cui viene rappresentato ciò che accade, oltre ad essere una cifra stilistica, servono forse a mitigare difensivamente la drammaticità che sottende le vite dei personaggi. La protagonista, che vive nella stanza di uno squallido albergo con la scritta al neon, sembra uscire da un quadro di Hopper, veste in modo anacronistico e sembra bloccata in un luogo fuori dal tempo; anche su questo “essere fuori dal tempo” la regista lavora presentandoci a volte scene che sembrano, tanto nella fotografia quanto nei costumi, proporsi come immagini di un’opera d’antan.
Amanda potrebbe lavorare in una delle farmacie di proprietà della sua famiglia o comunque dovrebbe trovare un qualche scopo nella vita, sistemarsi, magari trovare un ragazzo, ma questo risulta particolarmente difficile. Tutto sembra fermo, finchè non compare sulla scena Rebecca.
Anche quest’ultima ha un vissuto simile a quello di Amanda e un contesto famigliare più o meno analogo anche se, a differenza di lei, si è oramai chiusa nella sua stanza e non permette a nessuno di entrarvi. Ad un certo punto Rebecca le dirà che per fare fronte alla vita e, forse, al terribile vuoto e solitudine “Devi allenare la tua capacità di essere costantemente da un’altra parte”, come fa lei che per ore sta sdraiata, ferma, sotto il letto, da sola.
Amanda inizialmente resiste ai rifiuti di Rebecca perché ha molto bisogno di instaurare una relazione che vada al di là della formalità, nel tentativo disperato di stabilire un legame laddove l’esperienza primaria è stata quella di abbandono e di freddezza, finchè con un escamotage riesce a creare un contatto con l’amica.
Il cavallo vecchio ed emarginato che Amanda ad un certo punto ruba da una cascina sembra rappresentare il tentativo di inserire un elemento vitale e istintuale nella sua vita e il suo gesto di lasciarlo nel giardino della casa-mausoleo di Rebecca sembra un modo per rivitalizzare una situazione ferma e mortifera.
In conclusione, il film sembra muoversi nei canoni di una teen-movie con l’unico distinguo dell’età: a venticinque anni essere considerati degli adolescenti è difficile. Tutto ciò, dunque, rappresenta forse una descrizione della condizione di alcuni giovani adulti contemporanei: apparentemente liberi, ma in realtà prigionieri di un vuoto profondo che li rende incapaci di crescere e instaurare relazioni, di evolvere. La regia di Cavalli sembra dunque mettere in scena una clinica del vuoto (Green, 2002), offrendo al cinema contemporaneo un ritratto del disagio psichico della nostra epoca, dell’incapacità di stabilire legami significativi e della difficoltà che caratterizza l’ingresso nella vita adulta.
Bibliografia
Khout H. (1971). Narcisismo e analisi del Sé. Bollati Boringhieri, Torino, 1976
Green A. (2022). La clinica del negativo. Franco Angeli, Milano, 2023