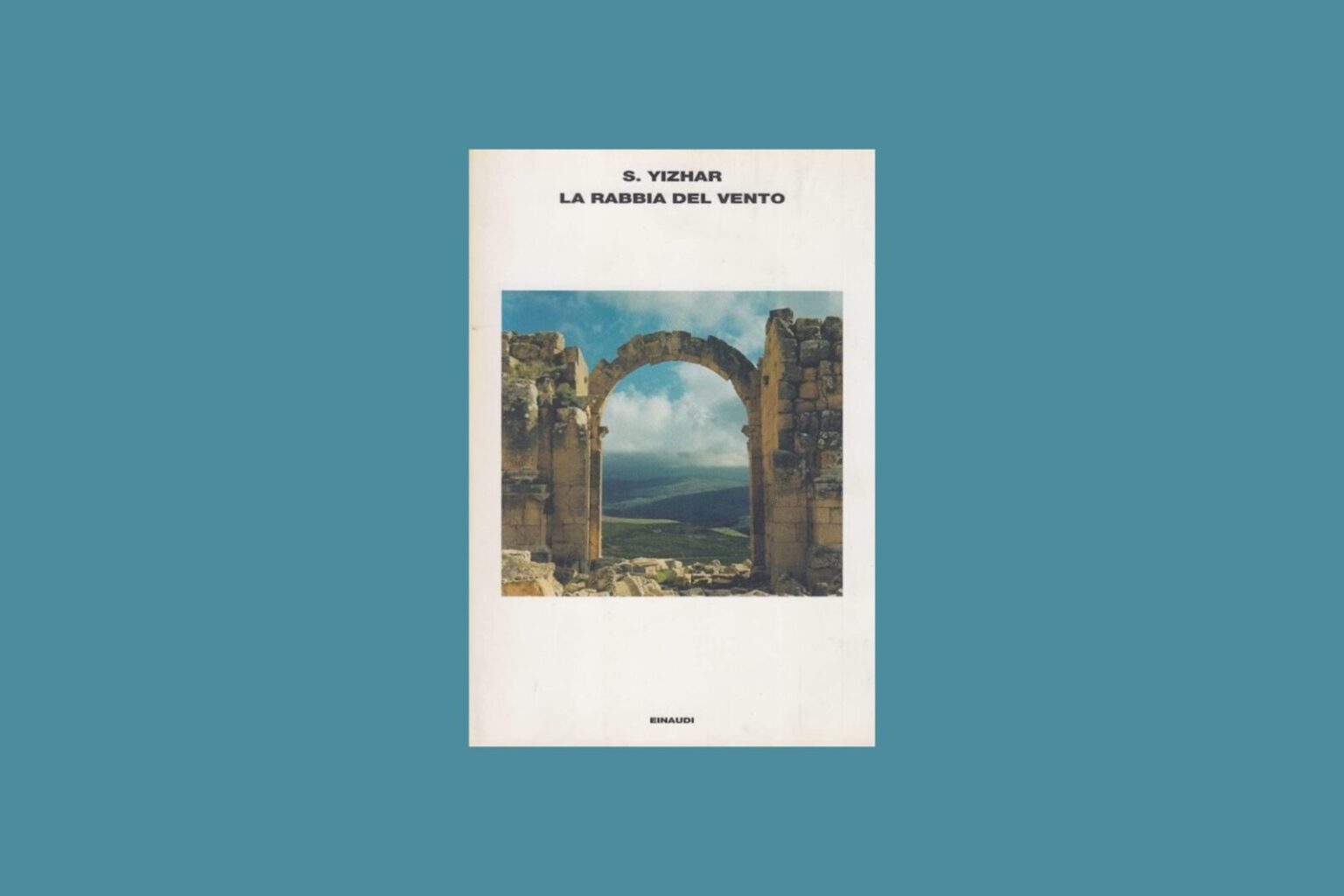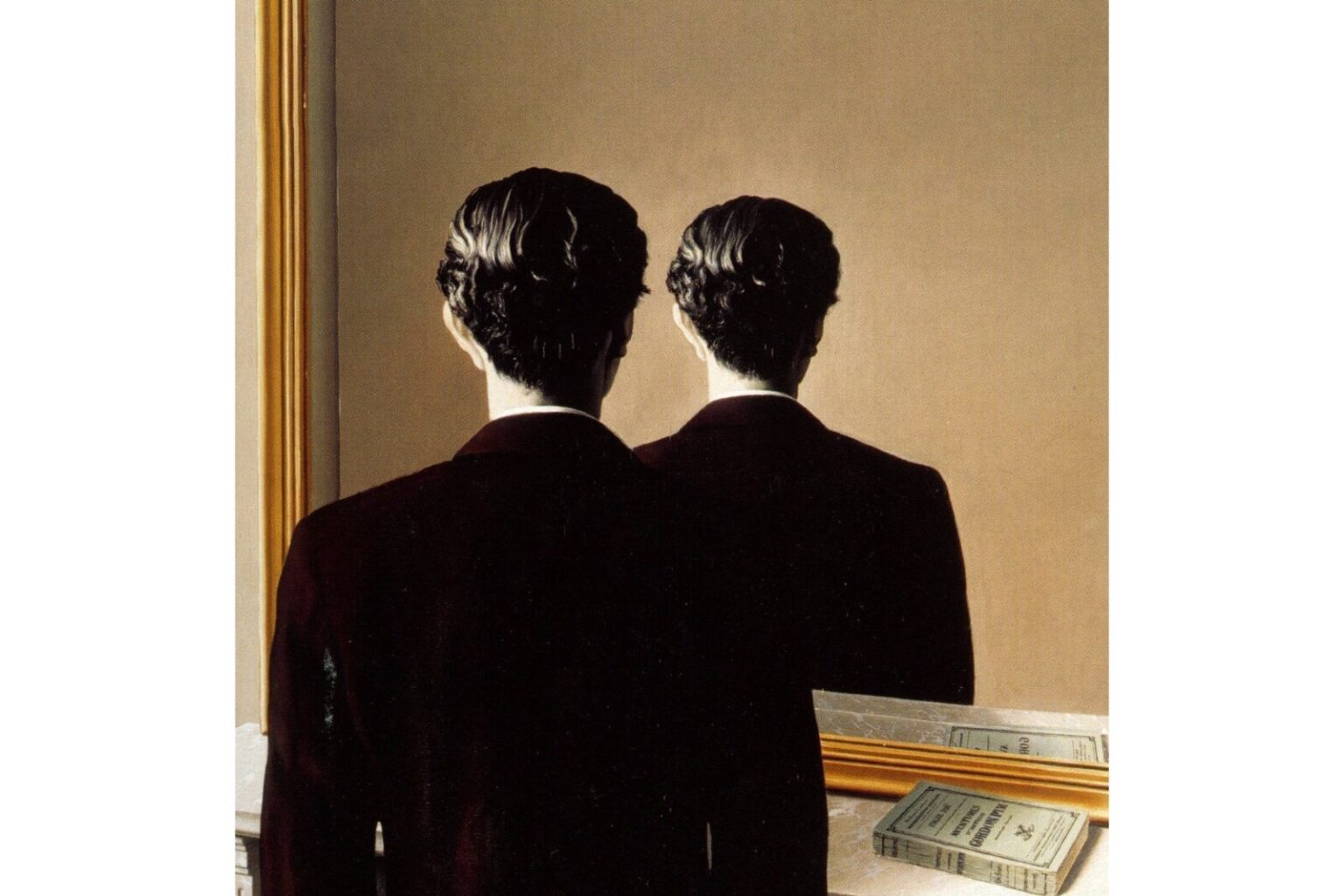Parole chiave: Dolore, Disagio psichico, Diagnosi, Stigma, Desiderio
Nel suo intervento sull’Huffington Post del 14 novembre 2025, Sarantis Thanopulos indaga le nuove forme del disagio psichico nella contemporaneità, segnate da un preoccupante processo di anestesia del dolore emotivo. L’autore denuncia l’eclissi della sofferenza come luogo di esperienza e significazione, tra diagnostica semplificata, rifiuto del pathos e crescente violenza dell’agire.
Il disagio psichico nella contemporaneità
Sarantis Thanopulos
Da tempo ci si interroga sulle nuove forme del disagio psichico nella contemporaneità. In realtà, la sofferenza umana nelle su varie configurazioni è rimasta inalterata nella sostanza, al di là dell’ovvia correlazione delle modalità della sua lettura e diagnosi, nonché della prevalenza di questa o di quell’altra forma sulle altre, con il contesto storico e sociale in cui essa si colloca. Il fenomeno diffuso davvero nuovo (che dovrebbe destare grande preoccupazione) è la dissoluzione della sofferenza che fa diventare il disagio muto, inodore, invisibile. Il dolore non sentito e non concepito può manifestarsi solo sotto forma di un agire violento distruttivo e autodistruttivo.
Il rifiuto del dolore è un fatto generalizzato. Il benessere psichico è identificato con l’assenza di tensioni e il godimento con il sollievo. La nostra epoca è molto lontana dalla concezione del patire come conoscenza della vita (Eschilo), sta perdendo la consapevolezza del legame necessario tra il soffrire e il piacere del vivere. Il dolore ci destabilizza e ci scoraggia, ma è anche la misura più affidabile del valore delle cose che amiamo e dei limiti che poniamo al nostro agire per proteggerle. Mantiene vivo il desiderio nei suoi momenti di sventura e lo orienta nella strada del suo riscatto, lo rimette in movimento.
Non possiamo godere di nulla se non rispettiamo il suo idioma, il suo modo di essere, ma la consapevolezza di ciò prende forma, tutte le volte che il nostro desiderio sconfina nell’ onnipotenza, attraverso un dolore in cui frustrazione, rabbia, compassione e preoccupazione coesistono. Non si può in alcun modo pretendere che si accetti il dolore come educazione al vivere: quando è troppo forte, insistente e diventa scoramento profondo o angoscia, è umano cercare di calmarlo, diluirlo. Tuttavia, lenire il dolore è molto diverso dall’anestesia permanente, dalla sua espulsione dalla nostra vita.
Una delle censure attuali del pathos ha un’origine paradossale: viene dall’opposizione allo “stigma”, la discriminazione di cui sono vittime le persone sofferenti considerate devianti e costitutivamente inferiori alle altre. Lo sforzo per il superamento dello “stigma”, che stabilisce una disparità impropria e aggiunge sofferenza alla sofferenza, ha smarrito, in una sua parte, la prospettiva basagliana: il diritto alla piena cittadinanza con, nonostante e oltre la propria sofferenza. È rimasto intrappolato in una cancellazione mistificante della differenza tra soffrire e non soffrire e ha finito per stigmatizzare il dolore.
Concorre all’esorcizzazione del malessere umano -nelle sue forme più persistenti e destabilizzanti e in quelle più legate all’ “infelicità della vita quotidiana” (Freud)- la diagnosi, la più diffusa delle malattie come la definiva più di un secolo fa Karl Kraus. Sempre di più la diagnosi della “malattia”, soprattutto nel campo psichiatrico, diventa un guscio vuoto in cui il “malato” è ingabbiato. Invano i medici più avveduti sul piano epistemologico (è sempre più in difficoltà di fronte al tecnicismo) avvertono che non esistono le “malattie” ma i “malati”, affermando la singolarità di ogni caso clinico. Nella semiologia medica e psicoterapeutica i sintomi dovrebbero rappresentare il visibile che rinvia al non visibile di una sofferenza che fa parte di una storia e costituzione personale. Questa sofferenza si può cogliere solo attraverso inferenze complesse richiedenti attenzione e ampiezza dello sguardo (rivolte sia all’insieme sia ai dettagli del quadro clinico) e conoscenza capace di apprendere dall’esperienza e dall’imprevisto. Oggigiorno si preferisce procedere sulla strada di un agire concreto, che punta tutto su ciò che effettivamente si vede, ma perde ciò che non si dona allo sguardo ad occhi aperti e esige, invece, una visione intuitiva.
L’eclissi della semiologia, prigioniera dei dispositivi diagnostici visivi (a cui l’intelligenza artificiale dà man forte), ha effetti molto negativi nascosti dall’impressionante impatto della tecnica sulle terapie mediche. La tecnica medica risolve molto meglio che nel passato tutto quello che fa parte del già conosciuto, ma non fa nessun passo in avanti nella conquista di nuove visioni dell’organismo umano (e della sua complessa costituzione psicofisica) capaci di ampliare il sapere medico senza il bisogno di vedere, toccare per credere, per legittimarle. Più ci si affida all’esteriorizzazione della sofferenza (a ciò che di essa è toccabile con le mani) più la sofferenza fisica prende il sopravvento sulla sofferenza psichica. Nelle malattie del corpo la componente affettiva del dolore è solitamente ignorata e nella cura delle malattie dell’anima avanza la pretesa di ridurle in malattie organiche da trattare (eliminando il dolore) con terapie puramente mediche. La tendenza a combattere ogni forma del dolore come se fosse sofferenza somatica rende il disagio emotivo incomprensibile. È frequente la tendenza a spiegarselo identificandosi con una definizione del proprio malessere descrittiva che agisce come tranquillizzante: la diagnosi diventa una condizione da condividere con tanti altri, uno stato “neurodivergente” dell’esistenza con cui imparare a convivere.
La spinta a eliminare il dolore psichico è del tutto coerente con una società precaria e instabile che scoraggia l’elaborazione della sofferenza come strumento di crescita. Massimo Recalcati ha parlato diversi anni fa di “clinica del vuoto” per definire la sfida che rappresentava per la cura psichica la diffusione allarmante dell’anoressia. Ha centrato la sua attenzione sul diniego del lutto da parte dei soggetti anoressici, più precisamente sul diniego del desiderio per l’altro che rende superfluo il lutto della sua perdita. Il vuoto anoressico dell’altro, dentro e fuori di sé, è comunque doloroso. Nell’anoressia del vivere (un malessere esteso ben al di là dei confini del “disturbo alimentare”) il diniego del proprio desiderio crea un senso di deprivazione che l’austerità estrema dell’assetto psichico non riesce a contenere.
Ciò a cui assistiamo oggi va oltre: uno svuotamento psichico elimina insieme alle emozioni anche la sofferenza che la loro assenza dovrebbe provocare. Esso agisce come anestesia preventiva, come eclissi di sé che rende il soggetto inaccessibile alla frustrazione e alla perdita. In casi estremi l’estraneità anestetizzante a sé stessi diventa una pentola a pressione in attesa di una deflagrazione. Il più delle volte è la fonte di un’inquietudine e di un’irrequietezza diffusa, soprattutto tra i giovani, che non accede a una consapevolezza del proprio malessere e a una vera domanda di cura, sfociando nella violenza. Penetra comunque in tutte le forme di sofferenza riconosciuta designificandole e complicandone decisamente la cura.