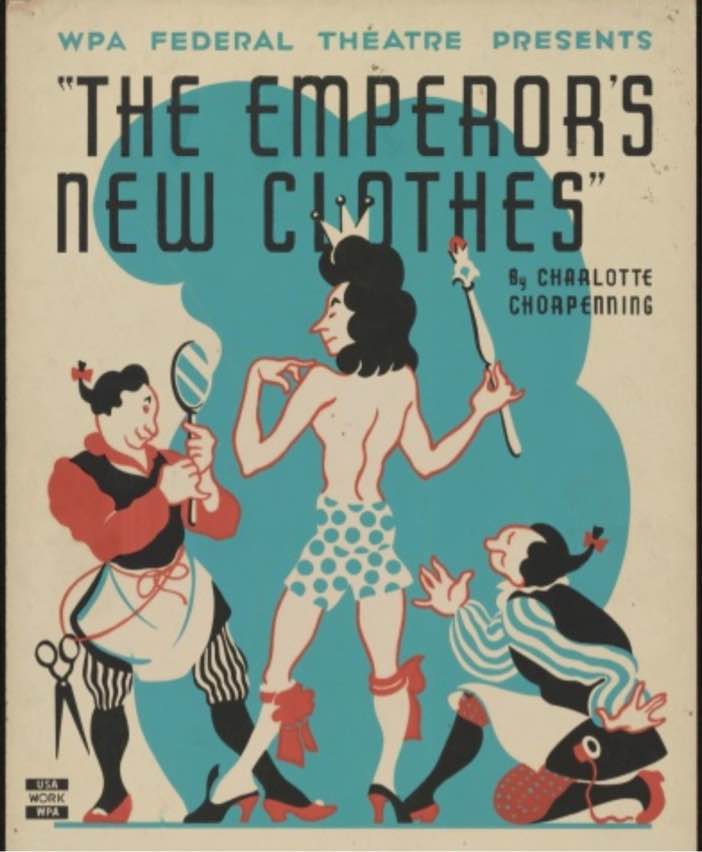
Parole chiave: conflitto, inconscio, sovranità, molteplicità, libertà
“No kings” e l’inconscio politico di una nazione
Di Chiara Buoncristiani e Tommaso Romani
Qualcosa di elettrico, febbrile nell’aria americana, come un ronzio di fondo che ha attraversato gli schermi, i megafoni, le strade e i corpi. “No Kings”, gridavano in milioni: cartelli scritti a mano, bandiere improvvisate, cartelloni appesi ai balconi. Nelle piazze di Washington, Boston e New York si sono visti bambini sulle spalle dei genitori, studenti che cantavano, lavoratori che marciavano accanto a veterani e insegnanti. A Los Angeles, una lunga catena umana si è formata lungo i Boulevard; a Chicago i manifestanti sono scesi nelle strade con cartelli come “Niente è più patriottico che protestare” o “Resistete al fascismo”, per strada c’erano anche bande musicali, un enorme striscione con il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti “We The People”. In molti quartieri campeggia ormai la scritta No Kings. È una protesta contro l’idea stessa di sovranità incarnata, contro il ritorno — reale o simbolico — di un potere personale che pretende di farsi destino collettivo. Ma si può fare l’ipotesi si tratti di un fenomeno più profondo: in America il termine King non ha infatti la stessa risonanza che ha in Europa. In Usa non evoca corone o genealogie nobiliari: è un segno arcaico, quasi mitico, fondante, che torna a pulsare nella memoria di un paese nato proprio contro un re.
L’America non ha mai avuto un’aristocrazia nel senso europeo del termine. Non ha castelli medievali, né un’araldica tramandata nei secoli. Eppure, come ha detto il politico Bernie Sanders nel suo discorso a Washington, la parola King tocca il cuore della coscienza americana, lo strappo originario su cui è stata edificata la prima democrazia moderna: la ribellione contro l’Inghilterra, contro la monarchia, contro il colonialismo. È un significante fondatore che potremmo leggere come un trauma originario che ritorna. Quando i manifestanti gridano “No Kings”, non si limitano quindi a contestare un uomo o un governo: evocano il fantasma del colonialismo, il ritorno di un potere che si pensa assoluto, di una figura paterna che pretende obbedienza. È il rovescio della Rivoluzione americana, un cortocircuito storico che, nel 2025, riemerge come eco dell’inconscio politico di una nazione.
A nessuno sarebbe parso plausibile, fino a poco tempo fa, che il linguaggio della monarchia potesse riaffiorare nel cuore della democrazia americana. Eppure eccolo qui, come se il re fosse tornato in forma di immagine, di gesto, di promessa. Immagini che spesso non vediamo nelle televisioni tradizionali, nei telegiornali “allineati”. È più facile trovarle sui social. Come se questi spazi, seppur fagocitati ormai dal capitalismo dei dati e delle profilazioni, non riuscissero mai del tutto a far rientrare nelle logiche dell’algoritmo le pieghe ramificate e caotiche della rete.
Forse anche per questo, scorrendo quelle immagini, viene in mente la psicoanalisi. E una domanda. Può il nostro discorso vivere in una dittatura? Può esistere una pratica della parola dove la parola è sorvegliata, filtrata, censurata? La risposta è storicamente verificabile. La psicoanalisi non sopravvive bene nei regimi totalitari. Non lo fece nella Germania nazista, dove Freud vide bruciare i propri libri. Non prospera oggi nei paesi governati da satrapie digitali o tecnocrazie paternalistiche. Perché la psicoanalisi, qualunque sia il suo destino istituzionale, presuppone una sola condizione essenziale: la libertà di parola.
Ma non una libertà generica, di stampa o di espressione. Parliamo della libertà più vertiginosa: quella di dire qualunque cosa, anche ciò che non si sa di voler dire. La libertà di contraddirsi, di mentire, di desiderare. La libertà di scoprire dentro di sé non un sé unitario, ma una scissione. È qui che la psicoanalisi diventa radicalmente incompatibile con ogni forma di potere totalitario. Perché dove c’è un Re, lì si suppone un soggetto intero, una volontà unica, un comando che si estende sul mondo come un sistema simbolico compatto. La psicoanalisi, al contrario, parte dal presupposto che l’essere umano sia plurale, attraversato dal conflitto, abitato dall’inconscio, sempre in trasformazione.
Freud lo intuì nella Vienna borghese, quando scriveva che l’Io “non è padrone in casa propria”. È questa la vera rivoluzione della psicoanalisi, la sua forza politica: affermare che nessuno è Re di se stesso. Che l’idea di una sovranità interiore — un Sé che governa, un Io che decide — è una finzione. E che proprio da questa finzione nasce la possibilità di libertà.
D’altra parte, nella psicoanalisi, si sta avviando una riflessione profonda sui mutamenti degli ultimi decenni. Riflessione su una dimensione storica e collettiva tanto più urgente in quanto tali mutamenti vivono oggi una fase di grande accelerazione. E tanto più necessaria anche in quanto la dimensione collettiva abita e dà forma ai nostri fantasmi. La psicoanalisi trarrebbe un grande giovamento da un confronto aperto e coraggioso degli avvenimenti del mondo dal ’68 in poi. E non si limiterebbe a una nostalgica constatazione della mancanza di padri o di certezze. Anzi. Sono tanti i fattori che hanno concorso ad un offuscamento del centro, del principio assoluto che tutto muove. Non è detto che sia un male. È un movimento che ha creato molto spazio ad un pensiero delle differenze e della molteplicità, ma che al tempo stesso ha ingenerato anche grandi angosce di frammentazione. Il bisogno identitario, visibile un po’ ovunque, non è altro che questo e diviene prêt-à-porter incontrando l’attuale fase del mercato globalizzato, dove i colossi informatici estraggono dati dagli individui e vendono loro identità e senso di appartenenza. Chi sente di essere fuori da questo mercato non potrà che rifugiarsi nella figura del re. E allora… Viva il re. Abbasso il re.
Una possibile pista da esplorare è nel pensiero del filosofo Giorgio Agamben. Nelle sue analisi sul concetto di sovranità, Agamben mostra come il potere si fondi su una sospensione: il sovrano è colui che decide sullo stato d’eccezione, cioè su chi può essere incluso o escluso dalla legge. Ma questa logica del confine — del dentro e del fuori, del cittadino e dell’homo sacer — è la stessa che agisce dentro la psiche, tra l’Io e il suo rimosso, tra il sé e le sue parti dissociate. La dittatura politica è l’esternalizzazione di una dittatura interna, quella che pretende di eliminare il conflitto e i tentativi di integrazione. Ecco perché la psicoanalisi, in fondo, è sempre una forma di resistenza: perché custodisce la scissione come spazio vitale, la mette in movimento, perché difende il diritto a non coincidere con se stessi.
Le manifestazioni No Kings non parlano soltanto di politica. Fanno parlare — nel senso più letterale — l’inconscio. Sono il sintomo collettivo di una civiltà che teme il ritorno del Padre, del Capo, dell’Unico. Un’America che aveva costruito la propria identità sulla pluralità, sull’iniziativa individuale e collettiva, sulla molteplicità dei mondi, si ritrova ora di fronte alla propria ombra. La pluralità che un tempo era la sua forza si è trasformata in disorientamento, e la richiesta di un “Re” appare come il tentativo di ricomporre, con la forza dell’identificazione, ciò che l’angoscia della frammentazione ha reso instabile. Le piazze colme di voci e cartelli sono allora il teatro di un doppio movimento: da un lato il rifiuto del potere assoluto, ma dall’altro fanno paura a molti, la paura di vivere senza un principio unificante. È in questa tensione che si misura la maturità democratica di una civiltà: nella capacità di sopportare la divisione, di riconoscere che la libertà non si eredita, ma si reinventa continuamente.
Uno dei cartelli più significativi era portato in alto da un ragazzo. Sopra la scritta “mio nonno ha combattuto il fascismo. Ora tocca a me”.
