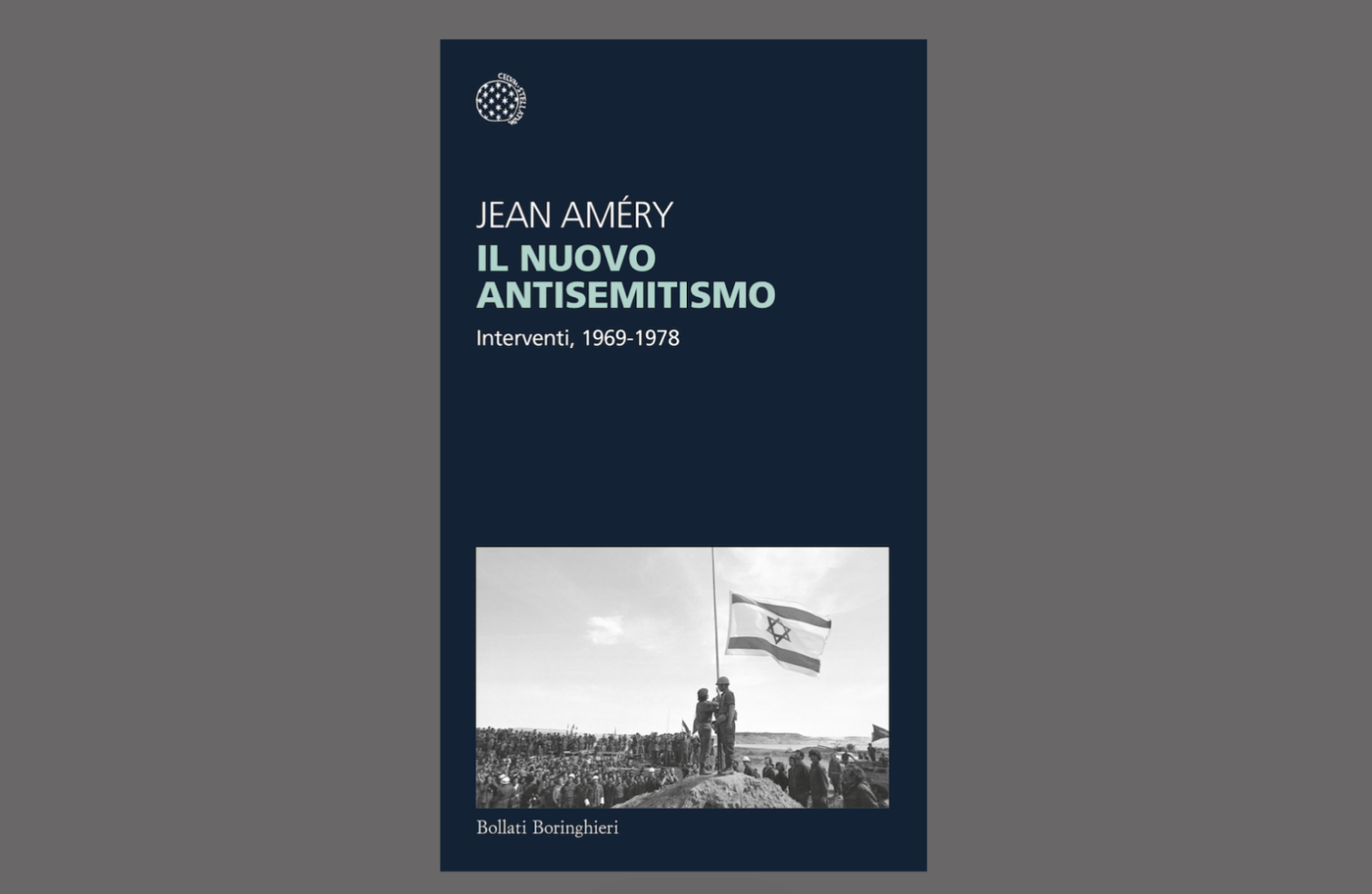Parole chiave: doppio, perturbante, autoritratto, scissione, selfie
Riflessioni in margine alla mostra
NELLO SPECCHIO DI NARCISO – IL RITRATTO DELL’ARTISTA – IL VOLTO, LA MASCHERA, IL SELFIE
Forlì, Musei San Domenico, 23/2 – 29/6/2025
IL DOPPIO E IL PERTURBANTE DA EURIPIDE A VAN GOGH
Di Pierluigi Moressa
“Pensavo che l’ombra dell’uomo fosse la sua vanità.”
(Friedrich Nietzsche, Il viandante e la sua ombra, 1886)
La figura di Elena è protagonista di molte varianti del mito e della tradizione poetica. Indicata da popoli diversi col nome di “Afrodite straniera”, incarna l’ideale di una bellezza fonte di ammirazione universale e di una vicenda mutevole e tormentosa. Così, la perfezione di Elena diviene metafora di uno stato capace di esporla al pericolo e al desiderio, alla lode e all’invidia, come affermano le donne troiane nel III libro dell’Iliade: Elena, simile alle dee immortali, è fonte di pericolo e causa di una guerra terribile. La sua presenza assume alternativamente tratti idealizzati e persecutori, stato di cui lei stessa finisce per dolersi come di un avverso destino. L’identità di Elena trae fondamento non solo dalla bellezza, ma anche da qualità al confine col mondo soprannaturale. Famosa è la variante del mito che le assegna una doppia identità. Accanto ai tratti della sposa infedele di Menelao, compaiono quelli del “doppio”, di un eidolon, simulacro per il quale Greci e Troiani si sono battuti durante dieci anni. Il tema, narrato da Erodoto nelle Storie e cantato da Stesicoro con la Palinodia, ripreso da Saffo in un celebre componimento, citato da Platone entro il Fedro e la Repubblica, da Isocrate, Aristofane e numerosi altri, non si disgiunge dalle attribuzioni di bellezza a Elena, oggetto di brame erotiche e insieme simbolo di una femminilità destinata a non lasciare alcuno indifferente.
Euripide porta in scena, con la tragedia “Elena”, il turbamento dovuto al confronto tra la protagonista e il suo simulacro. La vera Elena non si è mai recata a Troia, perché il dio Ermes ha creato il suo “doppio”: un fantasma realizzato con un pezzo di cielo. Questo è andato a Troia con Paride, mentre la donna reale è rimasta segretamente in Egitto presso il re Proteo. Alla morte del sovrano, Elena viene insidiata dall’erede, Teoclimeno, mentre giunge il falso annuncio che Menelao è morto in mare. In realtà, il re di Sparta ha fatto naufragio in Egitto, portando con sé l’eidolon della propria moglie, creduto la vera Elena. L’arrivo di Menelao al palazzo gli consente di incontrare realmente la sua sposa, mentre il simulacro scompare. Tutto gli è chiaro; insieme partiranno per Sparta, grazie a uno stratagemma che consentirà loro di sfuggire al controllo di Teoclimeno.
Da donna seduttiva e adultera a sposa fedele e innamorata: gli opposti attributi di Elena impongono una revisione e un distanziamento dal tema omerico della bellezza come causa di gravi distruzioni e di infinite avversità anche per le generazioni future. Il testo di Euripide sovverte anche la concezione eschilea di Elena, espressa nella tragedia “Agamennone” e si differenzia anche dal tema introdotto dallo stesso Euripide nelle “Troiane”, attraverso il confronto fra la sposa di Menelao e la tragica presenza di Ecuba. La suggestione del mito acquista caratteri ancora più perturbanti, seguendo la tradizione per cui Stesicoro, dopo essere stato accecato dall’intervento soprannaturale della donna, divenuta ormai dea e offesa per essere stata da lui presentata come adultera entro una prima versione del testo, avrebbe concepito un nuovo componimento dedicato a Elena (Palinodia), basandosi sulla versione sostenuta da Esiodo e sulla presenza del simulacro.
Il problema della colpa di Elena dovrebbe annullarsi nella tragedia euripidea. Una fama negativa continuerà, invece, a perseguitarla. La donna patisce, infatti, un sentimento doloroso per le conseguenze del comportamento del proprio doppio. Sua madre Leda si è tolta la vita, a un simile destino, secondo una variante dei racconti tradizionali, hanno dovuto soccombere i suoi due fratelli: Castore e Polluce. La figlia Ermione rimane senza marito né prole e piange per le nozze di sua madre, “che non erano nozze”. Tali sentimenti rispecchiano i riflessi di ciò che Eric Dodds chiama la “civiltà della vergogna”. Secondo questo stato mentale appartenente all’epoca arcaica, l’individuo attribuisce un valore di realtà oggettiva a ciò che gli altri pensano di lui. Allo stesso modo, non è il timore degli dèi a guidare le azioni del soggetto, ma il rispetto dell’opinione pubblica. Nel personaggio di Elena, il nome e una fama (kléos) ambivalente coincidono; entro questa scissione tra identità reale e nominale si sviluppa il dramma della protagonista. Si può anche affermare che un aspetto della dicotomia tra realtà e raffigurazione nasce dal modo in cui il pensiero greco ha affrontato le caratteristiche del doppio, per cui l’eidolon diviene non una semplice immagine e nemmeno un prodotto della mente. Scriveva Vernant: “Il doppio è una realtà esterna al soggetto, ma che, nella sua apparenza stessa, si oppone … agli oggetti familiari […] Esso si muove su due piani contrastanti … si rivela come qualcosa che non è di qui, come appartenente a un inaccessibile altrove” (Vernant, 348). Perciò, nel caso di Elena, il doppio è un elemento che agisce autenticamente al posto della protagonista, assumendone caratteristiche e qualità, è parte di un Sé artificialmente scisso. Tutto questo contribuisce a generare sentimenti di instabilità che corrispondono alla visione relativistica del reale. Il limite e la provvisorietà delle percezioni richiamano una riflessione freudiana: “Il reale rimarrà per sempre inconoscibile” (Freud, 1938, 623). Possiamo al massimo penetrare entro nessi e interdipendenze individuabili nel mondo esterno e riproducibili entro il nostro pensiero. La posizione di Euripide intende ribadire lo stato di provvisorietà caratteristico dei processi conoscitivi dell’uomo, indicando una relatività che mette in dubbio il ruolo e la presenza degli stessi dèi. Così, anche la guerra di Troia perde ogni senso di valore, intesa com’è a conquistare un eidolon. La tragedia va in scena ad Atene nel 412 a. C. E’ il periodo in cui le forze militari attiche sono coinvolte nel momento più duro segnato dalle guerre del Peloponneso. La figura di Elena è identificata in un tesoro, che è facile sottrarre, ma impossibile veramente possedere. La seduzione dell’assenza caratterizza un personaggio moltiplicato attraverso un doppio, che fa scoprire come le guerre più dolorose siano quelle in cui si combatte per un fantasma, tanto forte è la potenza simbolica della sua figura. Nella costruzione euripidea, la seduzione erotica così come la guerra sono attribuite al doppio creato dagli dèi. E il velo della seduzione copre l’angoscia del vuoto identitario, della perdita di Sé, del nulla in cui i personaggi della tragedia e gli uomini di ieri e di oggi si specchiano sull’orlo di un abisso esistenziale.
Il tema del doppio fu caro al teatro antico, tanto che il termine “sosia” deriva dal nome del servo di Anfitrione, comandante tebano, protagonista dell’omonima commedia scritta da Plauto sul finire del III secolo a. C. Qui Mercurio prende le sembianze di Sosia per consentire l’ingresso nelle stanze di Alcmena a Giove che aveva assunto, a sua volta, i connotati di Anfitrione, il marito della donna. Un doppio sosia dà luogo alla commedia degli equivoci, che si conclude con la nascita di un altro doppio; sono due i gemelli: Ercole, concepito da Alcmena nell’amplesso con Giove, e Ificle concepito dalla donna per l’incontro con Anfitrione, avvenuto subito dopo quello col dio.
La rappresentazione della duplicità del soggetto apre il discorso al concetto di “perturbante”, esplorato da Freud nell’omonimo saggio (1919). La ricerca del fondatore della psicoanalisi prende le mosse dal testo di un suo allievo, Otto Rank, autore nel 1914, del saggio “Der Doppelgänger”. Il Doppelgänger, il “doppio viandante” trova spazio nella percezione angosciosa di un duplicato, di un gemello cattivo e angosciante, che incarna i presagi della sventura e della morte. Rank metteva in evidenza come il doppio fosse alla base di un reale perturbamento, in quanto portatore di significati connessi con percezioni inconsuete e con fenomeni estranei alla coscienza. Il doppio proponeva lo sdoppiamento dell’Io e dell’identità, il ritorno dei morti, l’irruzione di sensazioni inattese che minavano le certezze acquisite sui dati scientifici e razionali. Il contatto col doppio e col perturbante suscita paure inconsce e presagi infausti, dove l’Io razionale perde i confini della logica cartesiana e viene travolto da terrori di origine indefinita e incontrollabile, mentre il Doppelgänger acquisisce una esistenza autonoma e non controllabile, fonte di ulteriore angoscia.
Il doppio, presso alcune culture primitive, viene indicato come un’ombra del soggetto, il cui valore è stato individuato nei termini dell’anima. Se l’ombra è, dunque, l’espressione del soffio vitale che sostiene l’individuo, la presenza del doppio configura una scissione dell’Io, un indebolimento che annuncia gravi difetti fino a configurare il pericolo della morte imminente, stato che potrà condurre l’individuo nel regno dei morti, delle ombre, appunto. Scriveva Rank: “una prima concezione dell’anima … corrisponderebbe a un monismo primitivo in cui essa sarebbe l’immagine del corpo” (77). Lo studioso fa riferimento al pensiero arcaico di popolazioni che non avevano la possibilità di riconoscere la propria immagine allo specchio. Questo ci porta al mito di Narciso e alla raffigurazione entro le acque della fisionomia di un soggetto che ancora non era riuscito a identificarla come propria. Gli aspetti primordiali dello sviluppo psichico trovano corrispondenza nelle considerazioni che Freud aveva sviluppato in “Totem e tabù” (1913) al riguardo dell’onnipotenza del pensiero, quando prospettò che gli uomini primitivi, così come i bambini, presentassero una struttura psichica narcisistica, sorta di omeostasi paragonabile alla perfezione della vita intrauterina. Si trattava di uno stato che non consentiva ancora scambi col mondo esterno: la presenza dell’altro non possedeva uno statuto di autonomia, ma era funzionale al mantenimento della quiete psico-fisica e non comportava ancora la possibilità di una relazione. Diviene facilmente comprensibile come la struttura narcisistica primaria risulti turbata dall’irrompere di elementi perturbanti, costituiti da variazioni dello stato di quiete, che vengono percepite in forma di annunci di morte: “il narcisismo primario, tipico anche del bambino, non ha alcuna idea della morte: al primitivo, come al bambino, pare ovvio che la vita continui eternamente. La morte gli pare un evento contronatura … Solo con la percezione della morte e della paura di essa, provocata dalla minaccia al narcisismo, sorge il desiderio dell’immortalità …” (Rank, 102).
Il saggio freudiano sul “perturbante” prende in considerazione innanzitutto la definizione del concetto: “esso appartiene alla sfera dello spaventoso, di ciò che ingenera angoscia e orrore” (Freud 1919, 81). Il doppio, con la coesistenza e la percezione di due personaggi identici, risulta una esperienza perturbante capace di raffigurare la scissione avvenuta entro l’Io e di indurre la ricomparsa di alcune idee magiche. Queste erano appartenute all’infanzia, ma si ripropongono nel presente col recupero improvviso di pensieri risalenti a tempi remoti e in apparenza dimenticati, come, per esempio, le convinzioni animistiche o l’esistenza reale di un compagno immaginario. “Il perturbante … si verifica quando complessi infantili rimossi sono richiamati in vita da un’impressione o quando convinzioni primitive superate sembrano aver trovato una nuova convalida” (Freud 1919, 110). In definitiva, la ricomparsa di un contenuto radicato nelle fantasticherie infantili pare conferire valore di realtà a ciò che era stato riferito a convinzioni irrazionali, connesse con aree del pensiero pre-logico. La presenza del doppio o del sosia rinvia, inoltre, a fasi dello sviluppo mentale in cui non era ancora avvenuta una demarcazione dei confini tra l’Io e la realtà esterna e tra l’Io e l’altro. Il doppio ha funzioni originariamente utili all’Io infantile per garantirgli idealmente una forma di sopravvivenza, scongiurando l’idea dell’annientamento e vanificando il sentimento primario di impotenza provato dal bambino.
Cerchiamo di pensare all’effetto che può generare su chiunque l’immagine della propria persona, quando essa si presenti improvvisamente come un individuo resosi autonomo dal nostro controllo. Freud, riferendosi a una analoga esperienza riportata da Ernst Mach nel testo di “Analisi delle sensazioni” (1886), descrive il proprio perturbamento, quando fu sorpreso dall’ingresso di un anziano signore nello scompartimento del treno dove viaggiava in solitudine; e aggiunge: “mi accorsi subito, con grande sgomento, che l’intruso era la mia stessa immagine riflessa dallo specchio fissato sulla porta di comunicazione. Ricordo tuttora che l’apparizione non mi piacque affatto” (Freud 1919, 109 n).
Sul piano della clinica, l’esperienza del doppio ha condotto alla descrizione di quadri morbosi, piuttosto rari per quanto dotati di gravità. Tra questi, ricordiamo l’autoscopia: illusione o allucinazione di un Sé gemello che viene percepito come autonomo; questo stato mentale consente il riconoscimento di un proprio gemello grandioso in grado di compiere atti che il soggetto si era proposto di realizzare. Questa immagine deriva da una scissione psichica avvenuta assai precocemente nello sviluppo mentale del soggetto; egli subisce, a tratti, la momentanea perdita della propria unità identitaria (depersonalizzazione). Ricordiamo anche la sindrome di Capgras o illusione del sosia, in cui il paziente ha la perdurante certezza che uno o più soggetti presenti nella sua vita siano stati sostituiti da sosia che li impersonano. L’assoluta convinzione del soggetto documenta la sussistenza di un delirio che frantuma i confini dell’Io e genera un difetto nella percezione del mondo esterno (derealizzazione).
Il perturbante riguarda qualcosa che era familiare e ora non lo è più, tanto da presentarsi come un’apertura verso le valenze terrifiche dei contenuti d’angoscia. Questa familiarità spiega l’utilizzo del termine “Das Uneimliche” (“Il non familiare”), che dà il titolo originale al saggio di Freud. Gli aspetti perturbanti presenti nelle opere letterarie vanno considerati diversamente: sono soggetti al regno della fantasia, “esonerato dall’esame di realtà” (Freud 1919, 111), e per questo non soggetto al confronto fra ciò che è esistente e ciò che risulta puramente immaginario. Vero è che “nella poesia, per ottenere effetti perturbanti, esistono una quantità di mezzi di cui la vita non può disporre” (ibidem). L’arte e la poesia, dunque, ci consentono di sperimentare turbamenti e stati passionali assai vivi, ma destinati a restare circoscritti entro le aree di una semplice rappresentazione o di una finzione riconoscibile. Il perturbante può, dunque, trasformarsi in esperienza catartica attraverso l’immersione del fruitore nelle verosimiglianze di un mondo immaginario.
E su quale statuto della vita psichica indaga la rappresentazione di sé? Che ruolo possiede l’autoritratto per consentire l’espressione dell’identità? Freud indica il valore della creazione e della raffigurazione di un doppio “come difesa dall’annientamento”; questa considerazione si inserisce sulla linea delle immagini del defunto che venivano modellate con materiale durevole e formate fin dal tempo delle civiltà presenti nell’antico Egitto. Annotava: “queste rappresentazioni sono sorte sul terreno dell’amore illimitato per se stessi, del narcisismo primario che domina la vita psichica sia del bambino sia dell’uomo primitivo” (Freud 1919, 96).
Il saggio di Rank contiene anche il riferimento a temi di maggiore complessità. Dopo avere analizzato i timori popolari e le superstizioni comuni relative all’uso dello specchio[1], fino alla proibizione di specchiarsi durante la notte, pena la perdita del proprio riflesso, e alle angosce per la rottura degli specchi come presagio di morte o di settennali disgrazie, Rank esplora alcune credenze antiche, tanto che “nell’immagine riflessa dallo specchio e dall’acqua, come nei ritratti, i primitivi vedono un’oggettivazione dell’anima” (80). Questo portò alla proibizione tanto di guardarsi allo specchio, per evitare la perdita della propria bellezza, quanto di rimirarsi sulla superficie di fiumi, laghi e paludi per sottrarsi al contatto coi mostri delle profondità acquatiche, capaci di rubare la vita a chi si avventurasse anche solo sopra la superficie. Analogamente, i soggetti appartenenti a numerose tribù rifiutavano di farsi ritrarre o fotografare perché l’atto di esteriorizzare la propria figura avrebbe comportato il danneggiamento dell’anima da parte di chi si fosse impadronito dell’immagine.

La coincidenza tra la raffigurazione di sé e l’identità del soggetto si è mantenuta, grazie all’attività razionale, come uno stato di pensiero legato a funzioni di ordine psicologico. L’autorappresentazione compiuta dall’artista contiene significati che vanno dalla componente narcisistica alla necessità dello scavo psicologico, dal desiderio di rendere esplicito il proprio mondo interiore alla volontà di documentare il procedere del tempo, dal bisogno di rendere durevole una effigie all’importanza di fissare stati d’animo transitori. Colpisce, per esempio, come Émile Bernard (1868-1941), tra il 1886 e il 1941, eseguisse quasi ogni anno un proprio ritratto per delineare non solo l’evoluzione della lunga ricerca artistica, ma anche per descrivere lo sviluppo della propria vicenda biografica attraverso sentimenti e affetti talvolta dolorosi.

Ricordiamo anche il pittore romano Antonio Mancini (1852-1930) che ci ha consegnato gli “autoritratti della follia”, compiuti durante i suoi soggiorni in una casa di cura (1878-81) poi nel manicomio provinciale di Napoli (1881-83); in essi, alla fissità della posa irrigidita dall’angoscia depressiva e dallo stato dissociativo si alternano fasi più serene, governate, anche artisticamente, da una migliore ripresa delle funzioni dell’Io. Una linea di pensiero fa notare come sia divenuta possibile la condivisione di un reciproco sguardo tra l’esecutore e il fruitore dell’opera, coinvolti nell’esperienza di guardare e di essere guardato. Così scriveva Egon Schiele: “io sto dipingendo quel me stesso su cui poso lo sguardo; io sono contemporaneamente colui che guarda e colui che è visto” (Kallir 1990, 651).
La letteratura si è occupata ampiamente del doppio e della scissione psichica prima che la psicoanalisi desse inizio alla propria ricerca. Fëdor Dostoevskij[2], Oscar Wilde[3], Edgar Allan Poe[4], Adelbert von Chamisso[5] hanno pubblicato opere in cui la perdita di unicità dell’individuo viene affrontata da punti narrativi diversi. “La psicoanalisi è emersa, in parte, da questa atmosfera improntata alla convinzione che l’uomo porti dentro una natura più oscura, un Sé nascostamente impulsivo e con una propensione demoniaca” (Grotstein 1981, 37).
Più complessa è l’analisi condotta nel romanzo di Robert Louis Stevenson (1850-1894), “Lo strano caso del Dr Jekyll e Mr Hyde” (1886). La nota vicenda, immaginata dall’autore, porta in scena un medico stimato e dalla reputazione irreprensibile, che, in virtù di una pozione contenente ignote impurità, assiste alla trasformazione non solo della propria indole, ma anche dei connotati fisici fino a trasformarsi in un individuo dalla condotta perversa e violenta. Mr Hyde assumerà gradualmente il pieno controllo della personalità e delle fattezze appartenute al medico, che non potrà più recuperare l’identità originaria fino al tragico epilogo. “Così mi avvicinavo progressivamente a quella verità che in parte ho scoperto e che mi ha condannato a questo naufragio spaventoso: l’uomo non è veramente uno, ma di fatto due. Dico due, perché il livello della mia conoscenza non va oltre. Altri mi seguiranno e supereranno questo limite; e oso supporre che alla fine l’uomo sarà considerato come uno Stato costituito da cittadini multiformi, incongrui e indipendenti” (Stevenson 1886, 74). Lo scrittore anticipa il concetto di scissione e, con la descrizione della doppia identità del personaggio (soggetto a mutamenti drammatici nell’acquisizione di personalità opposte), propone il tema dell’infelicità dell’individuo entro il gruppo sociale e della sfrenatezza pulsionale cui deve rinunciare per essere approvato e accolto. L’uomo stevensoniano è minacciato da forze oscure, demoniache, soggiogato da potenze inconsce tanto più imperiose quanto più represse. L’idea di un male e di un bene totalmente opposti e non comunicanti permeava la società coeva, mentre la ricerca freudiana giungeva inizialmente a delineare “una visione dell’uomo caratterizzata dalla presenza di una personalità conscia costantemente assediata da una personalità inconscia costituita dal ricordo traumatico infantile” (Grotstein 1981, 37). Successivamente (“L’Io e l’Es”, 1923) Freud ridimensionerà l’importanza della scissione a vantaggio della rimozione. La descrizione delle pulsioni istintuali spostò lo sguardo sulla tripartizione della psiche, dove l’Io assunse una funzione di sintesi e di mediazione rispetto agli impulsi contenuti nell’Es, alle istanze morali del Super Io e alle esigenze della realtà: “questo significativo cambio di accento culminò anche nella laicizzazione delle componenti dell’inconscio, prima connotate in senso demoniaco” (ibidem). Permaneva, dunque, la non unicità dell’individuo all’interno di un contesto più complesso e articolato, dove la creatività discendeva dalle funzioni consce dell’Io, attraverso il contatto con la parte irrazionale, inconscia e pulsionale, delle profondità psichiche.
In tempi recenti, il tema del doppio ha sollecitato lo sviluppo di ulteriori punti di vista con la definizione di due poli estremi: “un carattere … altamente persecutorio e distruttivo, la cui azione riesce a collassare ogni risorsa vitale del soggetto, e un carattere bonificato in cui il doppio si modifica e viene riassorbito entro una struttura vitale e integrata armonicamente” (Funari 1991, 57). Un esempio di questa possibile ricomposizione si coglie nel romanzo di Joseph Conrad (1857-1924) “Il compagno segreto” (1909), nel quale un capitano di veliero accoglie a bordo il giovane ufficiale fuggito dalla nave vicina: questi si rivelerà l’autentico alter–ego, il “compagno segreto” del comandante, fino a un finale insaturo, dal significato potenzialmente drammatico, che lascia avvertire la possibilità di una crescita nella maturazione e nella fiducia. Così, il sosia minaccioso “si trasforma nel coinquilino – compagno la cui traccia sul mare segna il senso di una nuova esperienza di pensiero” (Gaburri 1986, 59). Analoghe considerazioni vengono offerte dalla lettura di un romanzo scritto da Antonij Pogorelskij (1787-1836): “Il sosia” (1828). In esso, il protagonista descrive le proprie serate “nella piccola Russia”[6], trascorse in compagnia del proprio alter-ego. Il doppio ha qui una funzione strutturante per l’Io, perché svela al protagonista “il senso del divertimento e il piacere della relazione e tocca sensibilmente quell’esperienza particolare per cui la conoscenza può essere tanto più profonda quanto più riesce a preservare dentro di sé gli aspetti giocosi” (Funari 1991, 69). L’esperienza del doppio consente, in questo caso, al soggetto il recupero graduale dei fantasmi angosciosi che aveva proiettato all’esterno fino a condurlo verso l’integrazione in sé di nuove forme della conoscenza. L’incontro col doppio diviene, in tal modo, il prototipo dell’esperienza possibile nel rapporto concreto con l’altro e allo stesso tempo un momento di contatto con la parte più profonda del proprio Sé, ottenuto grazie al riconoscimento delle angosce provate e all’accettazione di una alterità non più minacciosa.
Karl Jaspers (1883-1969), filosofo e psichiatra, tracciò uno studio patografico di Vincent van Gogh (1853-1890). In un celebre saggio (1922), Jaspers individuava l’inizio della psicosi acuta con eccitamento e allucinazioni da cui fu colpito l’artista tra la fine del 1887 e l’inizio del 1888; essa fu preceduta da un prodromo di sintomi a valenza somatica. L’instaurarsi del quadro morboso si rivelò graduale fino a manifestarsi in forma di bouffées dissociative a ricorrenza periodica. Nella vicenda morbosa spiccano l’alterco violento di Vincent con Paul Gauguin (1848-1903), avvenuto ad Arles il 23 dicembre 1888, il tentativo di aggredirlo con un rasoio e infine la ritorsione della violenza su di sé, attraverso l’amputazione del lobo auricolare sinistro. Van Gogh venne subito ricoverato all’ospedale di Arles, passando poi al manicomio di Saint-Rémy (maggio 1889 – maggio 1890). Una volta dimesso, visse ad Auvers-sur-Oise sotto l’amichevole guida del dottor Paul-Ferdinand Gachet fino a una nuova crisi impulsiva culminata con l’autoferimento mediante un colpo di pistola all’inguine (27 luglio) cui seguì, due giorni dopo, la morte.

La vicenda di Van Gogh è segnata dai dipinti e dai ritratti. Negli autoritratti, egli amò sottolineare il valore delle espressioni e le caratteristiche emotive che ne emergevano. Scriveva al fratello Theodore (1857-1891), confrontando con un proprio autoritratto un ritratto precedente fattogli da Gauguin: “La mia faccia da allora si è molto rassicurata, ma ero proprio io, estremamente stanco e carico di elettricità, come ero allora” (V. van Gogh, 11). Un riflesso dello stato di eccitamento si coglie nella descrizione delle tonalità cromatiche impiegate e della qualità relativa agli sfondi: “invece di cercare di rendere esattamente ciò che ho davanti agli occhi, mi servo del colore per esprimermi con intensità … esagero il biondo dei capelli, arrivando al tono arancione, al giallo cromo, al limone pallido. Dietro la testa, invece di dipingere il muro banale del misero appartamento, dipingerò l’infinito, farò uno sfondo semplice del blu più ricco, più intenso che riuscirò a ottenere” (V. van Gogh, 14-15). Siamo nel 1888. Il trasferimento da Parigi ad Arles conferisce vigore all’ispirazione dell’artista e coincide temporalmente con l’evoluzione del suo quadro clinico. La linea tracciata dalle opere consente, secondo Jaspers, di seguire l’andamento dello stato psichico. Il periodo 1888-90 è indubbiamente quello più produttivo e coincide con fasi di esaltazione dell’umore capaci di condurre l’artista a un’attività febbrile. Per la qualità delle opere realizzate, va detto che l’Io, pur nelle crisi allucinatorie e nella ricorrente insoddisfazione, manteneva un contatto con la realtà sufficiente per far sì che il linguaggio estetico restasse comprensibile e il sentimento ispiratore condivisibile; pare, anzi, che l’artista cercasse di entrare con forza nell’essenza profonda del reale. Scriveva nel 1890: “In ogni modo, cercare di essere vicino alla realtà è forse un modo per combattere il male che continua sempre a tenermi inquieto” (V. van Gogh, 24). Le tensioni e le agitazioni con cui tracciava le figure indicano un forte prevalere di sentimenti a valenza universale. La pennellata scomponeva l’unità del quadro soprattutto nelle ambientazioni paesistiche. Secondo Jaspers, la schizofrenia (o più precisamente, il disturbo schizo-affettivo) eromperebbe con evidenza entro le opere fin dall’inizio del soggiorno nel Midi, coi segni di una potente tensione interiore. Nel 1889, le serie dei cipressi e dei girasoli potrebbero costituire il riflesso di un manierismo ripetitivo e rassicurante per l’assetto psichico. In realtà, a ciò si aggiungerebbe il tentativo di interpretare la realtà secondo i caratteri di una maggiore astrazione, responsabile della iniziale dissoluzione dei contorni e della percezione di una materia progressivamente indifferenziata.
Colpisce come, al di fuori delle crisi acute, l’artista mantenesse un buon grado di consapevolezza della malattia, tanto da scrivere ai familiari con lucidità, aggiornandoli sulla propria salute. La lettera è del gennaio 1889: “Spero di non aver avuto altro che una semplice crisi d’artista … Per il momento non sono ancora pazzo e sono ancora pieno di speranze” (V. van Gogh, 24). Dopo l’ingresso a Saint-Rémy, egli annotò, con esemplare consapevolezza, come l’ingresso in manicomio gli consentisse l’osservazione dei malati, cosa che giovava a fargli passare la paura della follia. Aggiunse che la sua persistente lucidità tra le crisi aveva spinto il dottor Peyron, direttore del manicomio, a dichiarargli che non era un pazzo come gli altri, anche se, durante gli accessi acuti, perdeva la coscienza della realtà. Nell’ultima lettera al fratello Theo, scritta il 27 luglio 1890 (giorno del colpo di pistola), Vincent espresse in poche parole l’essenza dell’arte e il rapporto dell’artista con la sua opera: “E poi è vero, noi possiamo far parlare solo i nostri quadri […] Ebbene, nel mio lavoro ci rischio la vita e la mia ragione vi si è consumata per metà –e va bene- ma tu non sei fra i mercanti di uomini … e puoi prendere la tua decisione … comportandoti sempre con umanità” (V. van Gogh, 400). Il testo della missiva riguardava il commercio delle opere d’arte. Vincent riconosceva al proprio fratello una sensibilità umana e creativa. Theo fu mercante d’arte. Dal fitto epistolario intercorso tra i due (del quale ci restano solo le lettere inviate dal pittore) cogliamo la confidenza affettuosa con cui l’artista si apriva al fratello soprattutto nei momenti di sofferenza. Come precisò la sorella Elisabeth, “il mondo avrebbe conosciuto il genio di Vincent e l’intuito di Theo” (E. van Gogh, 66). Theo rappresentò un autentico alter-ego per Vincent, e il legame profondo tra i due li portò a morire a sei mesi di distanza l’uno dall’altro. Nel 1914, le spoglie di Theo furono traslate accanto a quelle di Vincent entro il cimitero di Auvers-sur-Oise.
E i selfie? Il moderno autoritratto (individuale, di coppia, collettivo), realizzato per lo più attraverso uno smartphone, un tablet o una webcam, ha generato abitudini largamente diffuse. Si tratta di un esercizio solipsistico della rappresentazione? di un autoritratto senza spettatori? Tutt’altro. Il selfie è destinato a trovare diffusione, per lo più immediata, sulle piattaforme digitali tanto da potere raggiungere in pochi secondi l’intero pianeta. Non va dimenticato come la tecnologia digitale consenta di ritoccare l’immagine, migliorandola in modo significativo. Se la possibilità di diffondere un messaggio in maniera rapida e globale appare un vantaggio dei mezzi contemporanei, l’utilizzo compulsivo dei selfie ha finito per configurare un quadro psicopatologico. Se la rappresentazione di sé, finalizzata all’ammirazione o a una condivisione compiaciuta, può indicare una forma di narcisismo più o meno marcato, capace di generare un rinforzo, per quanto temporaneo, all’autostima, l’elevata frequenza del selfie ha consentito all’Associazione degli Psichiatri Americani di individuare una nuova sindrome. La differenza tra normalità e patologia trae indicazioni anche dalla quantità con cui un fenomeno si presenta. La Sindrome da Selfie (non ancora inserita nei manuali diagnostici) comporta lo scatto compulsivo (almeno sei volte al giorno) di immagini di sé e la loro diffusione; essa è considerata una moderna variante della Dismorfofobia. Il Disturbo da Dismorfismo corporeo comporta una eccessiva preoccupazione per alcuni minimi difetti fisici (in alcuni casi del tutto assenti) che si accompagna a controlli costanti e reiterati di fronte allo specchio fino a esitare talvolta nella richiesta di interventi chirurgici con finalità estetica. La patologia da selfie contiene, tra l’altro, uno stato di onnipotenza, per cui, attraverso la correzione impressa coi mezzi tecnologici (Photoshop), l’aspetto del soggetto riceve elevati miglioramenti, tanto da configurare un’immagine ideale. Nel mondo virtuale, la realtà viene talvolta intesa in modo difforme dalle categorie consuete: essa non è quella concreta, ma quella rappresentata. Per questo, ciò che non viene rappresentato o fotografato rischia di essere inesistente. Comprendiamo, allora, come il selfie indichi la necessità narcisistica di raffigurare una realtà perfetta, dove il minimo difetto non può essere tollerato. Oltre a ciò, la necessità di diffondere l’immagine in tempo reale fa comprendere come il semplice racconto verbale perda di valore e di significato rispetto alla istantanea raffigurazione. Un altro problema dell’utilizzo totalizzante dei selfie è la perdita di contatto con situazioni concrete, talvolta fonte di pericolo, che vengono ignorate a vantaggio della documentazione di ciò che sta avvenendo in quel preciso istante. Il selfie non è e non diviene una creazione artistica, ma rappresenta un riflesso del bisogno di riconoscimento e di ammirazione.

Nella mostra forlivese, colpiscono alcuni possibili precursori dei moderni selfie. Mi riferisco al dipinto di Piero Marussig (1879-1937): Autoritratto con la moglie (1911), dove la posizione dei due soggetti fa pensare alle pose dei selfie contemporanei, con l’inversione della tradizionale collocazione della donna, ritratta qui dietro l’artista.

L’uomo nero (1959) di Michelangelo Pistoletto (n. 1933) fa pensare a una elaborazione dell’istantanea fotografica che giunge a scomporre l’individuo nelle sue caratteristiche essenziali. L’Autoritratto (1987) di Chuck Chose (1940-2021) è una reale fotografia degli occhi scattata dall’autore e incorniciata con la giustapposizione di due enormi stampe. Gli occhi enormi e dilatati dell’artista sono una porta comunicante tra mondo interno ed esterno. E forse l’impiego dei selfie può essere anche inteso come il desiderio di fissare con evidenza, attraverso l’immagine, un istante di vita, un tratto della nostra interiorità.
BIBLIOGRAFIA
Conrad J. (1909). Il compagno segreto. BUR, Milano, 1996.
Dodds E. R. (1951). I Greci e l’irrazionale. BUR, Milano, 2018.
Euripide. Elena (traduzione di Carlo Diano), ne “Il teatro greco – Tutte le tragedie”. Sansoni, Firenze, 1983.
Freud S. (1913). Totem e tabù: alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici. OSF, 7.
Freud S. (1919). Il perturbante. OSF, 9.
Freud S. (1923). L’Io e l’Es. OSF, 9.
Freud S. (1938). Compendio di psicoanalisi. OSF, 11.
Funari E. (a cura di) “Il doppio tra patologia e necessità”. Raffaello Cortina, Milano, 1986.
Funari E. La chimera e il buon compagno. Raffaello Cortina, Milano, 1991.
Gaburri E. (1986). Dal gemello immaginario al compagno segreto in Funari E. cit. 1986.
Grotstein J. S. (1981). Scissione e identificazione proiettiva. Astrolabio Ubaldini, Roma, 1983.
Jaspers K. (1922). Genio e follia – Strindberg e Van Gogh. Raffaello Cortina, Milano, 2001.
Kallir J. (1990). Egon Schiele – The Complete Works. Thames and Hudson, New York, 1998.
Mach E. (1886). L’analisi delle sensazioni e il rapporto tra fisico e psichico. Feltrinelli, Milano, 1975.
Pogorelskij A. (1928). Il sosia. Studio Tesi, Pordenone, 1990:
Rank O. (1914). Il doppio – Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore. Sugarco, Milano, 2022.
Stevenson R. L. (1886). Lo strano caso del Dr Jekyll e di Mr Hyde. Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1968.
Van Gogh E. (1910). Vincent, mio fratello. Skira, Milano, 2010.
Van Gogh V. (1875-90). Lettere a Theo. Guanda, Milano, 2024.
Vernant J. P. (1971). Mito e pensiero presso i Greci. Einaudi, Torino, 2001.
Note
[1] Non vanno dimenticate le esperienze divinatorie della catoptromanzia, compiute con uno specchio ritenuto magico.
[2] “Il sosia” (1846).
[3] “Il ritratto di Dorian Gray” (1891).
[4] “William Wilson” (1839).
[5] “Storia straordinaria di Peter Schlemihl” (1814).
[6] Governatorato dell’Ucraina con capitale Černigov.