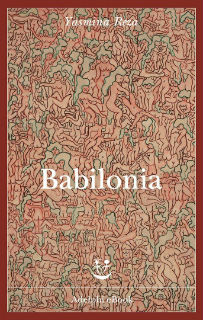
Babilonia
Di Yasmina Reza, Adhelpi, 2017
(Rossella Valdré)
Jasmina Reza è una scrittrice di pregio. La sua parola è affilata, precisa, appuntita, arguta, dissacrante, ricercata senza intellettualismi, mai convenzionale, mai banale, mai di troppo. Essa possiede il merito raro, oggi, che il lettore esigente cerca: di giungere al cuore delle cose. I suoi temi si ripetono, in varia forma, nelle molte sceneggiature (di cui poche tradotte in italiano) e nei non molti romanzi, tra cui brillano gli ultimi due gioielli: “Il Dio del massacro” (trasposto in film da Roman Polanski nel 2011, Carnage) e la raccolta di racconti “Felici i felici”. Qui la Reza parla di coppie, “Della loro tracotanza, della loro volgarità”, come scrive in “Felici i felici”; di massacri domestici borghesi; di irruzioni nell’irrazionale come fuga; di quotidiana infelicità, ora quieta, ora grottesca.
Direi che il grottesco è la cifra di “Babilonia”, appena uscito per Adelphi. Pur non toccando i vertici, e le perfidie, dei precedenti lavori citati, questo breve romanzo (romanzo? Difficile definire i ‘pastiche’, i piccoli zibaldoni della Reza) si legge d’un fiato e mantiene fede alle caratteristiche dell’autrice: strapparci un sorriso amaro, mancare di una sostanziale conclusione, e il dono della bellezza della scrittura. Le coppie qui sono molte, riunite ad una festa che Elizabeth e Pierre, coniugi tutto sommato ben assestati nel sopportare i fracassi del tempo che passa, una sera organizzano, chiamando a raccolta una serie di bizzarri personaggi, amici e conoscenti tutti portatori di una loro eccentricità, di un loro dettaglio particolare.
Ma un ospite è per Elizabeth – io narrante – il più gradito: Jean-Lino Manoscrivi, il solitario vicino di sopra. Da un po’ di tempo, i due hanno allacciato un dialogo che, narrativamente, si inframmezza all’attualità degli eventi; parlano delle loro infanzie di bambini non amati, del tempo che passa, della vita.
“Quando si cresce con l’idea di non avere nessuno è difficile tornare indietro. Anche se qualcuno ti prende la mano e ti abbraccia, la cosa non ti arriva davvero.”
Elizabeth sente che Jean-Lino, quest’ometto dal ridicolo nome italiano come il suo adorato gatto Edoardo, è solo: “Non avere nessuno significa non avere nemmeno se stessi. Chi ti ama ti rilascia un attestato di esistenza (o di consistenza). (…) non si può esistere senza una piccola fiaba sociale” (119, 120, corsivo mio).
Trovo psicoanaliticamente assai centrato il termine di consistenza in luogo del più generico ‘esistenza’; tutti tiriamo a campare, sembra dire la Reza, solo alcuni sono consistenti. In realtà Jean-Lino ha una moglie, Lydie, una patetica fanatica del benessere che chissà come è finita sotto il suo stesso tetto. I due, come molte coppie, sembrano estranei. Finita la festa, tutti a casa, lei e il marito a letto.
Elizabeth ha sessantadue anni, le perdite alle spalle cominciano ad essere molte, le creme anti-age non restituiscono giovinezza, ma la tiepida illusione di cui gli umani hanno bisogno. A metà romanzo, la svolta.
Jean-Lino ha ucciso la moglie, strangolandola. Non la sopportava più. Perché mai?
“Le coppie litigano sempre per motivi apparenti”, dirà in seguito Elizabeth alla polizia. Salutista fanatica, durante la festa, davanti al pollo servito a cena, Lydie aveva avuto da ridire se fosse di provenienza biologica o no, mangiando lei solo polli biologici, con tutta la solita manfrina a seguire, che protegge il volatile (“l’uccello”, ironicamente) e ignora l’umano. La grottesca discussione era proseguita a casa, racconta Jean-Lino, lui l’aveva accusata d’averlo umiliato davanti a tutti per uno stupido pollo; lei aveva commesso il più grande dei reati: nella rabbia, aveva dato un calcio ad Edoardo. Edoardo è per il nostro ometto l’intero mondo, l’unico amico, chi ci è sempre stato e sempre ci sarà. Quel calcio col tacco a spillo è fatale alla povera, sciocca Lydie. Dallo strangolamento in poi, il romanzo assume un tono, come detto, che mescola grottesco ed empatia per le miserie umane, prende di mira in gustosissime pagine le cosiddette “espressioni vacue” che infarciscono i discorsi del nostro tempo: “creare legame”, “tolleranza”, “elaborazione del lutto”, “il dovere della memoria”….Che senso hanno, queste profonde espressioni, al di fuori di un contesto che davvero le comprenda, diventate marketing del linguaggio? Viviamo dentro binari, scrive la Reza, i binari delle convenzioni. Con l’assurdo omicidio, a suo modo Jean-Lino si ribella: “Ha dato un calcio al gatto e l’ho strangolata.” E, nell’esilarante e straziante sfogo: “…me ne frego altamente del pollo, del tacchino, del maiale, me ne frego di tutta la compagnia, se mi mangio il mio pollo bio è perché è più buono ma a parte questo me ne frego, me ne frego se è infelice, che cosa ne sappiamo noi, me ne frego se non ha visto la luce del sole, se non ha saltellato tra gli alberi come un merlo o non si è rotolato nella polvere, non credo nella coscienza del pollo (….) Sono stufo di continue restrizioni, non ne posso più di vivere sotto il terrore, se mi va di mangiare pollo tutti i giorni mangio pollo tutti i giorni (…) mangiatevi la vostra insalata e smettetela di rompere” (p93).
Le ribellioni dei miti assumono le forme più inattese. Poiché, aggiunge (freudianamente) la Reza, l’essere umano tende alla quiete, ora Jean-Lino sarà in pace: poco gli importa (e lascio al lettore le altrettanto grottesche peripezie per nascondere il cadavere) se finirà i suoi giorni in galera. Dalla galera del matrimonio, delle convenzioni, del ‘politically correct’, dell’umiliazione sempre in agguato dei non amati – i non consistenti – il piccolo italo-francese è già uscito.
L’esilarante interrogatorio, che vede Elizabeth come protagonista in quanto sospetta complice di occultamento di cadavere, mostra tutta l’ottusità della giustizia umana di fronte ai crimini del cuore: la ferita narcisistica, la più dolorosa e impotente che esista, è a monte di molti omicidi tra le mura domestiche. Non sono i grandi fatti del mondo che ci interessano, intermezza l’autrice con frequenti divagazioni sul vivere, ma le nostre piccole ferite, perdite quotidiane. La giustizia umana faticherà a capire come non fossero amanti – “no, no, ci davamo del lei” – cosa unisce le anime che apparentemente non hanno beni, non hanno convenzioni da scambiarsi, ma solo parole, condivisioni. Di quelle, Elizabeth sentirà la mancanza.
Forse addolcita dal passare del tempo, in “Babilonia” la Reza è più cauta, ma non priva di ferocia, la ferocia verso i luoghi comuni e le convenzioni che imprigionano la coppia, per accostarvi uno sguardo più dolcemente ironico, colmo di pietas per come “per sopportare questa nostra vita terrena ci circondiamo di elementi fantastici (…) tutti i frammenti di un armamentario chic o miserabile sostengono gli uomini in silenzio” (64).
“Babilonia”, a differenza delle opere precedenti, per chi come me, ama e segue questa che è forse la più interessante autrice francese contemporanea, non ha più per oggetto solo la messa in crisi, la distruzione della coppia borghese, ma è anche un piccolo romanzo sul tempo, la vecchiaia, la solitudine, la necessità di dire no, no alle vacue ossessioni del nostro tempo, il tempo dei polli biologici e degli esseri umani inconsistenti.
“E’ la stessa idea di futuro che andrebbe messa in crisi. Entrati in questa terra, dobbiamo abbandonare ogni idea di permanenza”.
Vedi anche:
COPPIE.La coppia nella contemporaneità: dall’incontro amoroso alla psicopatologia
