
Chaos + Repair = Universe. Kader Attia, 2014
Intervista per la Somalia a Kaha Mohamed Aden, scrittrice

Domanda 1
Come descriverebbe il Corno d’Africa in rapporto alle “amnesie e alle rimozioni” dei Paesi che lo hanno occupato?
L’amnesia e la rimozione dei colonizzatori sono aspetti cruciali per la storiografia contemporanea poiché si collegano sia alle politiche interne (penso al dibattito politico su come affrontare temi attualissimi come l’immigrazione o i diritti culturali) sia con il bisogno di costruire una nuova identità, ripulita dai soprusi e dalle responsabilità del dominio forzato da parte dei governi ex coloniali. Per quanto mi riguarda, per non subire ancora una volta la centralità dei paesi coloniali, la mia attenzione è focalizzata su quanto hanno “combinato” i somali e su cosa il resto del mondo, che non coincide strettamente con i paesi che hanno occupato il corno d’Africa, ha consentito all’Italia di fare, dimenticando e quindi sacrificando, questo sì, le istanze di libertà e di indipendenza dei somali per premiare l’Italia che all’ultimo si era alleata con i vincitori della seconda guerra mondiale:
“Era un periodo particolare per la Somalia. Il mondo intero (si fa per dire) ritenne giusto che l’Italia, paese colonizzatore, iniziasse la Somalia al processo democratico. Questo ‘parto’ dell’Assemblea delle Nazioni Unite sarebbe durato dal 1950 al 1960 e venne chiamato AFIS, Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia”[1].
Questo evento per me ha dell’incredibile e ci sono tornata in più di un racconto: sentivo il bisogno di parlare della situazione paradossale in cui i somali, quelli che lottavano per l’indipendenza, si erano trovati. E’ difficile digerire che le Nazioni Unite, dimenticandosi bellamente le istanze degli indipendentisti e il diritto di autogovernarsi dei somali, abbiano dato carta bianca all’Italia, paese colonizzatore, per guidare i somali a costituire uno Stato democratico, oltretutto attraverso un’istituzione come l’AFIS, popolata da ex fascisti!
E a ben guardare nemmeno noi somali siamo lontani da certe rimozioni. Prendiamo il caso dello scontro[2] sull’indizione delle elezioni generali e sulla legge elettorale 4.5[3], attualmente in vigore a discapito di quella che si basa sul principio “una persona un voto”. Noto con dispiacere che da questo scontro non è emerso, almeno per quanto ne sappia, che la legge 4.5 è un frutto avvelenato di un determinato momento:
“…Alla fine del colonialismo, quando si è trattato di costituirci in fretta uno Stato democratico per raggiungere l’indipendenza. È stato un processo in cui erano pesantemente coinvolti gli stessi colonialisti e i loro collaboratori. Infine, è uscito fuori un accrocco, tanto che non è stato previsto nemmeno uno straccio di censimento e nessun tentativo di aggiornare gli strumenti che tradizionalmente regolavano i conflitti. Le forze indipendentiste, pur di togliersi i colonialisti dai piedi, hanno approvato il progetto”[4]
L’amnesia quindi non è una sindrome che riguarda soltanto i governi degli Stati come l’Italia che hanno occupato il Corno d’Africa ma anche un’istituzione come le Nazioni Unite, per non dire gli stessi appartenenti del Corno d’africa, i somali nel nostro caso. Così, aprire un confronto franco con il quale si possa affrontare cosa sono queste “dimenticanze” e/o riformulazioni non può che essere una cosa buona e utile.
Domanda 2
Le moderne nazioni postcoloniali – a detta di alcuni studiosi come Partha Chatterjee (1993) – somiglierebbero a una seconda copia della grande nazione europea e, in questo modo, rappresenterebbero gli spazi più adatti alla realizzazione dei suoi propositi economici, sociali e culturali”. Cosa ne pensa? E come interpreta tale affermazione?
Nel caso somalo, per esempio, le spinte verso la disarticolazione del sistema Stato nazione, provocate dalla globalizzazione e della guerra civile del 1991, costituiscono un contesto storico-sociale molto diverso da quello in cui si sono formate le grandi nazioni Europee. La separazione dei poteri è un elemento costitutivo della forma nazionale che si è venuta a determinare via via con un lunghissimo percorso in tutta Europa mentre in Somalia, a causa del conflitto non ancora definitivamente conclusosi, potrebbe rivelarsi meno chiaro oppure assumere una forma alquanto “anomala”. In un mio articolo, “Cambio d’abito”, ho cercato di dare un mio punto di vista sul ruolo delle donne somale in questo contesto confuso:
“In assenza dello Stato e in presenza della violenza dei signori della guerra, nel bel mezzo del caos, le donne in Somalia hanno desiderato la “legge”, la sharia. Quando è stata stracciata la “somalitudine”, quel tessuto reale e metaforico che teneva tutta la popolazione insieme, a mio avviso, le donne hanno interposto questo nuovo vestito tra il loro corpo e la violenza. Allo stesso tempo, hanno trovato nella religione un nuovo contenitore identitario comune, che andasse al di là delle divisioni claniche.”[5]
E’ chiaro che la questione religiosa è centrale, non solo per tenere uniti i somali come popolo, cioè come Nazione, ma anche in quella che dovrebbe essere l’ottica di uno Stato che riesca a essere democratico. Qui si pone la questione della democrazia in quanto garante della sicurezza di tutti i cittadini e quindi anche delle donne. Solamente la tutela dello stato di diritto può evitare che le donne siano alla mercé degli abusi delle milizie. E i somali, come altri popoli, stanno percorrendo itinerari a mio avviso inediti e non escludo, anzi me lo auguro, che in modi a loro specifici arrivino a costituirsi nazione democratica, senza essere copia delle grandi nazioni europee. Bisogna esplorare strade poco trafficate per raggiungere in breve tempo un obiettivo così difficile.
Domanda 3
A proposito dell’identità: che cosa pensa di quel controverso filone di studi (i.e. Homi K. Bhabha, in The Location of Culture del 1994 uses concepts such as mimicry, interstice, hybridity, and liminality to argue that cultural production is always most productive where it is most ambivalent ), in cui si parla dei processi culturali di ibridazione nei quali colonizzati e colonizzatori sono coinvolti in processi talora anche fertili? Eventualmente potrebbe fare degli esempi?
Provo a iniziare con un esempio tratto da un mio racconto pubblicato in una raccolta dal titolo eloquente, Fra-intendimenti. Il racconto inizia così:
“Ore quattro di notte, per il mondo in generale, oppure le dieci sempre di notte per chi ha l’onore di essere mogadisciano. Succede quello che succede normalmente nelle case dove abita almeno un somalo: suona il telefono. […]
Mi gratto gli occhi, guardo l’orologio, dico: “Che ore sono?” poi fra me e me: “Oh Dio! Sono le dieci di notte!”
Mr. F. interviene con la voce rilassata di chi l’ha sempre vinta. Mi ha corretto dicendo: “Le quattro, le quattro”.
In Somalia, una ragazza del clan Hawiye avrebbe detto le dieci, una ragazza Daarood avrebbe detto le quattro (proprio come si usa qui in Italia). Essendo io una Daarood cresciuta in mezzo agli Hawiye posso dare entrambe le versioni; cosí lo assecondo ripetendo: “Le quattro, le quattro”.[6]
Dunque questo personaggio, una donna somala che si è trasferita in Italia per ricominciare, ha una doppia “referenzialità” per misurare il tempo. Poi con l’andare avanti del racconto, la protagonista si dimentica di spostare l’ora e si stupisce di trovare la banca ancora chiusa, e dunque qui con il cambio di tempo europeo aumento la complessità e quindi la referenzialità spazio temporale della nostra protagonista non è soltanto binaria come ci insegna Bhabha ma tripla: due somale e una italiana.
Questi sono per me elementi di complessità che nei miei racconti solitamente oppongo agli stereotipi semplificanti in cui vengono proiettati nelle società d’arrivo gli immigrati; stereotipi che oltretutto affondano spesso le loro radici nel colonialismo. Ma sono anche un modo per condividere l’esistenza della possibilità che immigrati provenienti dagli stessi luoghi di partenza possano avere diversi referenti spazio temporali e anche il fatto che in un soggetto convivano tre referenzialità del tempo dove l’acquisizione di una non implica la cancellazione di un’altra. L’acquisizione del sapere non è a somma zero. Ma quando i personaggi non provengono dagli stessi luoghi? Infatti in un altro racconto in cui sono coinvolti tre soggetti – un interprete, un funzionario e una anziana richiedente asilo – la situazione è ancora diversa. Nonostante voglia inserirsi nella società che la ospiterà con uguali diritti e doveri, l’anziana difende a spada tratta i suoi referenti, non solo culturali ma anche di abitudini comportamentali, e per tutto il racconto non molla di un centimetro. Dall’altra parte il funzionario si attiene alla linea rigida dei suoi referenti spazio temporali in quanto veste il ruolo di responsabile della gestione dell’ufficio. Questa chiusura da parte di entrambi sembra rendere superflua la presenza dell’interprete che nel racconto non è solo un traduttore ma rappresenta anche il terzo spazio dove confluiscono tutte le ambivalenze. Raccontare una situazione del genere, come autrice, mi dà modo di esporre ai miei lettori uno dei tanti conflitti, in questo caso quello tra uguaglianza e differenza che emerge già all’arrivo degli immigrati. In quanto richiedente asilo l’anziana deve essere trattata secondo il criterio universale di Uguaglianza ma dall’altra parte, come esponente di una cultura specifica, vuole il e ha diritto al rispetto della sua differenza, non è disponibile ad assimilarsi:
“La dinamica del ‘gioco’: il signor D. (il funzionario) fa delle domande, io traduco e trasmetto alla signora che poi risponderà, e io tradurrò per il signor D.
Tutti e due cominciano a parlare contemporaneamente con me. La giornata inizia bene!
Chiedo al funzionario se non gli dispiace che io ascolti la signora. Un po’ scocciato, mi dà il permesso. Dopo una breve presentazione, i colloqui iniziano sempre con le sue domande, è lui il primo attore su questo palcoscenico.
La signora: Figliola, chi è quest’uomo? Tuo marito?
Io: No.
Il funzionario: Cosa sta dicendo?
Io: Vuole sapere chi siamo.
Il funzionario: Le dica che le domande le faccio io. Quanti anni ha la signora?
Dalle mie parti bisogna salutare a lungo gli anziani e solo loro all’inizio possono fare le domande. La mia signora non è una che fa concessioni. Infatti: “Se non è tuo marito, cosa ci fai in questa stanza con lui?”[7]
Il racconto continua così lungo tutta la storia in cui i due interlocutori principali non si incontreranno mai. Però come autrice, attraverso elementi strutturali del mio modo di scrivere, gioco un’ulteriore partita, oltre il piano espositivo della complessità e dell’introduzione dei lettori alla diversità culturali di cui parlavo, sulla stessa struttura narrativa che attraverso l’interlocuzione diretta, esitazioni, domande, commenti meta-narrativi, dubbi, rompe rigidi confini identitari e vuole stimolare i lettori ad agire per la costruzione di un mondo, una casa, dove la disponibilità all’ascolto è una condizione necessaria per essere inclusi.
Domanda 4
Utilizzando il concetto, caro a noi psicoanalisti, di Nachträglichkeit, che cosa potremmo pensare del post-colonialismo? Dove questo ‘post-’ rimanda a un dopo, a un evento successivo che però implica un prima che ‘non era (ancora) accaduto’? J. André potrebbe aver ragione quando osserva che “L’après-coup è un trauma, e se non è semplice ripetizione è perché contiene elementi di significazione che aprono, a condizione d’incontrare un ascolto e un’interpretazione, su una trasformazione del passato”? Se crede che tale questione possa avere un senso per ‘pensare’ il post-colonialismo, quali sarebbero in termini politici e geografici a suo parere l’ascolto e l’interpretazione necessari?
Il post colonialismo ovviamente non ha la stessa valenza per i colonizzati e i colonizzatori. Per questi ultimi, almeno per la maggior parte, il passato è vissuto come colpa, un insieme di azioni che ora non hanno giustificazione ma che allora non trovavano ostacoli se non in poche nicchie di opinione pubblica e/o per aspetti particolarmente esecrabili (per esempio la tratta degli schiavi).
Per me, che dovrei appartenere ai postcoloniali ossia ex colonizzati, in realtà questa prospettiva è spiazzante perché non mi appartiene, se non di riflesso. Io infatti appartengo alla generazione dell’indipendenza la cui prospettiva principale era il futuro. Per noi il trauma del colonialismo, come offesa e non come colpa, era alleviato soprattutto dalla prospettiva del futuro, che in una fase coincise con il “radioso futuro socialista”. Fu una formidabile operazione culturale che si confrontava sì sul passato più recente, quello coloniale, ma che contemporaneamente recuperava quello precedente o contemporaneo al colonialismo, rivalutando modi di convivenza, culture e tradizioni che costituivano la nostra storia. Un modo di riguardare le proprie origini per vedere in modo nuovo il futuro.
Così da ragazzina nel mio libro di geografia, Dhig e Lool, i rami che costituiscono lo scheletro della capanna dei nomadi, prendevano i nomi di meridiani e paralleli della terra (in fondo la terra è casa nostra). Così anche nei testi di storia, l’eroe per eccellenza non appariva, come avrebbero voluto gli inglesi (l’impero), Mad Mullah il pazzo fanatico, ma come Sayid Mohamed Abdille Hassan. Mohamed Abdille Hassan giganteggiava anche in letteratura, in quanto uno dei più importanti poeti del ‘900 somalo. Poesie che erano sì, pura arma di propaganda contro gli invasori colonialisti, oltre a uno strumento per capire il perché delle sue battaglie, ma anche un modo per conoscere la vastità, la ricchezza e la bellezza della lingua somala.
Si dovevano studiare le sue poesie ma una in particolare dovevamo saperla a memoria: quella sulla battaglia di Dhul Madoobe. La poesia è dedicata ai Darwiish, uomini della sua armata caduti prima della vittoria contro gli inglesi guidati dall’ufficiale Richard Conyngham Corfield, rimasto ucciso nella battaglia. In questa occasione Sayid compone una poesia che è un autentico rapporto dettagliato sulla vittoria e in cui delega all’ufficiale inglese “il compito” di informare i gloriosi Darwiish che riposano nell’al di là.
Mentre si costruiva un passato per progettare un futuro, il colonialismo naturalmente era presente ovunque, persino fisicamente: in negativo, ad esempio, nelle città, negli edifici dei colonizzatori, in positivo nelle statue degli eroi dell’indipendenza come quella di Sayid. La statua di Sayid – il maestro, la guida, bastava dire “il Sayid” che tutti, nessuno escluso, anche quelli a cui aveva saccheggiato e ammazzato gli avi, pensavano a lui – troneggiava là, nel “nuovo” centro della città, per restituire dignità e onore e indicare i valori da cui partire per un risorgimento. E poi c’è stata la caduta, preceduta dell’altra caduta, la dittatura, che le ha spianato la strada. C’è stata una caduta, un bagno di sangue guidato da signori della guerra che, per scacciare la dittatura, hanno dato inizio a una guerra civile, che come un’alluvione ha, tra le altre cose, spazzato via anche la Storia Condivisa. Ebbene: nel 1991, all’inizio della guerra, una massa di civili, “la ggente”, si è avventata sulla statua del Sayid, l’ha ridotta a ferraglia e venduta al primo stron..! Per queste persone evidentemente l’anticolonialismo e, per contro, il colonialismo, non aveva nessun significato o almeno non prioritario.
Le attuali prove di ricomposizione del nuovo e fragile Stato federale sono assai incerte: basti pensare alla disputa in corso tra il governo centrale e le regioni, che costringe a navigare a vista l’intero Paese. In mezzo alle tempeste claniche e ai notabili loro alleati, rispunta la statua del Sayid nello stesso posto che era rimasto vuoto in tutti questi anni! Cosa vuol dire? Trent’anni di violenza e di guerra civile come sono riusciti a riempire quel vuoto? In che modo la violenza costante e quotidiana ha riscritto i nostri racconti e quello che siamo diventati?
È chiaro che queste domande hanno bisogno di attenzione, ascolto, alla luce di tutto ciò che è successo dopo l’indipendenza.
Così, piuttosto che post coloniale mi definirei una donna post- indipendenza, curiosa nell’ascolto e disponibile alle interpretazioni, ma soprattutto in cerca di una bussola.
Domanda 5
“Per il fatto che si occupano in prevalenza della complessa questione dell’alterità, gli studi (post)coloniali incrociano spesso quelli femministi, soprattutto nel terreno di convergenza delle problematiche razziali e di genere. Si parla in questi studi della doppia subalternità della donna: che ne pensa?”
Ho scritto e scrivo di subalternità perché credo sia una questione sociale e politica importante che non si può non tenere in considerazione. Nei miei racconti ci sono dei personaggi femminili che sono nella condizione di subire varie tipologie di subalternità, non solo doppia ma anche tripla, multipla: di reddito, di status, di etnia, di colore della pelle, per dirne solo alcune. Inoltre non è raro che gravino tutte insieme sulle spalle di una sola donna. Ci sono momenti della mia scrittura, restando sempre al tema della subalternità, in cui mi pongo il problema di offrire scenari alternativi, quelli in cui elementi considerati simbolo della subalternità della donna, presenti nei luoghi comuni delle società di arrivo, non risultano affatto tali per le stesse, cosiddette, donne subalterne: anzi, sembra che siano elementi che le completino, che forniscano loro dignità:
“Aisha ha cambiato stile d’abbigliamento: adesso porta l’hijab. Fa parte di una grande comunità di Londra, quella musulmana. Appena arrivata a Londra, ad Aisha stava stretto essere soltanto una povera vedova profuga con sei figli. Ha preferito aggiungere tra le altre cose che le appartenevano, qualcosa che le desse dignità e forza. Con un tocco di velo e un bel vestito lungo e nero è entrata dalla porta principale nell’ummah. Ora è una lady musulmana con un passaporto forte.”[8]
Il personaggio di Aisha rappresenta una donna somala che, come molte altre, è scappata da un conflitto e, arrivata in Inghilterra, acquisisce il passaporto britannico. Ma affinché l’appartenenza alla comunità britannica sia piena vuole l’inclusione di elementi fondamentali della propria identità, tra i quali quella religiosa è sicuramente molto rilevante. La sua “differenza” che invoca riconoscimento si manifesta in un capo d’abbigliamento dal grande significato simbolico: l’hijab. Vestirsi con questo velo è appunto un “manifesto” della propria sfida alla subalternità.
Cerco di tematizzare la subalternità nella sua complessità e perciò mi piace metterne in luce la varietà. Non solo. Trovo importante evidenziare anche coloro che stanno dall’altro lato della relazione che costituisce la subalternità, i non subordinati.
“Il nero cioè nessun colore. Apparentemente chiunque può pensare di dare sul nero una pennellata del colore che vuole. Il camionista mi dà una pennellata color prostituta. Qualche femminista illuminista, una di quelle che vogliono liberare le donne che secondo loro sono assolutamente povere, mi aveva dipinto come una ragazza soggiogata dagli uomini delle mie parti che, ovviamente, aveva bisogno urgente del suo aiuto. Non eravamo amiche. Il suo aiuto era dettato da mie esigenze impellenti, supposte da lei. Non c’era modo di collaborare con lei. Voleva a tutti i costi discutere di quanto gli uomini, dalle mie parti, fossero mostruosi. Io avevo bisogno di un’alleata e mi sono silenziosamente accorta che non era possibile né suonare un piano a quattro mani, né accordarsi sul peso e la priorità da dare ai problemi in un’ipotetica agenda, che poteva avere soltanto i colori del blues. Qualche ragazzo di sinistra, non ancora disilluso, mi aveva dato i colori di chi ha sempre ragione, togliendomi nello stesso tempo tutti i colori di una persona capace di scegliere e di agire liberamente; non mi lasciava il rischio che si corre quando si sceglie: quello di sbagliare.”[9]
Come si vede in questo brano, tratto dal racconto Nonno Y e il colore degli alleati, sono presenti tre personaggi che rappresentano altrettante categorie eterogenee: un camionista, una “qualche femminista illuminista” e qualche “ragazzo di sinistra non ancora disilluso”. Tutti a loro modo cadono nella trappola della generalizzazione. Il personaggio del camionista ha per me la funzione di segnalare la presenza dei fantasmi dovuta alla connotazione erotica e sessuale che la propaganda coloniale attribuì in passato all’Africa, mentre le altre due tipologie, appiattendo le donne sulla sola dimensione di subordinate, non fanno altro che scipparle di tutte le altre identità che le donne nere sono capaci di accogliere in sé. Mentre coloro che restano ciechi davanti alle abilità con cui le donne si muovono nonostante il poco margine di spazio di manovra nei casi di subalternità, affogano nel nulla gli sforzi e le creatività delle donne nere in quei difficili momenti.
In quello che scrivo comunque cerco di non fare di ogni erba un fascio e dunque il fatto che gli immigrati hanno più riferimenti culturali oppure sono in condizione di subalternità non li rende immuni dall’avere pregiudizi; né la totalità dei soggetti che compongono la società d’arrivo i “bianchi”, uomini o donne che siano, hanno queste percezioni generalizzanti.
È importante inoltre prendere le distanze da quei discorsi che, forse per giustificare altre subalternità, in modo pregiudizievole rappresentano tutti gli uomini neri come malvagi. Infatti sempre nel racconto Nonno Y e il colore degli alleati, seguendo la stessa traiettoria della diversificazione, tra maschi neri della stessa cultura, quella somala per esempio, smentisco l’atteggiamento di “superiorità” con cui sono caratterizzati gli uomini delle culture africane: tutti con la stessa mentalità e per di più con una visione patriarcale ottusa. Racconto di uno scontro in cui sono coinvolte tre mentalità patriarcali su una questione delicata come l’accesso o meno alla scuola italiana per le ragazze somale. Da una parte abbiamo un gruppo di “notabili” somali conservatori insieme a un funzionario dell’amministrazione fiduciaria italiana (AFIS- una specie di prolungamento del colonialismo italiano); dall’altra, invece, a favore della scolarizzazione e del diritto allo studio delle ragazze, ci sono il Nonno Y e un suo amico, mossi dal desiderio di ampliare la capacità delle donne nel padroneggiare più mondi, e non certo spinti da un impeto assimilazionista. Entrambi gli uomini sono membri autorevoli della Lega indipendentista somala contro il colonialismo. Chi invece sguazza nell’assimilazione e che inoltre è delatrice e opportunista è Nadia, un personaggio che si trova in un altro racconto che ha come titolo il nome stesso della ragazza[10]. Voglio dire che alle donne (e alle femmine, nel caso delle protagoniste della favola che ho scritto[11]) attribuisco diverse caratteristiche. Possono essere intelligenti, aggressive, buone e cattive e magari tutto insieme. Quello che hanno in comune è un carattere estremamente deciso e anche quando assecondano gli altri, si muovono in modo fortemente autonomo. Esistono perché le vedo e con i miei scritti invito a integrare il loro sguardo a quelli che in diverse misure sono sprovvisti di lenti per vederle. Propongo la complessità e le diversità a cui contrappongo gli stereotipi semplificanti, creati anche (o soprattutto) per giustificare le subalternità.
[1] Eeddo Maryan, 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010, p.56
[2] Lo scontro inizia l’8 febbraio 2021 quando in assenza di una legge elettorale decade l’incarico del Presidente della Repubblica con un Parlamento che aveva già concluso la sua legislatura nel dicembre dell’anno precedente. Il 12 aprile 2021 quando questo stesso parlamento proroga di due anni il mandato presidenziale il conflitto esplode. Il 27 maggio 2021 rientra questa contrapposizione che ha coinvolto varie parti delle Istituzioni dello Stato Federale con un accordo promosso dal Primo Ministro.
[3] La legge 4.5 è una sistema elettorale di rappresentanza che assegna ai cosiddetti quattro “clan maggiori” uguale quota e mezzo punto percentuale a tutti i clan rimanenti. Il 27 maggio 2021 c’è stata qualche variazione di questo sistema ma la centralità del Clan rimane a discapito del sistema “un uomo un voto”. La formula 4.5 si ispira alla proposta per il sistema elettorale somalo del 1955 del AFIS contro il parere del SYL, il Partito che ha portato il paese all’indipendenza. Per ulteriori approfondimenti vedi Mohamed Aden Sheikh, The Trust Territory of Somaliland under Italian administration (AFIS) and the Somali Youth Legue, in Back To Mogadishu, Amazon Publishing,, 2021
[4] Un felice goffo volo allo Yaya Centre, 2020, in Africa e Mediterraneo, n.92-93 (1-2/20), pp.87-91
[5] Cambio d’abito, 2017, in Africa e Mediterraneo, n. 86, (1/17), pp.108-111
[6] Che ore sono? 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010, pp. 67-68.
[7] Uno Scialle afro-arabeggiante, 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010, p. 84
[8] La casa con l’albero: tra il Giusto e il Bene, 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010, p. 54.
[9] Nonno Y e il colore degli alleati, 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010, pp.13-14.
[10] Nadia, 2010, in Fra-intendimenti, Nottetempo, 2010
[11] Dalmar. La disfavola degli elefanti, Unicopli, 2019,
Intervista per l’Eritrea a Mussie Zerai (Padre Mosè), sacerdote.

A cura di Cristiano Rocchi
Cristiano Rocchi:
Noi abbiamo questa “finestra” in Geografie della Psicoanalisi che come sa tenta di tracciare una mappa della psiche basata sulle interconnessioni e interazioni generate da culture anche distanti da quella di provenienza della psicoanalisi trattando temi problematici che trovano diversa espressione nelle varie realtà offrire una panoramica della psicoanalisi e di temi psicoanalitici. Ora, Lei è un uomo di azione possiamo dire, quanto il pensiero pensa sia utile e importante per supportare il fare e favorire eventuali trasformazioni?
Padre Mosé:
Importante, aiuta anche a noi stessi, come africani, a riflettere su noi stessi, su dove siamo, su da dove veniamo, su dove vogliamo andare, che futuro vogliamo anche per la nostra Africa, per i nostri giovani, per il futuro o ciò che è stato finora. Almeno, cosa di quello che è stato finora, cosa preservare e cosa no; che cosa salvare e cosa invece non ci è servito o ci ha danneggiato; oppure ci ha, invece di aiutarci di andare avanti, ci ha trattenuto a rimanere fermi o addirittura ci ha riportato indietro. Quindi per me è utile riflettere su ogni aspetto, da ogni angolatura che è possibile, che ci aiuta. Per me ogni riflessione che arriva, da qualsiasi parte venga o da qualsiasi fronte si vuole affrontare, per me lo trovo un aiuto, un pungolo in più che ti costringe ad alzarti.
Cristiano Rocchi:
Bene, questo è molto interessante e mi fa piacere. Perché sa, a volte si può pensare che ci sia un gap troppo ampio fra il fare certe cose e il pensare attorno e su certe cose. E quindi anch’io mi chiedo qualche volta quanto poi si possa creare un ponte reale e significativo fra il pensiero e l’azione.
Padre Mosé:
Mah, trovo un danno enorme e non solo per noi africani, il fatto che si è puntato soprattutto sul fare e non sul pensare. Perché, se non si continua a sviluppare il pensiero, il fare alla fine si piega su se stesso e si rischia di ripetere anche gli errori che sono stati già fatti. Quindi, invece, se c’è, se continua a svilupparsi il pensiero, da vari punti di vista, su tutti gli aspetti della vita dell’uomo o della donna, il pensiero aiuta poi a sviluppare nuove strade, nuovi orizzonti su cui proiettare poi il fare. Il fare dovrebbe essere la traduzione del pensiero, non il contrario.
Cristiano Rocchi:
Certo, certo. Benissimo. Quindi un modus operandi e cogitandi che si intrecciano.
Padre Mosé:
Eh si.
Cristiano Rocchi:
Una domanda più generale che le pongo è questa: le moderne nazioni postcoloniali somiglierebbero, secondo alcuni studiosi, a una seconda copia della grande nazione europea e in questo modo rappresenterebbero gli spazi più adatti alla realizzazione dei suoi propositi economici, sociali e culturali. Questa è un’affermazione che, per esempio, fa uno studioso come Chatterjee. Ecco, lei che cosa ne pensa? Come interpreterebbe questa affermazione? Quanto la condivide?
Padre Mosé:
Mah, la condivido in gran parte. In gran parte dell’Africa è stato così. I moderni stati che si sono costituiti dopo l’indipendenza, hanno avuto, sì, l’indipendenza fisica ma non l’indipendenza politica, culturale, economica. Tutto il modello è rimasto quello coloniale, cioè quello che è stato impostato dai colonizzatori; anzi, i nuovi governanti o la classe cosiddetta intellettuale di questi Paesi è stata formata o nelle colonie, perché sono venuti in Francia, in Gran Bretagna o altrove, quindi sono formati sul modello europeo. Quindi hanno portato, al loro arrivo, non hanno cercato, come si diceva per i missionari; almeno alcuni Papi dicevano “No, dovete fare l’inculturazione del Vangelo. Non dovete trasportare così com’è il modello latino; dovete inculturarlo nelle…”
Invece non si è fatto così per la parte politica, economica di questi nuovi o finalmente Paesi liberi dal colonialismo. Hanno mantenuto tutta la struttura, sia economica, politica; anzi, si è cercato di scimmiottare, assimilare più possibile, o assomigliare più possibile all’Occidente, all’Europa, dimenticando la base, cioè dimenticando la cultura del proprio popolo, la tradizione del proprio popolo, la mentalità e tutti gli usi e costumi su cui doveva invece essere costruito il nuovo modello economico, politico e educativo anche.
Anche le nostre scuole, il curriculum e tutto, è sul modello europeo. In molti Paesi africani si studia la storia europea, non si studia la storia africana. I ragazzi dei paesi francofoni conoscono tutta la storia francese, ma non la cultura del proprio Paese. In questo senso si è continuato, è un colonialismo in diretta, cioè a telecomando o a distanza, un colonialismo culturale, economico, politico. Sì, non ci sono più fisicamente i governanti o i governatori europei, ma c’è la loro lingua che governa, c’è il loro modello economico che governa, c’è il modello politico che governa.
Cristiano Rocchi:
Ecco, ma allora, fermo restando che senz’altro ciò sia dovuto anche a delle ragioni di ordine economico, se si prova un attimo a approfondire con Lei da un punto di vista che può interessare particolarmente a me, a noi, psicoanalitico, perché secondo Lei questa – chiamiamola così – questa psiche collettiva africana rimane così infiltrata dalla psiche occidentale?
Padre Mosé:
Perché per secoli gli è stato detto, all’africano “Sei emancipato, sei sviluppato, sei… se tu vivi all’occidentale, se ti vesti all’occidentale, se pensi, citi filosofi occidentali o impari a memoria…”. Quindi lo sforzo che ha fatto l’africano, anche nell’essere-io lo vedo nella parte anche religiosa, di essere cattolico, essere anglicano etc. -essere… Se Lei va a vedere in Africa, la domenica vanno a messa, in chiesa, però dopo vanno poi a fare i riti tradizionali. Quindi il fatto di essere in chiesa vestito all’occidentale, è dire “Vedi, anch’io sono arrivato al tuo livello, sono diventato come te, finalmente sono emancipato, sono sviluppato, sono moderno, non sono più arcaico e quant’altro. Però mantengo ancora anche le mie radici, quindi vado a fare i miei riti dei miei antenati”.
Quindi c’è quest’aspetto che rimane, però rimane il fatto che sul piano del pensiero filosofico, ma anche su vari aspetti sul piano culturale, ha preferito cercare o inseguire l’Occidente perché è quello il modello vincente che gli è stato presentato.
Cristiano Rocchi:
Allora, in questo senso, si potrebbe parlare di una sorta di scissione che c’è nell’africano, nella psiche dell’africano, per cui c’è una parte superiore, di superficie che aderisce a un modello a cui tende o a cui è stato costretto a tendere; e sotto una parte che invece rimane più legata a un certo tipo di cultura, di tradizioni che sono millenarie.
Padre Mosé:
Sì, c’è una scissione. Lo vede anche dalla differenza tra chi vive nelle città e chi vive nei villaggi. Per esempio, nelle zone rurali si è conservata di più la tradizione ancestrale. Invece nelle città, come è stato demonizzato per secoli ciò che è stato la cultura africana come arcaica, come… spesso anche gli è stato detto “tutto ciò è diabolico” o quant’altro, tutto ciò che di brutto gli è stato detto, per cui si è fatto sì che si vergogni della propria cultura, della propria tradizione, dei propri usi e costumi. Perciò quindi chi viene in città cerca di liberarsene senza del tutto riuscirci, perché il legame con la famiglia rimane, però chi viene in città cerca di correre o rincorrere il modello occidentale, per dire “sono liberato, sono civilizzato, sono modernizzato, sono… ho fatto progressi, quindi…”
Perché quello che è il modello vincente, che gli è stato presentato e vede “noi siamo civilizzati, siamo venuti addirittura a civilizzarti”, quindi…
Cristiano Rocchi:
A liberarti.
Padre Mosé:
A liberarti, a civilizzarti. Quindi chiunque, è umano, chiunque vuole salire sul carro del vincente, perciò anche l’africano vuole salirci, su questo carro.
Cristiano Rocchi:
Senta, ci sono degli studi che si possono anche considerare, diciamo così, controversi in cui si parla di processi culturali di ibridazione fra colonizzati e colonizzatori che alcuni ritengono anche processi fertili. Secondo Lei questo tipo di considerazione è accettabile? Se lo è, dove, quando, quanto?
Padre Mosé:
Mah, in alcuni Paesi, lo si vede, l’ibridazione non è soltanto culturale ma ormai c’è un meticciato anche di famiglie, quindi anche da lì nasce questa ibridazione culturale. Lo si vede se lei va a Capo Verde, oppure se lei va nelle Isole Mauritius.
Cristiano Rocchi:
A Zanzibar.
Padre Mosé:
Anche, per esempio, sì, in Tanzania, anche in certi… ci sono questi tentativi, diciamo. Tentativi forse non studiati a tavolino, ma sono venuti creandosi piano piano con matrimoni misti, con la convivenza, a volte forzata, a volte volontaria. Per esempio con gli indiani, che sono arrivati come soldati inglesi, che poi si sono impiantati lì, ormai sono parte integrante della società. Quindi hanno portato la loro religione, la loro cultura e oggi, se lei va nelle Mauritius, ma anche, come ha citato, a Zanzibar, sono parte integrante della società. Per esempio trovi il marito tanzaniano, comunque di origine africana, con moglie di origine indiana. Nella stessa famiglia c’è l’Induismo insieme al Cattolicesimo o il Protestantesimo o Anglicanesimo che convivono. E da lì poi nasce anche il modo di vivere, di pensare, di rapportarsi nella società, tutto nuovo. Non è né pienamente africano né pienamente indiano … Quindi questa è la cultura ibrida che esce fuori poi da questo contesto.
Cristiano Rocchi:
Ora Le pongo una domanda più vicina alle concettualizzazioni psicoanalitiche. C’è un concetto (molto caro a noi psicoanalisti), in tedesco nominato Nachträglichkeit , in inglese deferred action, in francese après-coup. Si tratta di un concetto che sostanzialmente si riferisce a un tipo di processo che potremmo chiamare il ritorno postumo o l’azione retroattiva; cerco di spiegarlo in modo molto semplice, forse un pochino riduttivo: accade un evento traumatico, poi c’è un periodo di latenza di questo evento, come se non fosse mai accaduto… che non fosse stato riconosciuto. Poi successivamente ne accade un altro, a distanza anche di anni, che rimette in moto (azione retroattiva), rimette in moto ciò che era accaduto a livello psichico. E si può parlare di psiche individuale come di psiche collettiva.
Allora, noi abbiamo pensato a questo concetto, quindi a un post che rimanda a un evento successivo… cioè, questo post, che rimanda a un effetto successivo, abbiamo provato a pensarlo anche in relazione proprio alle dinamiche postcolonialiste. Le faccio una citazione. Uno psicoanalista francese – i francesi si sono occupati, dopo Freud, molto di questo concetto, e l’hanno tradotto con après-coup – J. André dice “L’après-coup è un trauma e se non è semplice ripetizione, è perché contiene elementi di significazione che aprono, a condizione di incontrare un ascolto e un’interpretazione, su una trasformazione del passato. Aprono a una trasformazione del passato”. Allora, descritto sommariamente il significato di questo concetto, Le chiedo: può avere, secondo lei, un’utilità utilizzare questo concetto per pensare il postcolonialismo? Cioè, anche in termini politici, geografici, economici, come potrebbero essere l’ascolto e le dinamiche di ciò che avviene, della fenomenologia presente osservabile nelle varie regioni che sono state colonizzate, alla luce di questo concetto? Cioè, come potremmo utilizzarlo eventualmente?
Padre Mosé:
Eh, bisognerebbe analizzare, Paese per Paese come si sta vivendo. Bisognerebbe analizzare Paese per Paese. Perché poi la situazione africana oggi è talmente diversificata per tutta una serie di situazioni, politiche, economiche e quant’altro. Però, per esempio, io lo vedo il caso del Ghana. Il Ghana oggi è un Paese che sta cercando di togliersi di dosso tutte le varie “catene” possibili che lo legano come ex colonia, con il Paese che l’ha colonizzato. Quindi sta cercando di riaffermarsi la sua piena indipendenza, sia economica, culturale; sta incentivando molto, soprattutto sul piano culturale e di pensiero, di sviluppo, il recupero della propria storia, della propria tradizione, proiettandolo verso il futuro. Quindi il Ghana potrebbe essere uno di questi Paesi da studiare, su come sta vivendo tutto questo.
Cristiano Rocchi:
Una sorta di laboratorio quindi, secondo lei?
Padre Mosé:
Sì, per me sì. È un laboratorio che sta chiamando anche diversi altri, per esempio il richiamo che sta continuamente facendo degli afroamericani, di tornare a contribuire a questo recupero, recupero di storia, cultura, usi e costumi dell’Africa nera, ancora (non solo) del colonialismo, ancora prima del tempo del mercato degli schiavi. Quindi sta cercando di tornare più indietro di tre/quattrocento anni per recuperare sul piano storico-culturale e però cercando di adattarlo all’oggi. Quindi da una parte dare la piena confidenza a se stesso all’africano che, prima del colonialismo, non era una tabula rasa, ma aveva una cultura, una tradizione, una storia. Così come si racconta dei vari regnanti occidentali europei, c’erano re e regine dell’Africa, dell’Africa nera, che erano anche potenti, ricchi, che hanno fatto la storia. Quindi con tanti scrittori, sceneggiatori, registi, il Ghana sta cercando di recuperare tutto questo.
Per me il Ghana è un esempio forte, però dall’altra parte ci sono altri Paesi invece che sembrano più andare verso una regressione; ciò è forse dovuto anche a una situazione di disgregazione politico-culturale che li sta dilaniando al loro interno, quindi fanno fatica a elaborare o a fare dei passi in avanti.
Guarda la Somalia, guarda, beh, quasi tutto il Corno d’Africa: oggi è in situazione di pantano; o che si chiude, come l’Eritrea, che si chiude su se stessa e vede l’Occidente come nemico assoluto quindi… o comunque lo guarda con sospetto. Quindi cerca di isolarsi senza fare passi in avanti né sul piano di pensiero né sul piano economico né su altri piani… è un congelarsi che non aiuta né il Paese né la gente.
Un Paese come la Somalia invece è dilaniato da tutta la situazione economica, anche se ci sono all’interno piccoli segni di cambiamento. Per esempio nella Somaliland si osserva adesso un timido tentativo di sviluppo, da tutti i punti di vista, sia economico-politico. Mentre si stanno perdendo le aspettative che erano presenti prima rispetto al Sudafrica; il Sudafrica, che doveva essere il laboratorio per eccellenza di tutto questo, purtroppo negli ultimi anni sembra un po’ andarsi paralizzando. Perché quello sarebbe stato il terreno ideale, dopo la riconciliazione e tutto il lavoro che è stato fatto con Mandela, per superare le divisioni. È lì che il trauma che è stato vissuto, sia del colonialismo, sia dell’apartheid, avrebbe dovuto portare a un modello nuovo o quello che si diceva prima, ad una cultura ibrida, nuova, che si crea da un amalgamarsi fra gli africani e i bianchi che ormai erano parte integrante della società; la crisi economica che ha frenato ogni tentativo di unità nazionale, di creare un’unità culturale; negli ultimi anni anzi la tensione interna si è scaricata attraverso attacchi ai nuovi migranti che sono arrivati, che sono stati massacrati. Alcuni sostengono che tutta l’economia è detenuta ancora nelle mani dei bianchi, quindi di fatto non c’è l’apartheid politica ma c’è l’apartheid economica.
Tutto questo non ha aiutato il Sudafrica di oggi a fare quei passi necessari ad elaborare i traumi del passato e non gli hanno fatto fare quel passo in avanti che anche Mandela sperava, auspicava. Il processo di riconciliazione, di cui è stato fautore, lui sperava che portasse a questa nuova pagina di convivenza e ad una cultura ibrida sudafricana, cosa invece a oggi ancora non realizzata.
Cristiano Rocchi:
Anche se capisco sia difficile rispondere, a questo punto le chiedo come, diciamo “a parità di trauma” com’è che ci sono delle aree in cui le risposte sono… contengono (forse) una maggiore elaborazione del trauma stesso e altre aree in cui invece questo sembra non avvenire? Per esempio, facendo un raffronto fra il Ghana – lo citava lei come paese in cui sembra che l’elaborazione del trauma in qualche modo stia forse riuscendo e dove quindi si osserva anche la capacità, per esempio, di andare a recuperare certi valori del lontano passato- e il Corno d’Africa.
Padre Mosé:
È dovuto all’instabilità politica. Il Ghana, per la sua fortuna, ha avuto una certa stabilità politica in questi ultimi 40 anni, ha avuto una stabilità politica che gli ha permesso di poter almeno iniziare ad elaborare la sua storia. Il Corno d’Africa è passato continuamente dalla padella alla brace, da una dittatura all’altra, da un conflitto all’altro e quindi molta della classe intellettuale del Corno d’Africa o è morta in guerra o è morta in prigione oppure è scappata e vive all’estero quindi… Vedi l’Etiopia, … cinque anni occupata dall’Italia, perché è durata dal ’35 al ’40-’41, la vera occupazione dell’Etiopia. Ed è quella che è stata meno traumatizzata, quella che ha mantenuto maggiore contatto con la propria storia, la propria tradizione; però ha avuto tanti altri traumi da guerre e dittature che si sono susseguiti. Questo ha sottratto tanta di quella energia mentale, fisica, economica, che non ha permesso all’Etiopia di riflettere su se stessa ed emanciparsi. La Somalia è stata per anni sotto una dittatura che non ha pensato a investire sul piano culturale o sul piano di recupero, di emancipare il pensiero o quant’altro; ha pensato di più a fare guerre. Quando tu mandi in guerra i tuoi giovani, che sono coloro su cui investire e che possono favorire lo sviluppo sia sul piano economico che culturale, paralizzi ogni tentativo di crescita e di cambiamento. Siad Barre non ha fatto altro che guerre, con l’Etiopia e con altri vicini. Ha vissuto 17 anni, ma 17 anni in guerra.
Cristiano Rocchi:
Senta, Padre Mosè, Le pongo questa ultima domanda: seguendo un po’ quel filone che è denominato antropologia inversa, che diversi autori africani hanno praticato già dagli anni Trenta, le chiedevo: che tipo di sguardo possono portare le Afriche sull’Europa?
Padre Mosé:
Allora, diversi scrittori africani oggi stanno uscendo da quel tentativo di cercare il capro espiatorio per le cose che non vanno in Africa, quindi cercando la colpa solo all’esterno… ovvio, c’è una colpa per un determinato periodo, coloniale e quant’altro, però per fortuna ci sono oggi diversi scrittori, intellettuali, che stanno cercando di aiutare l’Africa a uscire dal colonialismo. Stanno aiutando a guardare se stessi, a guardare oggi e a guardare la propria classe dirigente, la propria capacità di capire la situazione dove si vive, come si vive, quindi anche il proprio ruolo attivo in questo contesto di oggi, non piangere solo su quello che è successo 60 anni fa o 70 anni fa.
Ci sono oggi scrittori, intellettuali, registi, perfino comici che si distinguono per svolgere questa operazione. Per esempio, io seguo alcuni giovani attori teatrali che stanno contribuendo in questo senso a far prendere coscienza all’africano di chi è, cosa vuole essere e dove vuole andare. Quindi lo stanno pungolando, dicendo: “Tu sei responsabile oggi di quello che ti sta succedendo, di quello che stai vivendo. Non piangere soltanto sul passato, ma guarda chi ti sta governando oggi, da dove viene, come è arrivato, che contributo hai dato tu perché lui oggi sia in quel posto”.
Ci sono per fortuna dei giovani intellettuali che stanno cercando di superare quella che è stata la fase di colpevolizzare l’uomo bianco che ha occupato, che ha sottratto, che ha sfruttato… Stanno cercando di recuperare anche partendo dalla tradizione. Alcuni dicono: va beh, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni come affrontavano i problemi? Come risolvevano i conflitti? Come…? Quindi tornando anche alle radici; per esempio di come i loro avi, seduti intorno a un albero, risolvevano i loro conflitti di terreno, di bestiame, di matrimoni, di economia e quindi propongono: recuperiamo quello che facevano i nostri nonni; quindi la capacità di dialogo, la capacità di giustizia, di come veniva amministrata la giustizia; non in tribunale ma dall’assemblea del villaggio; come venivano aiutate le vedove? come venivano aiutati gli orfani? Dal villaggio. Prima dell’arrivo dell’uomo bianco, che ha costruito gli orfanotrofi o altro genere di strutture lontane dal contesto africano. Recuperando quella storia, quelle storie, quel modo di fare, trasportandolo all’oggi, stanno dicendo, questi giovani intellettuali: guardate che anche noi avevamo il nostro modo di fare giustizia, anche noi avevamo il nostro modo di risolvere i conflitti ed avevamo una grande capacità di dialogo, di ascolto. Quindi recuperiamo tutto questo. Facciamo, trasportandolo all’oggi, rispondere ai problemi che abbiamo oggi.
Cristiano Rocchi:
Sì, che in termini psicoanalitici sarebbe un po’ un tentativo di elaborazione del trauma.
Padre Mosé:
Ok. Sì, sì, è una elaborazione del trauma, perché è quel trauma che ha interrotto quello che poteva essere lo sviluppo naturale di quelle usanze, di quella cultura, di quel modo di fare che piano piano avrebbe potuto portare alle leggi scritte, alle leggi. Invece purtroppo sono rimasti quasi solo oralmente trasmessi, dai nonni ai nipoti, ai figli, è rimasto poco di scritto, quindi anche le leggi. Per esempio l’Etiopia aveva il Fetha Nagast – che è stato tradotto in molte lingue – che è stato per secoli come la Legge, come la Costituzione dei vari re che si sono succeduti sul trono di Etiopia fino agli anni Sessanta. Per fortuna questo è scritto; è partito con pochi articoli, però mano mano ogni regnante che si è succeduto aggiungeva qualcosa. Quindi alla fine è diventato un tomo abbastanza consistente, molto inclusivo, che affrontava tutti gli aspetti della vita, della società, dalla religione ai matrimoni
Cristiano Rocchi:
Si parla di quale epoca?
Padre Mosé:
Se non mi sbaglio, parte dal 1400. Ed era rimasto valido fino all’ultimo imperatore, Haile Selassié, è decaduto poi negli anni Settanta, nel 1974. Il testo è stato tradotto, lo trova anche in inglese.
Cristiano Rocchi:
E concerneva anche la dimensione religiosa, mi ha detto lei.
Padre Mosé:
Sì, sì. Sia l’aspetto religioso, sia l’aspetto sociale, sia quello politico. Anzi, è nato come legge religiosa inizialmente, perché all’epoca il re era anche sacerdote.
Cristiano Rocchi:
Ma di che religione si trattava?
Padre Mosé:
Cristiana ortodossa.
Cristiano Rocchi:
Molto bene, Padre Mosè, La ringrazio tantissimo per la Sua disponibilità e spero ci potremo incontrare presto di nuovo qui e magari anche dal vivo.
Padre Mosé:
Grazie a Lei ed a voi.
La sequenza coloniale: un oblio monumentale.

Conversazione con Rino Bianchi. A cura di Livio Boni
Livio Boni: Mi permetta di prendere le cose un po’ alla lontana. Osservando le sue fotografie sulle tracce urbane della storia coloniale a Roma (una parte delle quali è inclusa in Roma negata. Percorsi postcoloniali per la città, Ediesse, 2014, libro concepito in collaborazione con Igiaba Scego) si ricava la netta impressione che abbiate voluto mettere in evidenza una certa invisibilizzazione della memoria monumentale della storia coloniale nello spazio urbano romano. Per un lettore di Freud è difficile non pensare ad un’immagine famosa, che l’iniziatore della psicoanalisi propone nel Disagio della civiltà. In quest’occasione, Freud, che era un grande appassionato della Città Eterna, paragona Roma allo spazio psichico, in cui nulla si cancella, tutto lascia una traccia, e di cui, al contempo, è impossibile farsi una rappresentazione globale. Le cito il passo di Freud:
Ora facciamo l’ipotesi fantastica che Roma non sia un abitato umano, ma un’entità psichica dal passato similmente lungo e ricco, in cui dunque niente di quel che una volta è esistito è andato perduto, in cui accanto all’ultima fase di sviluppo continuino ad esistere anche quelle anteriori. Per Roma ciò significherebbe pertanto che sul Palatino i palazzi imperiali e il septizonium di Settimio Severo si ergerebbero ancora nella loro antica imponenza, che Castel Sant’Angelo avrebbe ancora sulle sue merlature le belle statue di cui fu adorno fino all’assedio dei Goti e così via. Ma non basta: al posto del palazzo Caffarelli si ergerebbe di nuovo, senza bisogno di demolire questo edificio, il tempio di Giove Capitolino, e non soltanto nella sua ultima forma, come lo videro i Romani dell’epoca imperiale, ma anche nel suo aspetto più antico, quando si presentava ancora in forme etrusche ed era ornato di antefisse fittili. Dove adesso sorge il Colosseo, potremmo anche ammirare la Domus aurea di Nerone, ora scomparsa; sulla piazza del Pantheon troveremmo non solo il Pantheon odierno, quale ci fu lasciato da Adriano, ma, sullo stesso suolo, anche la costruzione originaria di Menenio Agrippa; anzi, sullo stesso terreno sorgerebbe anche la chiesa di Santa Maria sopra Minerva e l’antico tempio sul quale è stata costruita. E allora basterebbe forse che l’osservatore cambiasse la direzione del suo sguardo o il suo punto di vista, per evocare l’una o l’altra veduta.
Personalmente, quest’immagine di Roma come città virtualmente presente in tutte le proprie stratificazioni storiche mi ha sempre intrigato e sembrato parzialmente enigmatica(nota1). Certo, Freud preciserà immediatamente che si tratta in qualche modo di un miraggio, o di un esperimento mentale, poiché, di fatto, elementi architettonici afferenti ad epoche diverse non possono consistere nel medesimo spazio, e che la città, come la psiche, vive in realtà di cancellazioni, e non di conservazione, anche quando, come Roma, conserva traccia di ogni elemento anteriore. Insomma l’analogia tra città e psiche ha i suoi limiti, aggiunge Freud…. Allora, per seguire questa traccia freudiana, potremmo dire che la Roma coloniale fa parte delle stratificazioni storiche suscettibili di essere riattivate? Oppure, al contrario, come lascia intendere Roma negata, la memoria coloniale della Capitale si trova in qualche modo imprigionata in una certa invisibilizzazione, e in una sua dissimulazione dietro altre stratificazioni storiche – l’antichità romana, l’architettura «fascista», ecc. – che la rendono indiscernibile, favorendone la rimozione? E che cosa evoca l’immagine freudiana di Roma come archivio-psichico ai suoi occhi?
Rino Bianchi:Certamente la memoria coloniale della Capitale è imprigionata, chiusa, coperta, celata, nascosta tra le stratificazioni, ed è a mio avviso una scelta non casuale. Del resto relegare le tracce coloniali in questi luoghi è stato un modo per negare quello che è stata l’esperienza coloniale italiana. Una esperienza tristissima, violenta e di sopraffazione, che ha mirato ad annientare la cultura dei popoli con cui è venuta a contatto. Esistono testimonianze di una memoria per immagini pubblica composta di più aspetti: cartoline fotografiche ed illustrate, foto dei giornali, vignette satiriche; esistono, poi, anche album privati formati da ritagli di giornali in cui viene fatta una collazione, ad uso privato, di immagini pubbliche. Nelle foto appare, la fauna del luogo, a dimostrazione che ci trova in un altro mondo, in un paese ancora selvaggio popolato di animali, e farsi fotografare vicino ad un leopardo ammaestrato era prova di coraggio da mostrare fieramente ad amici e parenti. L’Africa “non ancora civilizzata” e misteriosa era anche pericolosa e gli ufficiali o le persone più alfabetizzate si erano formati su romanzi di avventura, resoconti di esploratori, e quotidiani dove questo tipo di esotismi era molto presente. Anche se tra il periodo liberale e quello fascista vi sono alcune differenze, uno dei miti, duro a morire ancor oggi, è quello della sensualità e disponibilità della donna africana. In Africa la donna diviene, anche nelle foto, l’icona di questa sensualità primitiva. Venivano spedite ad amici e parenti le foto di ragazze, il più delle volte giovanissime, nude o seminude.
Del resto anche la scuola post-fascista ha trattato marginalmente l’esperienza coloniale italiana. Non c’è stata una pubblicistica, a parte quella di una ristretta cerchia di studiosi, che raccontasse ai giovani, ragazze, ragazzi la storia del colonialismo italiano in Africa e di come quella triste pagina, nascosta e negata, abbia finito per avere ripercussioni nella nostra società, alimentando in modo costante una certa forma di razzismo. È mancata quella narrazione con finalità sociale che raccontasse in modo semplice questa parte di storia. Insisto su questa lettura perché accanto ai monumenti coloniali, esiste un filone narrativo, divulgativo, convincente e rassicurante che mira a giustificare il colonialismo come azione necessaria. Non dimentichiamo che le colonie nel nostro paese venivano raccontate in modo diverso da quello che erano. Accanto alle cronache di giornali e periodici, si sviluppò una narrativa evocativa e soprattutto vennero creati e commercializzati prodotti che dovevano rassicurare e convincere. Il torrone “africano” “Zanzibar”, la tintura per calzature “Nero Abissino”, i biscotti “Tripolini” “Zulù” “Negretti”, la pasta “Abissine”. Prodotti della quotidianità che hanno contribuito a creare, stratificare e consolidare un certo immaginario collettivo che è contenuto nel concetto esplicato da Angelo Del Boca: “Italiani brava gente?”. Insomma i luoghi coloniali di Roma e non solo, andrebbero spiegati, raccontati, dovrebbero essere meta di lezioni scolastiche.
LB: Uno dei problemi dell’iscrizione plastica della storia coloniale italiana nello spazio urbano romano (ma non solo romano) mi pare quello di essere assorbita in un immaginario antichista e imperiale che la rende pressoché indiscernibile.

Penso al caso della stele di Dogali, ora situata dinanzi alle terme di Diocleziano, nei pressi della Stazione Termini (IMMAGINE 1) Come distinguerla, a occhio nudo, per così dire, da uno dei tanti obelischi antichi disseminati per la città? Detto in altri termini, come restituire una visibilità e una leggibilità alla monumentalità coloniale? Come distinguerla, per esempio, dal culto moderno dell’antico, su cui si sono costituite tante città italiane, dal Rinascimento fino all’epoca fascista, passando per il neoclassicismo settecentesco o il romanticismo delle rovine dell’Ottocento?
A me pare che, a differenza dell’odonomastica coloniale(nota2), che è ben reperibile e isolabile, il problema delle tracce monumentali della vicenda coloniale italiana sia quello di essere affogate dentro un immaginario transtorico, che le integra a sé, e che questa indiscernibilità di fondo traspaia anche nel Suo lavoro fotografico. Qual è il suo punto di vista di fotografo?
In che modo la fotografia può contribuire a rendere visibile ciò che abbiamo sotto gli occhi, e che tuttavia non riusciamo a distinguere?
RB: E’ una mia convinzione che i monumenti, come tutte le tracce del passato e quindi le stratificazioni vadano raccontate ed analizzate, raccontate, partecipate. Se ponessimo ad un campione di 100 persone questa domanda: “Perché si chiama Piazza dei Cinquecento?” sono certo che non più del dieci per cento degli intervistati saprebbe dare una risposta esaustiva. Questo dimostra la lacuna conoscitiva che persiste su questo periodo storico. La Stele di Dogali, è il monumento dedicato ai 500 militari italiani, in realtà 435, caduti il 26 gennaio 1887 a Dogali, nei pressi di Massaua, nella battaglia che li vide opposti ai soldati etiopi di Ras Alula. In origine, nel 1887, era stato collocato dinanzi alla Stazione Termini, fu spostato nell’attuale sede nel 1925 e, nel 1937 poi vi fu aggiuto il Leone di Giuda. Certamente la posizione originaria lo rendeva molto visibile e posto tra l’altro in un luogo “crocevia”. Il fatto è che i monumenti andrebbero spiegati, raccontare la Stele di Dogali è un viaggio nella storia, che parte dal Regno d’Italia, attraversa il fascismo ed arriva agli anni del dopoguerra e della Prima Repubblica. È importante conoscere la storia del colonialismo, perché le migrazioni di oggi seguono le linee coloniali del passato. A proposito della fotografia, come medium comunicativo ed artistico si è imposto tra le masse con la diffusione della pellicola formato rullo negli anni ’80 dell’ottocento, grazie a questa soluzione tecnica, divenne presto lo strumento principale per la rappresentazione della realtà, ovvero sostituì la pittura nel registrare gli avvenimenti più importanti e memorabili; ha rimpiazzata la pittura come strumento di costruzione della cultura visuale anche perché è un mezzo di rappresentazione della realtà molto più potente, fedele, economico e veloce (con la fotografia digitale tutto è ingigantito e moltiplicato). Comunque la fotografia, anche se ha una stretta connessione con la realtà dobbiamo riconoscere che non è ”realtà fedele”, basta considerare, la rilevanza di elementi come l’impostazione compositiva dell’immagine, la definizione del soggetto, la profondità di campo, ladeformazione prospettica, l’eventuale ricorso ad effetti, questo per dire che la fotografia erroneamente è considerata portatrice di verità. Per rendersi conto del massiccio utilizzo del medium fotografico da parte del fascismo basta analizzare il lavoro del fotografo Pedrini che ancor oggi rappresenta la maggior parte della documentazione fotografica disponibile sulla Somalia italiana, tanto che venne utilizzata per decenni anche dopo la sua morte. All’epoca venivano “stampate in media 1000 copie 13×18” (per ogni soggetto) al mese, e venivano inviate a riviste e giornali, ai Ministeri, istituzioni ed enti e utilizzate per le pubblicazioni a carattere coloniale riguardanti la Somalia. Molte sue immagini sono diventate la parte illustrativa dei testi scolastici utilizzati negli anni Trenta, Quaranta e oltre. Nel lavoro realizzato per Roma negata ho cercato di ribaltare tutti quegli stereotipi che avevano contribuito a creare le fotografie coloniali, sempre pensando che la fotografia più che dare risposte deve porre interrogativi.

LB: Il monumento coloniale più noto, legato alla storia coloniale italiana, è indubbiamente la Stele di Axum (IMMAGINE 2), un obelisco in pietra basaltica trafugato dalle truppe italiane in Etiopia nel 1935, e esposto a Roma, a Piazza di Porta Capena, nell’ottobre del 1937, dinanzi all’allora Ministero delle Colonie (oggi sede della FAO) per celebrare il primo anno dell’Impero.

Dopo mille controversie, l’obelisco fu restituito all’Etiopia all’inizio degli anni Duemila, e rimane oggi solo il vuoto lasciato dalla sua rimozione (IMMAGINE 3). Qual è il suo sguardo su questa vacanza della memoria coloniale. Mentre in diversi paesi d’Europa è in corso, oramai da decenni, la ricerca sugli anti-monumenti (gegendenkmal)(nota3), cioè sulla possibilità di iscrivere nello spazio pubblico la memoria di un evento traumatico senza tuttavia monumentalizzarlo (si pensi ai « monumenti interrati » legati alla memoria della Shoah, come la Fontana di Aschrott a Kassel ; o al vuoto perenizzato sul ground zero a New York dal Memoriale dell’11 Settembre), nulla di questo genere è stato realizzato a Roma, per esempio, per rammentare la storia del doppio trasferimento della Stele di Axum. Come se bastasse restituire il maltolto, senza elaborare in alcun modo il processo in questione. Resta allora solo il vuoto iscritto nello spazio urbano, che rischia di divenire in tal modo la semplice metafora di un vuoto nella memoria collettiva.
Che cosa ne pensa?
RB: Al posto della Stele di Axum, durante la consiliatura Alemanno, sono state sistemate due colonne provenienti dalla fontana della Curia Innocenziana che era Piazza di Montecitorio. Le colonne vogliono rappresentare le Torri gemelle di New York, e sono l’omaggio alle vittime dell’11 settembre. Ai piedi delle colonne su una targa di alluminio anodizzato la frase momorabile del filosofo Santayana, che visse e morì a Roma: “Coloro che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo”. Leggendo i fatti della Stele di Axum mi trovo a constatare la volontà ad occultare la memoria coloniale.
LB: Un altro tratto specifico della memoria patrimoniale del colonialismo italiano è l’assenza di una statuaria militare o celebrativa legata all’impresa coloniale. A differenza di quanto si osserva per le nazioni imperialistiche moderne, come l’Inghilterra e la Francia, non esiste una statuaria celebrativa di tal sorta in Italia. Mentre in Francia si discute accesamente della legittimità di mantenere questo tipo di monumentalità – si pensi alla decapitazione recente della statua dell’imperatrice Giuseppina a Fort-de-France, nelle Antille francesi; o alle polemiche sui monumenti al generale Bugeaud, autore di massacri di massa in Algeria alla fine del XIX° secolo, per restare al caso francese- la storia coloniale italiana sembra essere stata troppo breve per iscrivere una traccia statuaria durevole, e troppo compromessa con il fascismo per essere inserita nella narrazione nazionale.(nota4)


In tal senso le fotografie da Lei scelte per Roma negata, nelle quali sono associati luoghi legati alla storia coloniale e ritratti di personalità africane o italo-africane, sia pubbliche che anonime, (IMMAGINI 4 e 5), mi sembrano svolgere un ruolo analogo alla contro-monumentalità di cui parlavo poc’anzi, di una contro-statuaria da cui traspare quasi l’idea che i veri protagonisti della storia coloniale italiana non siano altro che gli eredi viventi della decolonizzazione. E l’idea che il modo più efficace di ridare una visibilità pubblica alla storia rimossa del colonialismo non possa non passare, in un modo o in un altro, per un’inclusione, e persino per una celebrazione, del suo lascito vivente, umano e di colore, sullo sfondo marmoreo delle architetture romane dell’epoca.
Condivide questa lettura del suo lavoro?
RB: Concordo con questa lettura. Il lavoro fotografico di Roma negata è un concetto assimilabile all’idea di contro-monumentalità, ho voluto portare avanti la visione, il concetto di riappropriazione da parte dei figli dei colonizzati dei luoghi coloniali e colonialisti. Il ritratto di Amin Nour in Piazza dei Cinquecento, davanti alla Stazione Termini, crocevia di culture, fiero, su un piedistallo, una statua vivente che si riprende il luogo.
Parigi-Roma, giugno 2022
Note
1 Cfr. Livio Boni, Guillaume Sibertin Blanc, La Ville inconsciente, Paris, Hermann 2018.
2 Sull’odonomastica coloniale, vedasi la mappatura e le azioni di «guerriglia » simbolica proposta dai Wu Ming sur loro blog : https://www.wumingfoundation.com/giap/
3 Per una panoramica sugli anti-monumenti, cfr. Pietro Conte (dir.), Une présence absente. Figures de l’image mémorielle, Paris, Mimesis France, 2013.
4 In questo senso la vicenda della statua in bronzo di Indro Montanelli, inaugurata a Milano nel 2006 e recentemente oggetto di campagne denunciatorie e di imbrattamenti con vernice rossa, è sintomatico : da una parte, in effetti, si gli si rimprovera il « matrimonio coloniale » con la giovane eritrea Destà, da lui mai abiurato ; dall’altro l’episodio traduce l’esigenza di trattare la questione dell’impensato del razzismo coloniale attraverso la messa in causa di figure riconosciute e « rispettabili » della storia italiana del XX° secolo, senza confinarlo ad un episodio marginale o ad una deriva propria al fascismo.
Quel che resta dell’Impero se ne ‘disordiniamo’ l’assetto stabilito.
Foto di Rino Bianchi
Per gentile concessione
A cura di Daniela Scotto di Fasano
A Roma, in un quartiere oggi marginale e degradato, Torpignattara, in Via dell’Acqua bullicante 121, fu durante il fascismo, costruito il Cinema Impero, “simile per struttura e per nome al gioiello di art decò la cui facciata fu progettata da Marco Messina nel 1937 e che si trovava proprio a Asmara, in Eritrea, Africa Orientale”, scrive Igiaba Scego in Roma Negata. Percorsi postcoloniali nella città (Bianchi, Scego, 2020, p.32).
Che continua: “Anche nel nome quel cinema era violento. L’Impero era quello che Benito Mussolini sognava per aver prestigio davanti alle altre potenze europee […]. L’impero era quello che era riapparso «sui colli fatali di Roma.»” (ibidem).
Insomma, il cinema (o, meglio, quel che ne resta, come vedremo) era, nelle intenzioni del duce, uno dei simboli del mito tragicamente megalomane costato migliaia di vite umane del nostro colonialismo.

Oggi, l’albergo Impero può farsi – nel nostro lavoro di ricognizione dello spazio urbano alla luce delle tracce che vi restano della monumentalità dell’Impero, documentate dalle foto di Rino Bianchi, – metafora di un mito ‘albergato’ e privo di radici per – per fortuna – durare.
Un impero, quello coloniale italiano, nato ‘in albergo’, un albergo che comunque lo ha evocato e ne ha parlato, in modo subliminale, a chi ogni giorno vi passava davanti.
Infatti, il nostro colonialismo ha mostrato al mondo di quale pasta fosse fatto il sogno di Benito Mussolini, una pasta destinata a cadere in rovina, una pasta destinata a non lievitare, a non durare.
In albergo, infatti, si transita, non si mettono radici, si va via.
E l’impero di Mussolini era nato in un albergo, era privo di radici.
Ancora metaforicamente, ciò che restava del cinema Impero lo testimoniava: chiuso nel 1983, e di anno in anno, fino a oggi, solo degrado. Pier Paolo Pasolini lo citava in Ragazzi di vita, un Pier Paolo Pasolini evocato negli anni del degrado da un murale:

“[…] il cinema Impero degradato e solo ha la capacità di illuminare la storia e i suoi recessi segreti. La sua vista rimanda all’Eritrea e a quel legame disconosciuto (Scego, 2020, p.38), come mostra orgogliosamente Ruth Gebresus, fotografata da Rino Bianchi a testimoniare il legame tra Africa e Italia, “Un legame violento, cattivo, sporco e non certo piacevole” (ibidem):

Le ultime foto mostrano che fine ha fatto, finora, il sogno di Mussolini:
un sogno senza casa,

destinato a rientrare nei suoi stessi residui bui,

dove sedie vuote testimoniano che fine ha fatto l’incubo coloniale italiano….

Ma, come la psicoanalisi insegna, è dotazione umana la possibilità di cambiamento, di trasformazione. La genialità di Freud fu quella di scoprire che le isteriche soffrivano di ricordi, con ciò sganciando l’esistenza dalla coartazione del destino e restituendo senso al residuo, fondando, in tal modo, una scienza riflessiva: “In questo forse è essenziale la funzione di una scienza ‘riflessiva’ che possa liberarci dalla predeterminazione contenuta nell’idea di un destino già segnato e immutabile, e ci aiuti a trovare sempre nuovi modi per rinnovare l’interrogazione.” (Preta 1993, XXXIII).
Nell’ambito della ricerca inesauribile, tipica di ogni percorso psicoanalitico, di trovare sempre nuovi modi per rinnovare l’interrogazione, ancora una volta il cinema Impero può farsi metafora, in Italia come in Eritrea, a Roma quanto a Asmara, della possibilità di “liberarci dalla predeterminazione contenuta nell’idea di un destino già segnato e immutabile” (ibidem). Infatti, “l’invenzione narra anche della realtà, e ridistribuisce i diversi elementi, e dà corpo alle fantasie, e le colloca in un campo più complesso, e più ampio dove varie rielaborazioni dell’evento sono rese possibili. Una trasformazione poetica e cognitiva. […] Questo tipo di trasformazioni […] sono delle modalità operative, che nascono direttamente dal contesto e prendono forma come risultato di un incrocio di eventi, di incontri tra diverse individualità, di trasformazioni del campo. Per questo costituiscono un salto immaginativo, ma ancorato al materiale che effettivamente è a disposizione” (Preta 1993, XXXII)
Possiamo cogliere l’evidenza di quanto “Il senso stesso diventa contingente” (Preta 1993, XXXII) nel fatto che a Roma, come ha sottolineato Livio Boni, l’ex cinema Impero ospita attualmente una scuola di teatro, per cui, al di là della damnatio memoriae di cui giustamente Rino Bianchi e Igiaba Scego danno testimonianza in Roma negata, il cinema Impero è stato anche al centro, in questi ultimi anni, di un tentativo di recupero da parte di un comitato di quartiere e di un cantiere partecipativo, diventando uno dei tanti esempi di tentativi di difesa e di autogestione della cultura nei quartieri popolari a Roma; è stato infatti in parte restaurato e dovrebbe trasformarsi in Casa della Cultura.
Non sappiamo, ovviamente, se la genealogia coloniale del cinema sia entrata in linea di mira del Comitato, ma resta, agli occhi di noi psicoanalisti, oggetto di grande interesse il fatto che la trasformazione di un relitto della grandeur fascista in oggetto di rivendicazione culturale sia avvenuta ‘dal basso’! In effetti, come nota Livio Boni (2022), “il mondo è «grande, terribile e complicato», ha ragione Gramsci”… e infatti, prosegue Boni, anche questo aspetto sarebbe interessante da esplorare, così come lo è riflettere sulla patrimonializzazione del suo edificio gemello a Asmara.
Da psicoanalisti, potremmo andare più a fondo con le nostre riflessioni sulle opposte evoluzioni subìte dai due cinema gemelli, l’uno, con l’intera città di Asmara che lo ospita, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, l’altro nel corso degli anni in stato di abbandono e degrado.
Infatti, tali opposte evoluzioni potrebbero suggerire che, se in Italia si è voluta ‘punire’ l’intenzione megalomanica di Mussolini riducendone l’espressione – il cinema Impero – ad un’allegoria patetica del colonialismo tardivo, crudele e improvvisato del fascismo, in Eritrea i segni del colonialismo, che hanno fatto di Asmara ‘la piccola Roma’, e le hanno dato accesso al Patrimonio Unesco, hanno in quel contesto valore di riscatto e, soprattutto di rivincita.
Un bel riscatto, in ogni caso, che sia a Roma che a Asmara la cultura sia, al momento attuale, la valenza (metaforica e non solo) dei due cinema, a testimonianza della forza della psiche umana, capace di ‘disordinare’ l’assetto stabilito (Preta, 1993, IX), tesa a sganciare l’esistenza dalla coartazione del destino, a restituire senso al residuo, nel solco della scienza riflessiva fondata da Freud.
Bibliografia
Bianchi R. Scego I., 2020, Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città, EDIESSE edizioni, Roma.
Boni L., 2022, comunicazione personale
Preta L., 1993, Le strategie della conoscenza, in Preta L., 1993, a cura di, La passione del conoscere, Laterza, Roma-Bari.
“Roma negata” di R. Bianchi e I. Scego. Recensione di D. Scotto di Fasano
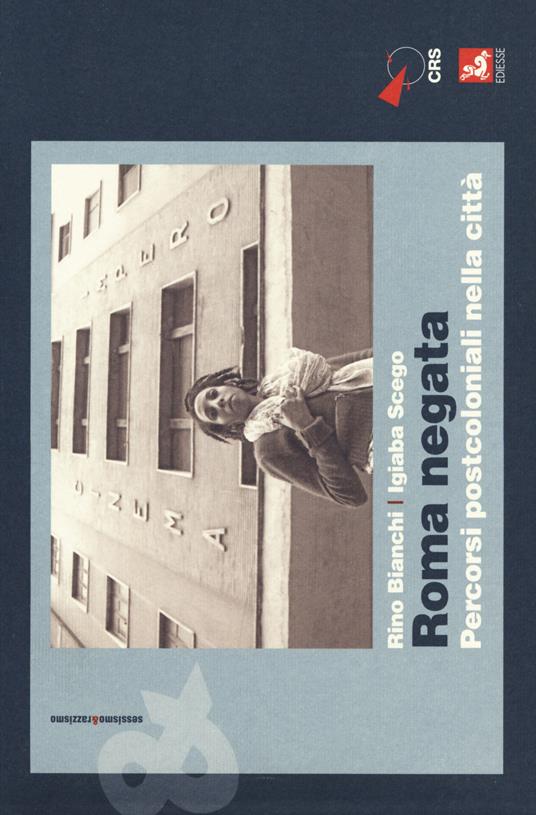
Roma negata. Percorsi postcoloniali nella città, EDIESSE, 2020, pp.157
Rino Bianchi | Igiaba Scego
Recensione a cura di Daniela Scotto di Fasano
Igiaba Scego, autrice di molti romanzi e libri di saggistica, è una scrittrice italo-somala.
Rino Bianchi, fotografo e fotogiornalista professionista dal 1990, ha sposato una donna turca.
Come loro stessi dichiarano (p.134), questi sono i due dati biografici che hanno mosso i due Autori a dar vita, con parole e fotografie, a Roma negata.
Leggiamo: “Io, Igiaba Scego, sono originaria del Corno d’Africa e avevo la necessità di spiegare i rapporti tesi fra i miei due mondi. Lo sguardo di Tztà o di Sofia Mahmoud sono anche il mio sguardo. Sono anche il mio orgoglio. […] Le foto di Rino Bianchi sono molto diverse da quelle che avrebbe potuto fare un suo collega di inizio Novecento. Entrambi maschi bianchi, entrambi europei, entrambi pronti a violare l’intimità con un aggeggio che, come si dice spesso in Africa, ti ruba l’anima. Ma mentre ad inizio secolo l’« altro» veniva fotografato per essere catalogato, etichettato, ridicolizzato, nelle foto di Rino non troverete nulla di tutto questo. Lui, marito di una donna turca, ha compiuto nella sua vita un percorso di decolonizzazione che lo ha portato a vedere il mondo come un insieme di uguali nella differenza” (pp.134-135).
Il pensiero di chi scrive corre a un altro fotografo, il soldato ebreo Ettore Navarra, descritto da Maaza Mengiste in Il re Ombra (Einaudi, 2019), che ha l’obbligo di documentare con la fotografia gli atti di incredibile violenza, sempre insensata e gratuita, che l’esercito italiano compiva nel corso della colonizzazione del Corno d’Africa. A Ettore Navarra era affidato l’incarico di dare atto del potere di Roma fascista. La dittatura infatti alimentava anche mediante tali documentazioni fotografiche la propria immagine, che doveva risultare straordinariamente forte e potente.
Della stessa natura degli ordini impartiti al soldato ebreo Ettore Navarra i monumenti inneggianti al Fascio e al suo potere descritti da Igiaba Scego e Rino Bianchi, come documentano i titoli dei capitoli: Inizio a camminare…, L’impero che non ti aspetti, Le cinquecento Afriche di un capolinea romano, L’obelisco della discordia, Memoria coloniale: lo strano ritorno, Affile: una vergogna nazionale.
Come scrive nella Presentazione Nadia Terranova, “I luoghi di cui il nostro sguardo si riappropria smettono di essere strade neutre […] e vanno a comporre un paesaggio vivo che ci racconta la storia recente che abbiamo rimosso” (p.9).
Ecco, potremmo dire, adottando il vertice, psicoanalitico, che l’operazione condotta da Igiaba Scego e Rino Bianchi è quello di ‘interpretare’, per così dire, il testo delle ‘libere associazioni’ rappresentate dai ‘segni’ che caratterizzano il contesto urbano preso in esame: Roma.
Una Roma vecchia, che in Somalia chiamerebbero Ajuza (p.13), in cui il viaggio di Igiaba prende il via da Piazza di Porta Capena.
Qui, un tempo, era locata la stele di Axum; oggi, invece, un cipresso (l’albero di Ade, non a caso, nota l’Autrice) e delle targhe, alle quali due colonne fanno da siparietto.
Su una targa, una frase: “Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo”, del filosofo spagnolo-americano George Santayana, sull’altra, un’altra scritta: “In ricordo delle vittime della strage di New York e Washington dell’11 settembre 2001.La citta di Roma per la pace contro ogni forma di terrorismo”.
Ecco! Le due colonne metafora delle Twin Towers! Quanti a Roma lo sapranno? “Nessuno forse a Roma lo sa… Nessuno.” (p.15). Ma, continua Igiaba, “Percepivo un’assenza… una grande assenza… […] era la mia Africa che mancava all’appello. La mia Africa che in quel luogo era stata trucidata. […] lì mancava un’altra targa (anche piccola) dedicata alle vittime del colonialismo italiano. Lì un tempo […] c’era stata la stele di Axum. Un obelisco che l’Italia fascista si era portata come bottino di guerra dall’Etiopia. […] Pensai in un lampo alle vittime dell’irite in Etiopia […] Pelli nere rese bianche da una morte vigliacca, […] con gas che la convenzione di Ginevra aveva vietato. […] E lì, proprio dove ora c’era il cipresso, l’Italia aveva celebrato il trionfo di quella barbarie. […] Ora la stele sta ad Axum, insieme alle sue sorelle etiopi. Ma a Piazza di Porta Capena cos’è rimasto di quel passaggio? […] L’11 Settembre era perfetto per dimenticare” (pp. 16-19).
Come psicoanalista, oltre a condividere – sulla scia del concetto dei ricordi di copertura (Freud 1899, volume 2) – il fatto che l’11 Settembre fosse perfetto per dimenticare (a dispetto del fatto che “Quelli che non sanno ricordare il passato sono condannati a ripeterlo”), non posso non pensare che sia il “patto di memoria tra Roma e New York” (p.16) sia la frase di Santayana possano essere considerati una ‘reazione controfobica’, un capovolgimento, una trasformazione nel contrario: a mostrare innanzitutto a se stessi e, inoltre, al mondo, che si hanno ‘le mani pulite’. La Roma Ajuza ha le mani pulite: “Piazza di Porta Capena è in fondo un esempio di questa incapacità dell’Italia di prendersi le sue responsabilità, di fare un vero patto di memoria” (p.22). “Ieri i colonizzati, oggi i migranti, vittime di un sistema che si autogenera e autoassolve” (p.25).
E poi: L’impero che non ti aspetti è il cinema Impero a Tor Pignattara, Via dell’Acqua bullicante 121, “simile per struttura e per nome al gioiello di art decò la cui facciata fu progettata da Marco Messina nel 1937 e che si trovava proprio ad Asmara, Eritrea, Africa orientale” (p.32): a testimoniare il legame tra Africa e Italia. “Un legame violento, cattivo, sporco […] Anche nel nome quel cinema era violento. L’impero era quello che Benito Mussolini sognava” (p.32), un impero da ‘doppia erezione’, come a Mogadiscio si diceva della cattedrale che uno dei quadrumviri della marcia su Roma, De Vecchis, aveva fatto costruire identica a quella di Cefalù, con le sue due torri altissime.
In questo capitolo molti sono i riferimenti toccanti alle terribili vicende della migrazione dei nostri anni, che ha i suoi mille cadaveri sepolti nel mare che unisce Africa ed Europa, il Mediterraneo.
A questo punto, nel libro, intervengono le foto di Rino Bianchi: Tezeta Abraham davanti al Palazzo della Civiltà Italiana, e altri protagonisti delle vicende che uniscono Roma e il Corno d’Africa fotografati a Piazza dei Cinquecento, davanti alla stele di Dogali, in Viale Somalia, all’ex Museo africano (di cui nel libro si parla diffusamente nelle Conclusioni), al cinema Impero.
Non è possibile, per ragioni di spazio, dare conto delle forti suggestioni provocate dalle Immagini di Rino Bianchi, spero di sopperire a tale mancanza nel corso dell’intervista al loro Autore che sarà pubblicata in AfrichE. Tra(N)sformazioni assieme a quelle fin qui rivolte a Kaha Mohamed Aden e a Padre Mussie Zerai (nel libro fotografato davanti ai Fori imperiali).
In Le cinquecento Afriche di un capolinea romano si entra in contatto con l’eccidio di Dogali, una delle più cocenti sconfitte che l’Italia abbia subito in Africa orientale (cinquecento soldati italiani vi furono sterminati dalla resistenza etiope nel 1887), trasformata dalla retorica del tempo in un atto di eroismo portato alle estreme conseguenze.
“Dogali è una sconfitta. […] Una massa informe di errori di strategia, pressapochismo, sottovalutazione dell’avversario, arroganza e distorto pensiero razzista. Un disastro militare che non ha nessuna scusante. Un disastro che doveva essere recepito come tale e aprire nella società italiana una riflessione seria sul colonialismo.” (pp.56-57).
E invece non accadde, nonostante la posizione fortemente critica di intellettuali come Giosuè Carducci, Ulisse Barbieri, Andrea Costa e Gabriele D’Annunzio.
“Manifestazioni di collera riempiono le strade di Roma, dopo che la notizia dell’eccidio di Dogali si è sparsa per il paese.” (p.60). Igiaba Scega ce li descrive nel suo romanzo La linea del colore, facendocene sentire la violenza e la ferocia, che nel romanzo si abbattono sulla protagonista dalla pelle nera.
Come psicoanalista, sottolineo l’importanza di un’osservazione dell’Autrice che può condurci a riflettere sulla paura che l’uomo bianco ha da sempre nutrito nei confronti dell’uomo nero, basti pensare all’uomo nero che turba i sonni dei bambini bianchi. “Pensiamo – scrive Igiaba Scego – all’Amerigo Vespucci di Jan van der Straet, dove l’offerta sessuale è esplicita. La terra-donna è lì pronta a farsi possedere, ma in una scena sullo sfondo c’è l’immagine fugace di alcune donne cannibali. Ed ecco di nuovo quell’antica paura di evirazione reale e metaforica” (p.64).
Mi chiedo se tale fantasia maschile, ancestrale, non pronta ad accogliere il femminile, da un lato, e fantasticato, dall’altro, come ‘cannibale’, non sia interpretabile come la radice del fatto che – non avendo posto per l’altro e quindi per questa ragione temendolo – lo trasforma – agendo in assunto di base attacco-fuga (Bion, 1948) – in oggetto da possedere, colonizzare, depredare.
Per uno strano gioco del destino, Piazza dei Cinquecento oggi è l’ombelico africano di Roma, “è diventata la piazza dei somali, degli eritrei, degli etiopi e anche di tutti gli altri migranti” (p.68): una – possiamo chiederci – piazza rivincita? Una piazza eccidio del colonialismo?
Lì accanto, e nel capitolo successivo, L’obelisco della discordia, la stele di Dogali. L’Autrice ricorda “che la guerra d’Africa fu per Benito Mussolini il momento più alto di consenso per il suo regime dittatoriale” (p.74), che “Fino al 1973 […] i documenti dei somali e delle somale erano scritti in due lingue: arabo e italiano” (p.75), sottolinea il fatto che in molte città eritree e somale l’architettura italiana degli anni venti-trenta è importante oltre che suggestiva e nomi italiani si rincorrono come lepri nei luoghi più belli.
E poi, dice di Axum, città etiope del Tigrè, dove nacque, intorno al quarto secolo a.C., uno dei regni più misteriosi dell’intera Africa, che occupava anche la vallata del Barca e le zone che oggi compongono l’intera Eritrea. Nella piana di Axum colpisce la presenza di giganteschi obelischi: “Quello che fu collocato a Roma, a Piazza di Porta Capena, era alto 24 metri e aveva un peso netto di 150-170 tonnellate” (p. 83).
Mussolini, il 31 ottobre 1937, anniversario della marcia su Roma, ne avrebbe fatto il suo obelisco imperiale. Ma le cose non andarono come Mussolini le aveva sognate, e la stele rimase a Piazza di Porta Capena dimenticata: “la storia in Italia non è mai stata decolonizzata. Il colonialismo fu inghiottito da questo oblio e quelli che furono dei punti di riferimento simbolici del fascismo furono lasciati andare alla deriva come fossero delle zattere fantasma in un fiume di non detto” (p.87).
Finché, il 28 maggio 2002, la stele fu colpita da un fulmine “con violenza inaudita e il marmo si sbriciolò tutto intorno fino quasi a diventare polvere” (p.91).
Con sessant’anni di ritardo, presidente Scalfaro, ne fu decisa finalmente la restituzione all’Etiopia. “Nel luglio del 2002 il Consiglio dei ministri deliberò la restituzione ai legittimi proprietari e nel novembre 2003 avvenne lo smontaggio della stele a Piazza di Porta Capena” (p.93).
Si dovrà però attendere il 2005 perché la stele rientri in patria. Nel frattempo, per dolorosa ironia della sorte, giace coperta da una tela cerata nel cortile della caserma di Polizia di Ponte Galeria. Contesto drammaticamente connesso al Cie, “dove migranti che non hanno commesso nessun reato vengono rinchiusi in galere peggiori delle galere stesse” (p.94-95).
Si chiede l’Autrice: a Piazza di Porta Capena, dove oggi due targhe e due malinconiche colonne suggellano il patto Roma-New York, un’altra targa non poteva ‘dire’ dell’assoluto silenzio calato sul colonialismo italiano e sulle sue vittime?
In Memoria coloniale: lo strano ritorno la riflessione di Igiaba Scego, a partire dal Ponte Amedeo d’Aosta, si concentra sull’“orgoglio di reliquia fascista” (p.100) che esso è chiamato a rappresentare, a partire dal personaggio al quale è dedicato: Amedeo d’Aosta, “il volto gentile e raffinato del fascismo italiano” (p.100), l’eroe dell’Amba Alagi, che di fatto, sebbene senza la rozzezza di Rodolfo Graziani, era con costui “in totale continuità” (p.101).
Anche Roma, come il ponte, esibisce innumerevoli fasci littori, sui tombini, su facciate di palazzi, e a parere dell’Autrice, la nonchalance con cui i segni del fascismo di ieri convivono inosservati con la realtà di oggi ha a che fare con il proposito di non “avere a che fare con le tracce di un passato che non ci piace” (p.101).
Però, “La memoria non è negare quello che è stato, ma rielaborare quella vita passata, contestualizzarla e soprattutto non dimenticarla” (p.101).
Dal vertice psicoanalitico, impossibile non chiamare in causa a proposito di queste affermazioni due concetti, quello di assuefazione all’ovvio di Silvia Amati Sas e quello di Nachträglichkeit, traducibile in italiano con ‘posteriorità’, ‘retroattività’ o ‘azione differita’ (in inglese ‘deferred action’), meglio reso in francese con ‘apres-coup’.
Amati Sas, sulle orme di Josè Bleger, ha studiato il fenomeno da lei detto di Assuefazione all’ovvio, in rapporto al quale, ad esempio, il fatto che paia inevitabile, quasi ‘naturale’, che ogni giorno in Italia almeno tre persone muoiano sul luogo di lavoro. Già nel 1997, Amati Sas scriveva: “tendiamo sempre più a strutturarci nell’ambiguità, tanto che le “personalità ambigue” (Bleger, 1967), conformiste e adattive, possono essere considerate la personalità di base propria della nostra epoca. […] Nell’ambiguità […] tutto appare possibile e interscambiabile: i termini opposti, contraddittori e potenzialmente conflittuali, non sono ancora precisati, né contrastati. Per questa ragione, l’ambiguità dà ai fenomeni psichici un carattere proteiforme di imprecisione, malleabilità e adattabilità. (1997, p. 66)”.
“Condividiamo quanto scrive Silvia Amati Sas (1997): «Il mondo tecnologico di oggi ci offre maggiori possibilità di essere trattati come delle cose anziché come persone, e questo succede al di là della nostra capacità di percepirlo, conoscerlo, pensarlo… Ci affacciamo a un dilemma identitario che (come dice Hanna Arendt) è quello di chiederci se siamo dei chio dei che cosa». Rimandiamo, per un approfondimento, agli scritti dell’Autrice e alle ulteriori riflessioni che ha sviluppato su questi temi, in particolare al fatto di abituarsi difensivamente all’inumano (tortura, stragi, eccidi, olocausti) come rientrasse nella categoria dell’ovvio. E’ una questione importante poiché, come rileva anche Bodei (2001, p. 41), «I disagi non sono maggiori o minori del passato: siamo però diventati più insensibili a essi: il malessere circola clandestinamente, come qualcosa che, spesso, non desideriamo guardare da vicino» (Francesconi, Scotto di Fasano, 2014, p. 17).
Il concetto di Nachträglichkeit, invece, ci immette subitaneamente nel mondo del ‘post’: qual è il ‘post’ riservato anche alle cose che riteniamo negative, che non ci piacciono ma fanno comunque parte di noi? Che possono, se non interrogate ‘a posteriori’, lavorare a nostra insaputa inducendoci a ripetere coattivamente proprio quanto non ci piace. O al quale ci siamo ‘assuefatti’. “Papà mi disse solo: […] Anche se è una cosa negativa, fa parte di te, in qualche modo quella roba sei anche tu. Non ti piace, ma la devi accettare, farci i conti, trasformare magari” (p.102-103).
Tali considerazioni consentono di chiamare in causa un dei concetti chiave di cui, con Livio Boni e Cristiano Rocchi, parliamo nella Introduzione a AfrichE. Tra(N)sformazioni, quello di ‘antropologia inversa’.
Per un’antropologia inversa, Roma negata ci aiuta a chiederci: che sguardo portano le Afriche sull’Europa, e sull’Occidente più in generale? E in che modo un simile cambiamento di punto di vista può contribuire alla nostra auto-rappresentazione? Incoraggiando una certa ‘antropologia inversa’, che diversi autori africani hanno del resto praticato già dagli anni Cinquanta (DADIE’, 1959), Roma negata è la visione africana, o euro-africana, delle ex-metropoli coloniali – Parigi, Londra, Roma o Lisbona (in questo caso, Roma) – e, più in generale, delle città europee che risultano particolarmente ‘impregnate’ della vicenda coloniale. Di conseguenza, esse vengono ‘lette’ come fossero il tramite data l’iscrizione della memoria coloniale nello spazio urbano, artistico-monumentale e toponomastico delle città occidentali (WU MING, 2018).
Infine, in Affile: una vergogna nazionale, l’Autrice evoca una grave macchia per la nostra democrazia, la “costruzione ad Affile del mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani, […] l’uomo che fece uccidere i cantastorie, i poeti, i diaconi dopo l’attentato da lui subito ad Addis Abeba nel 1937. La sua crudeltà era nota. E poi come tutti gli italiani si macchiò della vigliaccheria estrema di usare gas vietati dalla convenzione di Ginevra sulla popolazione etiope inerme. […] E a questo individuo […] Affile ha dedicato un sacrario militare. Il sindaco del luogo, Ercole Viri, ha dirottato fondi pubblici per far costruire quella immensa vergogna” (p.117), “un’oscenità artistica ed etica” (p.121) costata 130 mila euro della Regione Lazio Giunta Polverini.
Molte le suggestioni del libro delle quali si dovrebbe dire e che trascuro per ragioni di spazio: la moglie dodicenne di Indro Montanelli (ma in Africa è un’altra cosa!, dichiarò Montanelli intervistato da Gianni Bisiach nel 1969), gli ascari utilizzati e tristemente obliati – “Si cancella quello che è troppo scomodo” (p.107) – un oblio che suggerirebbe un’ulteriore riflessione nei termini del concetto di Nachträglichkeit…
Ma vado a concludere, invitando alla lettura di Roma negata per approfondire questioni che ci riguardano profondamente, e – quel che è peggio – inconsapevolmente, assuefacendoci a nostra insaputa all’ovvio.
Infatti, nelle Conclusioni, Igiaba Scego scrive che “Questo libro si doveva concludere con una foto […] La foto del balcone di Palazzo Venezia […] avevamo pensato che da quel balcone dovevano affacciarsi richiedenti asilo somali, eritrei, etiopi […] uomini e donne che rivendicavano quel passato in comune con un’Italia sorda e assente […] e un po’ sleale” (p.123). “Volevamo partire dal Corno d’Africa, dall’umiliazione di quel colonialismo crudele e straccione, perché di fatto era in quel passato che si annidava la xenofobia del presente” (p.125).
E, in termini psicoanalitici, la reazione controfobica del luogo comune Italiani brava gente…
“Occupare uno spazio è un grido di esistenza. E’ un modo per dire «ti amo» al futuro. Perché la crisi […] più grave è quella della perdita di orientamento” (p.125). Per questo Roma negata è importante, nel suo sforzo (riuscito) di mappare la città, guardandola oltre l’ovvio dell’evidente (Scotto di Fasano et al., 2007), “come si guarda qualcosa di nuovo e inaspettato.” (p.125).
La bussola che ha orientato il viaggio di Rino Bianchi e Igiaba Scego è il concetto di narrazione tossica che viene dal collettivo Wu Ming, secondo la quale una storia, per essere tossica, dev’essere narrata sempre dallo stesso punto di vista, omettendo gli stessi dettagli, rimuovendo gli stessi elementi di complessità.
“In Somalia tutti i nomadi sanno che il miglior antidoto all’ignoranza, a quella jahilia che ci vuole muti e sordi, è il racconto. […] La storia va raccontata dal punto di vista di chi ha subito […] Solo così le narrazioni tossiche che ci avvelenano la vita ci possono abbandonare” (p.128).
Ma poi, Rino Bianchi e Igiaba Scego hanno abbandonato l’idea di sostituire su quel balcone il fantasma del corpo di Mussolini con questa ‘altra’ Italia mescolata e meticcia; hanno fatto un’altra riflessione: “Non aveva senso riempire di corpi un balcone che non era mai tornato ad essere davvero dei cittadini. Mai tornato ad essere di Roma” (p.126).
Insomma, un libro importante, Roma negata, in cui “Ogni sfumatura è nata da un percorso condiviso” (p.126) dai due autori e offre a chi legge lo stimolo a guardare il mondo anche dalla luna, con stupita meraviglia (Di Chiara, 1990).
Bibliografia
AMATI SAS Silvia, 1997, Sessualità di massa, sessualità privata, in Chiappino F. et al., a cura di, Affettività, Sessualità, Identità, Atti Convegno AIES, 27.9.1997, Trento.
BION W., 1948, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1961
BLEGER Josè, 1967, L’ambiguità nella clinica psicoanalitica, in Simbiosi e ambiguità, Lauretana, Loreto, 1992.
BODEI Remo, 2011, Il dottor Freud e i nervi dell’anima, Donzelli, Roma
DADIÉ Bernard, Un Nègre à Paris, Paris, Présence Africaine, 1959.
DI CHIARA Giuseppe, 1990, La stupita meraviglia, l’autismo e la competenza difensiva, Riv. Psicoanal., 36, 441- 457
FRANCESCONI Marco, SCOTTO DI FASANO Daniela, 2014, a cura di, Il sonno della ragione. Saggi sulla violenza, Liguori, Napoli
FREUD S., 1899, Ricordi di copertura, OSF, Bollati Boringhieri, Torino, 1989
SCEGO Igiaba, L’Africa è un continente, in PIAGGIO Chiara, SCEGO Igiaba, a cura di, Africana. Raccontare il Continente al di là degli stereotipi, Milano, Feltrinelli, 2021
SCOTTO DI FASANO Daniela et al., 2007, Mentalizzare l’esperienza oltre l’ovvio dell’evidente. Ovvero, crescere come professionisti, come genitori, come formatori, (con al.), inCresti L., Nissim S., Percorsi di crescita: dagli occhi alla mente, Borla, Roma, 2007 WU MING (Collettivo), I fantasmi coloniali infestano le nostre città, 2018, consultabile in Rete https://www.wumingfoundation.com/giap/2018/10/viva-menilicchi-4/
